
I lavoratori siciliani (Il presente contributo è stato presentato ad Avola dal Movimento Culturale Ales, durante l'incontro pubblico organizzato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia il 24 aprile 2012. Con l'intento di non dimenticare le vittime del fascismo in Sicilia. Per affrontare il presente e a futura memoria).
|
In questi giorni che intercorrono tra il 25 Aprile e il 1° Maggio una riflessione si impone per tutti i siciliani, in particolare per i contadini e gli agricoltori che abbiamo visto scendere in piazza all'inizio dell'anno.
Per conoscere la storia del movimento contadino in Sicilia occorre partire da lontano, dalla fine dell'Ottocento, quando i braccianti e altre categorie di lavoratori cominciarono a unirsi per far fronte comune contro i latifondisti e i grandi prorietari terrieri, da sempre impegnati a mantenere la loro posizione di privilegio nella società dell'isola perpetrando forme di sfruttamento disumano ormai molto note.
Nel 1885 nascono in Sicilia le prime Società di Mutuo Soccorso, create come strumento per attenuare le sofferenze dei braccianti e degli altri lavoratori impegnati nella lotta contro il latifondo.
Subito dopo, nel 1888, nasce il primo Fascio dei lavoratori, simbolo di quell'esperienza che portò le questioni sociali dell'isola alla ribalta nazionale e che passerà alla storia col nome di Fasci siciliani. L'esperienza del Fasci siciliani non va confusa o affiancata al fascismo (semmai alle esperienze socialiste), in quanto precede di circa quarant'anni la nascita del regime di Mussolini e si basa su ben altri presupposti. L'affinità dei termini potrebbe indurre in errore.
Le rivendicazioni dei Fasci siciliani (sopratutto braccianti, minatori delle zolfare e artigiani) si concretizzano in almeno tre aspetti: riforma del lavoro agricolo, opposizione alla mafia agraria e alle istituzioni conservatrici, collettivizzazione della terra.
Per comprendere la composizione dei Fasci siciliani può essere utile leggere l'art. 6 dello Statuto del Fascio di Trapani che ritiene condizione essenziale, per entrare a far parte dei Fasci, quella di vivere del frutto del proprio lavoro, alle dipendenze di un padrone e non in posizione dominante rispetto ad altri lavoratori (cioè senza avere braccianti alle proprie dipendenze). Un movimento nato dal basso, insomma.
Il governo e la mafia risponderanno duramente alle rivendicazioni dei lavoratori e il 20 Gennaio 1893 si verificherà il massacro forse più violento e sfacciato perpetrato contro i lavoratori siciliani. A Caltavuturo i soldati e i carabinieri spareranno, infatti, cu circa 500 contadini di ritorno da un'occupazione di terre del demanio comunale, provocando 13 morti, numerosi feriti, e aggravando il bilancio con una buona dose di denunce e arresti.
Tra il Dicembre del 1893 e il Gennaio del 1894 si verificheranno i massacri di Serradifalco, Alcamo, Lercara, Giardinello, Pietraperzia, Gibellina, Belmonte, Marineo e Santa Caterina Villarmosa. In totale 92 persone uccise come rappresaglia per l'occupazione delle terre e per le rivendicazioni in materia di lavoro.
Il 1984 sarà l'anno in cui il governo scioglierà forzatamente i Fasci siciliani con arresti di massa e chiusura delle sedi, scatenando un'ondata di emigrazione verso l'estero che diventerà una costante per i lavoratori isolani fino ai giorni nostri. Altri scontri si verificheranno comunque a Siculiana, Troina, Modica, Giarratana, Erice e Grammichele.
Nei primi del '900 il movimento contadino continuerà la propria lotta per l'affittanza collettiva delle terre scontrandosi col fuoco della mafia a Corleone (dove morirà Bernardino Verro), Piana dei Greci e Santo Stefano Quisquina (dove verrà ucciso Lorenzo Panepinto, dirigente dei Fasci e poi del partito socialista). Sarà questo lo scenario nel quale i contadini affronteranno la guerra del '15-'18, con i mafiosi e i latifondisti che si oppongono alle loro rivendicazioni e ordinano, con la forza delle armi, di ammainare le bandiere rosse issate nei campi occupati.
Alla nascita del fascismo, nel marzo del 1919, la situazione del movimento contadino si aggraverà ulteriormente.
Tra il '19 e il '20 i mafiosi sparano a Corleone, Prizzi, Barrafranca, Petralia Soprana e Noto. Le forze dell'ordine sparano a Riesi (15 morti, 50 feriti), Gela (3 morti), Randazzo (9 morti), Centuripe (2 vittime) e Catania, dove i provocatori "nazional-fascisti" attuano azioni di disturbo contro i lavoratori e trovano man forte nella truppa regia che fa 6 morti e 40 feriti.
A Comiso i fascisti accoltellano il presidente della Lega Contadina e la guardia regia uccide 4 persone (di cui una donna e una bambina) per disperdere la successiva manifestazione di protesta. Scontri tra socialisti e nazionalisti si verificano a Modica, mentre a Messina le "camicie nere" assaltano con pugnali e manganelli il congresso regionale socialista.
Quella che si viene a creare è «una forma di reazione all'invasione dei terreni». I latifondisti arruolano individui «per dar vita ad un fascismo agrario pericoloso e capace di tristi conseguenze come il fascismo urbano».
A Palermo e Trapani si hanno esempi di unione tra contadini e operai che lotteranno insieme contro i proprietari delle fabbriche e delle grandi coltivazioni. Nel capoluogo i fascisti pugnalano Giovanni Orcel, segretario della FIOM (il sindacato dei metallurgici), di ispirazione leninista sarà definito "protocomunista e bolscevico" dalla stampa conservatrice. A Trapani sarà ucciso il capolega Giuseppe Monticciuolo.
Le forze reazionarie vengono definite "fascista e nazional-combattentistica" nella Sicilia sud-orientale, "mafiosa e nazional-combattentistica" nella Sicilia occidentale.
Il 1921 proseguirà con altre spedizioni fasciste contro circoli socialisti, camere del lavoro, dirigenti politici e sindacalisti.
A Vittoria, Comiso e Augusta le "immondizie rivoluzionarie", come le definisce il "Giornale dell'Isola" (organo di stampa della destra conservatrice) sono costrette alle dimisisioni dopo azioni squadristiche e intimidatorie, dopo la devastazione del circolo socialista e una sparatoria sui lavoratori a Vittoria da parte dei "combattenti nazional-fascisti" (1 morto e 10 feriti). A Ragusa gli squadristi incendiano la Camera del Lavoro, la sezione socialista e la Lega degli Operai e dei Contadini (4 morti e 60 feriti). A Modica squadre fasciste occupano il comune e costringono gli amministratori alle dimissioni, dopo averne indotto qualcuno, sotto la minaccia delle armi, a baciare la bandiera italiana. Il prefetto plaude a quella che definisce «una perfetta manifestazione di italianità». Ancora a Modica nazionalisti, fascisti e polizia sparano sui lavoratori in assemblea (6 morti, 4 feriti).
Altri contadini vengono uccisi a Scicli, Comiso, Ragusa, San Piero Patti e feriti ad Augusta e Vittoria (dove va in fiamme la sede del partito comunista). A Lentini le forze dell'ordine caricano la folla durante un comizio e uccidono 2 donne. Nei giorni successivi i nazionalisti provocano 4 morti e 50 feriti. A Niscemi i fascisti attaccano gli operai in piazza e riescono ad ucciderne uno.
Il fascismo, insomma, si è saldamente alleato con i mafiosi e i latifondisti e insieme a loro fa blocco unico contro i diritti dei lavoratori.
L'11 Gennaio 1923 tutte le organizzazioni non fasciste saranno chiuse e i militanti mandati al confino o in carcere. Le strutture messe in piedi dal movimento contadino nei lunghi anni di lotta saranno requisite e trasformate in covi e organizzazioni fasciste.
Seguiranno 20 anni di buio totale per i diritti dei lavoratori siciliani e, tra questi, molti di quelli emigrati verso il nord-Italia entreranno nelle fila della Resistenza Partigiana per combattere contro il nemico che avevano già dovuto fronteggiare nella propria terra natìa. Anche la figura del prefetto Mori, più volte ostentata come il tentativo di lotta alla mafia del regime fascista, si rivelerà una coperta corta. Il fascismo combatterà infatti gli strati più bassi e ininfluenti della sfera mafiosa, lasciando intatta l'essenza dell'organizzazione che aveva aiutato proprio i fascisti nelle proprie scorribande degli anni '20 in chiave anticomunista. Il prefetto Mori verrà rimosso dal regime e mandato a godersi i giorni a venire lontano dalla Sicilia.
Il 10 Luglio del 1943, con lo sbarco alleato in Sicilia, il movimento contadino portà rinascere e riorganizzarsi, anche perchè (parole di Palmiro Togliatti) «il popolo siciliano ha sete di libertà e fame di terra». Si danno alle stampe settimanali come "La Voce Socialista", "La Voce Comunista" e "La Voce dell'Isola" e le rivendicazioni degli agricoltori verteranno sopratutto sulla questione dei granai del popolo, della riforna agraria e dell'assegnazione delle terre incolte o malcoltivate.
Il sangue continuerà a scorrere a Regalbuto, Casteldaccia, Comiso e Palermo (tra i 40 e i 50 morti in manifestazioni realizzate anche contro il carovita e la leva obbligatoria).Le azioni di mafiosi e militari contro contadini, comunisti e socialisti si ripeteranno a Vicari, Trabia, Ficarazzi, Cattolica Eraclea, Ventimiglia di Sicilia, Piazza Armerina, Bagheria, Burgio, Favara, Naro, Caccamo, Alia, Santa Ninfa, Corleone, Belmonte Mezzagno, Baucina, Sciacca, Messina, Piana dei Greci e a Palermo (dove i lavoratori dei cantieri navali esigono la rimozione del direttore della fabbrica, un ex-fascista ancora in carica).
Il primo Maggio del 1947 i contadini delle alture che sovrastano Palermo andranno a festeggiare a Portella della Ginestra la vittoria alle elezioni regionali (tenutesi dieci giorni prima) da parte del "Blocco del popolo". Durante il comizio saranno uccisi in 12 (30 i feriti).
Nel dopoguerra la lotta del movimento contadino continuerà e le conquiste in tema di diritti saranno pagate a caro prezzo come ad Avola nel dicembre del 1968.
Quel che risulta evidente dalla lettura della storia di questo movimento è che i contadini siciliani e con loro gli altri lavoratori, avevano e hanno mille buone ragioni per essere, oggi come ieri, partigiani e antifascisti!
|













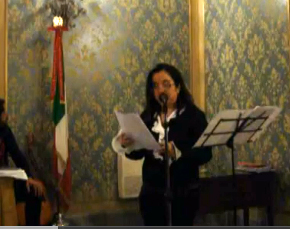
Giuseppina Boccaccio legge
''DOVE VOLA L'AVVOLTOIO''
di Italo Calvino
DOVE VOLA L'AVVOLTOIO
Testo di Italo Calvino
Un giorno nel mondo finita fu l'ultima guerra,
il cupo cannone si tacque e più non sparò,
e privo del tristo suo cibo dall'arida terra,
un branco di neri avvoltoi si levò.
Dove vola l'avvoltoio?
avvoltoio vola via,
vola via dalla terra mia,
che è la terra dell'amor.
L'avvoltoio andò dal fiume
ed il fiume disse: "No,
avvoltoio vola via,
avvoltoio vola via.
Nella limpida corrente
ora scendon carpe e trote
non più i corpi dei soldati
che la fanno insanguinar".
Dove vola l'avvoltoio?
avvoltoio vola via,
vola via dalla terra mia,
che è la terra dell'amor.
L'avvoltoio andò dal bosco
ed il bosco disse: "No
avvoltoio vola via,
avvoltoio vola via.
Tra le foglie in mezzo ai rami
passan sol raggi di sole,
gli scoiattoli e le rane
non più i colpi del fucil".
Dove vola l'avvoltoio?
avvoltoio vola via,
vola via dalla terra mia,
che è la terra dell'amor.
L'avvoltoio andò dall'eco
e anche l'eco disse "No
avvoltoio vola via,
avvoltoio vola via.
Sono canti che io porto
sono i tonfi delle zappe,
girotondi e ninnenanne,
non più il rombo del cannon".
Dove vola l'avvoltoio?
avvoltoio vola via,
vola via dalla terra mia,
che è la terra dell'amor.
L'avvoltoio andò ai tedeschi
e i tedeschi disse: "No
avvoltoio vola via,
avvoltoio vola via.
Non vogliam mangiar più fango,
odio e piombo nelle guerre,
pane e case in terra altrui
non vogliamo più rubar".
Dove vola l'avvoltoio?
avvoltoio vola via,
vola via dalla terra mia,
che è la terra dell'amor.
L'avvoltoio andò alla madre
e la madre disse: "No
avvoltoio vola via,
avvoltoio vola via.
I miei figli li dò solo
a una bella fidanzata
che li porti nel suo letto
non li mando più a ammazzar"
Dove vola l'avvoltoio?
avvoltoio vola via,
vola via dalla terra mia,
che è la terra dell'amor.
L'avvoltoio andò all'uranio
e l'uranio disse: "No,
avvoltoio vola via,
avvoltoio vola via.
La mia forza nucleare
farà andare sulla Luna,
non deflagrerà infuocata
distruggendo le città".
Dove vola l'avvoltoio?
avvoltoio vola via,
vola via dalla terra mia,
che è la terra dell'amor.
Ma chi delle guerre quel giorno aveva il rimpianto
in un luogo deserto a complotto si radunò
e vide nel cielo arrivare girando quel branco
e scendere scendere finché qualcuno gridò:
Dove vola l'avvoltoio?
avvoltoio vola via,
vola via dalla testa mia...
ma il rapace li sbranò.

