Questa che segue e la Premessa di Nello Lupo,
al libro sulla figura e l'opera di don Milani
(luglio 2001, 8°, pagine 208, ill., € 14,46)

Era l’ottobre del 1976, anno particolare, di
quelli che lasciano il segno. Coronavo un bel sogno, raggiungevo l’agognato
posto di lavoro. Un posto ambito: fare l’insegnante, per me che venivo
dall’associazionismo cattolico scautistico, diveniva realtà. Presi
servizio con incarico a tempo indeterminato quale docente di Applicazioni
tecniche alla scuola media statale "Marconi" di Torino.
Quartiere della Torino-bene, come si diceva un tempo.
Ma scoprii, ben presto, di essere stato destinato non al plesso centrale,
bello, accogliente, organizzato, con grandi spazi per l’operatività,
ma alla sua succursale, che si trovava nella vicina collina di Sassi, proprio
sotto Superga, la tomba collettiva del grande e mitico Torino di Valentino
Mazzola.
La scuola era statale, allocata in un collegio di
preti, si chiamava "Città dei Ragazzi". Ospitava, a convitto, fanciulli
che provenivano dalle esperienze più amare che la vita potesse riservare
a un essere umano.
Michele era un ragazzo di 15 anni, alto e robusto,
divenuto completamente calvo in seguito al trauma per la morte violenta del
padre, due anni di ripetenza.
Giuseppe, figlio di separati, minuto, gracile, frequentava
la seconda media. Irrequieto, continuamente in movimento, era affetto, come
si direbbe oggi, da sindrome da iperattività.
Felice, prima media, silenzioso e taciturno, viveva
appartato, ricurvo su sé stesso, era sostanzialmente incapace di relazionarsi
agli altri.
Tre bambini, tre diversi mondi, tre diversi "prodotti"
di quella medesima causa sociale che fu l’emarginazione economica, civile
e culturale susseguente al boom economico degli anni ’60: sradicamento
violento dalla propria terra di origine, deprivazione culturale dei quartieri
dormitorio della periferia torinese.
L’impatto con quella realtà fu duro e
difficile. Non mi restò che chiedere aiuto. Un giovane aspirante insegnante,
alle prime armi, cosa poteva fare se non sottomettersi all’autorità
indiscussa e indiscutibile di una collega di lettere?
Anziana, alla fine della sua carriera scolastica,
discusse con me amorevolmente per ore intere. Non sciolse i miei dubbi, accrebbe,
in me, la consapevolezza delle responsabilità che ci si assume quando
si sceglie di fare l’educatore. Mi consigliò un libro, Lettera
a una professoressa della scuola di Barbiana, mi strinse la mano e mi augurò
"buona fortuna".
Fu così che "conobbi" Don Lorenzo.
Avevo dimestichezza con preti e suore. Ero cresciuto
tranquillamente in mezzo a loro, in un paesino di cultura contadina, nella
quiete di una vita serena, lo scorrere lento del tempo, la gioia dei rapporti
autentici e veri, lontano dai rumori e dalle tensioni della violenza verbale
e materiale dello scontro sociale nella Torino degli anni ’70.
Ero abituato al contatto fisico, faccia a faccia,
con i miei altri significativi: mio padre, mia madre, mia sorella, il parroco
e l’amorevole suora della mia felice infanzia, modelli di socialità
e di educazione religiosa.
Ora il quadro cambiava. Non modelli reali in carne
ed ossa, ma un libro. Da leggere, da interpretare, da calare nella realtà
della quotidianità e rutinarietà di un insegnamento, che fin
dal principio tendevo a interpretare come strumento, mezzo per dare risposte,
non demagogiche ma reali, a quell’infanzia "reietta e abbandonata" che
il Signore mi aveva messo davanti, quasi a ricordarmi che il periodo delle
"castagne" era finito, che cominciava quello ben più importante delle
responsabilità.
Lessi e rilessi, due, tre volte quel libro. Non vi
trovai le regolette pratiche che a quel tempo, erroneamente, cercavo. Vi scoprii
cose ben più importanti, le ragioni del mio impegno professionale:
servire gli ultimi, gli emarginati, gli "ignoranti", quelli che la scuola
rifiutava, bocciava, allontanava, escludeva.
Fu così che il priore entrò prepotentemente
nella mia vita, non solo professionale.
A ventiquattro anni da quell’incontro, don Lorenzo
rimane, ancora oggi, in una società e in una cultura così diverse
da quelle in cui operò, la stella polare, il maestro che guida e orienta,
che alimenta, che rinnova l’amore per la scuola, il difensore dei diritti
inalienabili di ogni bambino.
Ci ha insegnato che la scuola è, e deve essere,
strumento di "mediazione collettiva dell’amore", che il suo fine non
è preparare le classi dirigenti del paese ma colmare il divario tra
le sue finalità formali che sono, lo ricordiamo, dare cittadinanza
e dignità a tutti, nessuno escluso, elevandone istruzione e cultura
e le sue finalità reali.
Don Milani ci ha trasmesso che alla base di ogni
azione che pretenda di essere educativa c’è l’amore per il
bambino, il rispetto della sua dignità di persona, c’è
il coinvolgimento e la "scelta". Ci ha insegnato la libertà, ci ha
dato la consapevolezza che la vera cultura non è quella che si trasmette
ma quella che la coscienza produce.
Don Lorenzo mirava a costruirla questa coscienza,
come prodotto finale di un’educazione che deve mirare all’acquisizione
degli strumenti logico-concettuali che rinforzano abilità che egli
riteneva essenziali come il pensiero critico, ciò che egli chiamava
"ragionare con la propria testa", perché senza queste ogni assenso
di fede è mito, superstizione, formalismo, abitudine.
Ma ragionare con la propria testa non era per il
priore un vuoto tecnicismo, puro esercizio metodologico. E’ invece, l’insieme
di conoscenze, ragione e valori morali, i soli presupposti su cui può
fondarsi una risposta libera e cosciente alla chiamata di fede.
Oggi nasce questo libro. E nasce dal bisogno di esternare
un amore filiale per il maestro che esercitò "la sua paternità
sacerdotale", come felicemente la chiama Liana Fiorani, certamente sui suoi
allievi di ieri, ma la estende, da sempre, ai tanti allievi disseminati nelle
tante barbiane del mondo, educatori cattolici e no, che sentono don Lorenzo
Milani maestro di fede, di riscatto, di libertà e di solidarietà,
esercitare una decisiva influenza sul modo di essere e di vivere l’insegnamento.
Sono passati più di trent’anni dal quel
26 giugno del 1967 in cui il priore di Barbiana, vinto dal suo incurabile
male, lasciò la vita terrena.
La figura e l’eredità di don Lorenzo
sono oggetto, ancora oggi, di accese dispute.
L’odio viscerale della destra per questo prete
che aveva osato sfidare la tradizione è già noto.
La sinistra, che negli anni della sua martoriata
esistenza lo osannò, facendone il simbolo della riscossa dei poveri,
nel trentennio della sua morte ha manifestato un atteggiamento ambivalente:
oscillante tra tentazioni di annessione (la visita del segretario dei D.S.
Walter Veltroni a Barbiana) e rifiuto (si trattava pur sempre di un prete).
La Chiesa, quella stessa che lo mise ai margini,
ora finalmente ne scopre la natura profetica, con tanti singoli pronunciamenti,
fra gli ultimi un articolo sull’Osservatore Romano nel giugno del 1997
e le interviste più recenti su Famiglia Cristiana
Ormai lontani dal clima incandescente della fine
degli anni ’60, caratterizzato dallo scontro ideologico e politico fra
le due culture egemoni, quella cattolica e quella marxista, si può
tentare, oggi, una lettura del pensiero e dell’opera milaniani con maggiore
obiettività.
In quegli anni fu fatta una lettura in chiave essenzialmente
socio-politica che presentò il priore come "il prete rosso", il "contestatore"
"il rivoluzionario" e il suo scritto più famoso, Lettera a una professoressa,
come il "libretto rosso" del ’68 italiano, definizione che dobbiamo all’attuale
ministro alla pubblica istruzione Tullio De Mauro congiuntamente al noto pedagogista
di scuola marxista Lucio Lombardo Radice.
Dalla cultura marxista, priva di una dottrina pedagogica
sistematica ed organica, e per questo molto attenta a cogliere tutte le occasioni
possibili per un’elaborazione dottrinale e teoretica di prassi educative
coerenti con i nuclei tematici di pensiero pedagogico engelsiani e marxiani,
furono messi in evidenza gli aspetti che più si presentavano funzionali
al suo disegno di egemonia sulla società italiana: la denuncia anti-borghese
del sistema di sfruttamento e di oppressione delle classi lavoratrici, la
critica alla funzione di classe svolta dalla scuola, il disvelamento dei meccanismi
di selezione, le istanze pacifiste, il tutto disgiunto dalle motivazioni cristiane
da cui profondamente sgorgavano.
La tesi di questo libro è che quella lettura,
che non a caso misconobbe l’opera prima di don Milani Esperienze pastorali,
fu interessata e di parte.
Il pensiero e la prassi educativa di don Lorenzo
Milani, infatti, non possono essere ridotti alla sola pars destruens, alla
categoria della pura e semplice contestazione. V’è nel suo pensiero
una pars costruens che può essere desunta da una lettura comparata
dei suoi scritti più famosi: Lettera a una professoressa e L’obbedienza
non è più una virtù, con la sua opera prima Esperienze
pastorali, la sola che può fornire le coordinate umane, culturali,
ma soprattutto religiose, senza le quali ogni pretesa di comprendere il Milani
prete-maestro risulterebbe del tutto fuorviante.
La stessa collocazione del pensiero pedagogico milaniano
nella storia della pedagogia andrebbe rivista.
Alle indiscutibili istanze sociali e libertarie riteniamo
vada aggiunta una dimensione teoretica spiritualistica o più precisamente
personalistica, che don Milani espresse certamente sul piano della prassi
educativa concreta, che fa del priore di Barbiana, a pieno titolo, un autorevolissimo
rappresentante del personalismo cattolico contemporaneo.
Nello
Lupo |
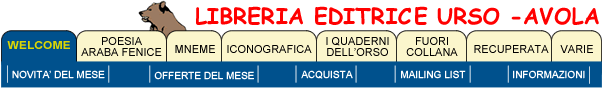
![]()