Paolo Di Paolo e il suo romanzo ''irrisolto'', di Orazio Parisi
05-09-2009 inserito da ciccio; categoria Novita' in libreria. 
Paolo Di Paolo e il suo romanzo ''irrisolto''
Voglio tornare sul termine ''irrisolto'' con il quale Paolo Di Paolo ha definito in un messaggio su FB, di risposta a uno mio precedente, il suo romanzo ''Questa lontananza cosi' vicina''(G. Perrone, Roma 2009). Non credo sia essenziale sapere se questa sua impressione, diciamo intima, l'abbia comunicata anche ad altri. Il fatto che, pur noi due non conoscendoci, l'abbia detta a me, la qual cosa mi potrebbe incuriosire maggiormente, si puo', credo facilmente, spiegare con l'entusiastico apprezzamento con il quale egli ha accolto il mio messaggio. D'altronde, perche' non credere nella funzione miracolistica delle parole, specie delle parole scritte, che all'improvviso possono abbattere d'un colpo solo ogni lontananza.
E' una di quelle banalita' che si dicono in certi momenti, questa parola ''irrisolto'', ho pensato di primo acchito. E gliel'ho pure comunicato senza indugiare piu' di tanto, sicuro del fatto che il libro mi aveva avvinto sin dalla prima lettura, non trovandovi oltretutto nulla di irrisolto. Eppure, quella parola, quell'aggettivo che ho sostantivato con tanta speditezza in ''banalita''', mi ha dato da pensare (e forse me ne da' ancora oggi). Forse e' una di quelle parole su cui non si smette mai di pensare.
''L'alfabeto che uccide'', diceva Nadia Fusini riguardo alla poetica di Wallace Stevens. Anche una sola parola puo' ''uccidere''; a volte, facendo del bene: puo' uccidere la nostra arroganza, presunzione, superficialita'.... Come racconta Paolo Di Paolo, quando fu ''ucciso'' da due sole parole: ''Ridere sull'altare! esclamo' don***. Non aggiunse altro, non era un vero rimprovero ne' uno schiaffo: ma ebbe piu' peso, mi fece piu' male''.
E' vero: a questa parola, irrisolto, se riusciamo a ficcarci dentro tutto il nostro sentire - le emozioni, i progetti, le illusioni, le vittorie, i fallimenti... tutto -, non si puo' rinunciare piu' a pensare. Credo che pensassi esattamente a questo, quando ho scritto in quel messaggio a Paolo, che irrisolta e' proprio la vita; e forse, proprio per questo, m'era sembrata una banalita', ossia qualcosa di notoriamente comune a tutti: banal, nel suo significato etimologico, appunto.
Ma si', in fondo cos'altro e' la vita se non il calderone incandescente in cui si mescolano di continuo gli elementi di quell'elenco, di cui parla Paolo nel libro, magari stucchevole e illegibile, con cui D. ''avrebbe tentato un'immagine del reale, delle cose e del loro senso, quello di cui aveva fatto esperienza''. Questa vita cos'e', se non la cifra, il registro delle banalita', una dopo l'altra. Non a caso Schopenhauer ammoniva, rinunciate alla vita! E Michelstaedter aggiungeva: la vita e' solo rettorica, non persuade di nulla; essa e' come un gancio che pende e, in quanto pende, dipende. Banalita'.
Certo, banalita'. Piu' questa parola si pronuncia e piu' diviene oscura, enigmatica. Ma cos'e', davvero, questa banalita'? Non sono cosi' stupido, da pormi una domanda che possa esaurirsi con quattro battute da filosofia spicciola o che si possa risolvere, banalmente, con un vocabolario. E' allora necessario fare un salto e tuffarsi, dal trampolino, comodo, ''sulla vita'', nelle acque che si agitano ''nella vita'', perche' e' nella vita che ogni cosa acquista il suo peso specifico, ed e' in essa che , all'improvviso, si puo' andare a fondo, e scoprire che molte cosiddette banalita' non sono affatto banali: ''Cosi' si muore, scoprivo, come se non lo sapessi gia''', si legge quasi all'inizio del romanzo.
Forse bisognerebbe, di tanto in tanto, tornare bambini, a sette anni, come scrive Paolo subito dopo, per apprendere le semplici verita' della vita, e per poterci stupire di esse nella quotidianita' (o di essa, della quotidianita'?). Insomma, per apprendere che per vivere occorre un ethos; soprattutto, direi, un ethos delle cose semplici: ''... quel giorno, senza un motivo preciso, stavo tornando al mio liceo, come si fa nel primo anno da orfani di scuola (e poi non piu'). Si torna ai banchi appena lasciati quasi per rimarcare, in un sorriso teso, la distanza che ci separa da li': finalmente. Anche per dire a bidelle e a giudici la cui toga non conta piu' niente per noi, che eccoci, che adesso la vita e' solo nostra. Cominciata universita' o risposte ai telefoni di un call-center, importa lo sguardo svagato che possiamo finalmente permetterci. Carlo, diplomato e miracolato, per almeno una ventina di ricreazioni, seguitava a comparire da quelle parti: forse perche' aveva interessi amorosi, ma forse soprattutto perche' adesso, adesso poteva rullare canne in santa pace, alla faccia di tutto e tutti - e di quanto mi avete fatto patire''. E allora, che cosa e' banalita'?, piu' che una semplice domanda, potrebbe essere un invito, un invito a riscoprire un ethos. Che non la si prenda a ridere, pero'. Capisco, la tentazione e' forte, quando si parla di ethos in questo Paese, in cui persino il Capo, colui che da' l'esempio, ha tutt'al pi' un ethos da escort.
L'ho chiamato l'ethos delle cose semplici. Mi viene in mente quell'etica del movente, enunciata per primo da Prodico, cosi' come la riferisce Senofonte: ''Se vuoi che gli dei ti siano benevoli, devi venerare gli dei. Se vuoi essere amato dagli amici, devi beneficare gli amici. Se desideri essere onorato da una citta', devi essere utile alla citta'. Se aspiri ad essere ammirato da tutta la Grecia, devi sforzarti di far bene alla Grecia, ecc.''. Non c'e' nulla di complicato in questo, eppure senza queste semplici (banali?) verita', non si vive ne' si sopravvive. Il Paese sta andando a fondo? Forse perche' ha smarrito le cose semplici, banali? E' che in questo Paese, cosi' com'e' oggi, niente puo' essere banale, ma anzi tutto diviene ''urgente''. Anche un romanzetto ''irrisolto'', come l'ha definito lo stesso autore.
Ma forse questo ragazzo vuole dissimulare cosi' la sua timidezza. Forse, questo ragazzo, ha gia' capito anche che non bisogna montarsi la testa, che occorre non confidare molto sugli onori e improntare uno stile di vita che non consideri gli oneri solo come sacrifici. E ha capito ancora molto di piu'. Che, a furia di ''libri sbagliati e di domande'', di ''Romanzi invecchiati nello sforzo scolastico di ringiovanire'', ci vuole poco a ritrovarsi estromessi ''dalla categoria dei Normali''. E a ''Impazzire'' per questo. E che, infine, occorre cercare, in tutto cio' che la vita offre, e sopra tutto, come ha insegnato Lalla Romano in quel passo di ''Nei mari estremi'' che lui riporta nel libro, la ''verita' chiara come l'aria e sostanziosa come il pane'', non la verita' ''comoda'', ma ''semplice''.
Pero', non ha capito forse, questo ragazzo, che in questo Paese, a forza di sminuire le cose buone, si continua a soffrire la solitudine. Perche' la maggior parte delle persone, in questo Paese, ha smarrito l'anima, e non sa piu' cosa sia, l'anima. E non la cerca piu', credendo che possedere un'anima non fosse di alcuna utilita'. Un bel libro di Romano Montroni, edito da Laterza nel 2006, s'intitola ''Vendere l'anima - il mestiere del libraio''. Aveva capito Montroni che oggi, in questo Paese, il mestiere del libraio e' un'attivita' in fallimento.
Non e' che Paolo Di Paolo non abbia capito tutto questo. Figuriamoci! E' che egli, forse per modestia, non riconosce chiaramente nel suo bel libro, uno dei rari buoni romanzi incentrati sui giovani e la scuola, l'''urgenza'' di essere letto da tutti. Affinche' in questo Paese, al quale oggi, per noti motivi, di giovani e di scuola non ''importa una emerita minchia, con rispetto parlando'', si possa trovare l'occasione giusta per ricominciare a parlare di cose serie. Altro che banalita'! ''Ma scusa Tubini, ma in fondo che cosa sapevamo noi, dei professori? Chi erano per noi? e chi eravamo noi per loro, oltre quel cognome-nome sul registro? Forse lo capiamo sempre troppo tardi. Forse e' tardi quando scopriamo che alcuni di loro hanno tracciato segretamente in noi le mappe di una geografia del cuore''.
Alcuni di loro. Enuclea, Paolo Di Paolo, gli sforzi dei professori: ''Li abbiamo visti leggere versi antichi...'', ''Li abbiamo visti completare alla lavagna lunghissime equazioni...''. ''Li abbiamo visti anche spolmonarsi ˝ prosegue subito dopo ˝, far la voce grossa, quando forse non c'era ragione...'', ''A volte ci hanno umiliato, di fronte a tutti, con parole che entravano dritte come lame nella nostra pelle di burro. Li abbiamo, con il tempo, scoperti piu' umani, mai infallibili, come ci era capitato talvolta di ritenerli; e capaci (come noi) di generosita', ma anche di azioni e frasi meschine, perfino cattive''. E, dulcis in fundo, verita' per verita': ''Li abbiamo giudicati incapaci, stolti, falliti (in alcuni casi lo erano)''. Il mio amico libraio-editore Ciccio Urso non esiterebbe ad aggiungere che i maggiori record del non comprare libri, e del non saper leggere (e scrivere), li hanno proprio loro, i professori.
Ma tutto questo non giustifica, non solo il rancore dei ragazzi, come scrive Paolo Di Paolo, ma soprattutto l'indifferenza della societa', delle famiglie, dei bravi padri di famiglia nelle loro faccende affaccendati (e le ''faccende'' dei vostri figli, di chi sono?). Non giustifica affatto l'approssimazione, per non dire altro, con cui i politici, i governanti affrontano le questioni serie, come queste. Tanto, la scuola cosa da' ai nostri ragazzi?, dicono i bravi padri di famiglia. E allora dai, escludiamo perfino Darwin dall'insegnamento, dicono i nostri bravi governanti. Tanto, i professori sono dei falliti, dice la societa'; i giovani sono incapaci, dicono i professori; e noi ci facciamo le canne, dicono i ragazzi ˝ e Vaffanculo!
Elsa Morante, nella sua raccolta di poesie Il mondo salvato dai ragazzini scritta nel 1968, diceva in conclusione: ''E adesso o voi che avete ascoltato queste canzoni, perdonatemi se sospiro ripensando a quanto era stata semplice la mia vita''. Lei si riferiva certamente alla vita ''semplice'' dei ragazzi degli anni Quaranta e Cinquanta, ai quali aveva fatto dono delle favole e poesie per bambini, scritte a tredici anni, e pubblicate nel 1942 sotto il titolo Le avventure di Caterina. Il 1968 era gia' un'altra epoca, la vita non era piu' semplice come prima; e di guasti alla societa' ne ha prodotti tanti. Eppure, ricordo che il due dicembre del Sessantotto, il giorno in cui accaddero i cosiddetti Fatti di Avola, avevo quindici anni, io e il mio compagno di classe al Ginnasio, e amico per tutta la vita, Giorgio Morale (oggi fa lo scrittore e vive a Milano), appena proclamato lo sciopero a scuola, ci siamo recati sul luogo, alle porte di Avola venendo da Siracusa, in cui avvennero i sanguinosi scontri fra braccianti e polizia. Subito ci siamo messi a scroccare sigarette ai manifestanti e abbiamo anche intavolato discorsi, discorsi seri, di quelli che tu puoi fare solo a contatto con gli adulti e con il loro mondo, e che ti lasciano il segno per gli anni a venire. Ecco, tra tutto un mare di cose sbagliate di quegli anni, una sola cosa giusta ricordo, che, come dice la Morante, rendeva ''semplice'' anche la vita di quell'epoca: il contatto dei ragazzi con gli adulti, e viceversa. Oggi dominano due slogan: indifferenza e esclusione ˝ e Vaffanculo!
Ma dove cazzo l'ha presa Paolo Di Paolo questa parola ''irrisolto''. Da quale cazzo di sinapsi dei suoi neuroni e' spuntata come fungo che avvelena il libro (o me)? Irrisolto, in che? nella storia? nella scrittura? Eppure, l'ha scritto nella Postfazione che ''Lei'', la sua compagna di liceo a cui aveva ''chiesto di leggere questa storia'' e con cui riteneva di poter cominciare un dialogo, ''in sostanza, aveva letto pensando alle persone''. Ha scritto pure, citando Philip Roth, che ''la gente non legge pensando all'arte: legge pensando alle persone'' (mi piace quel brano d'inizio del libro di Martin Amis ''L'informazione'': ''Gina era una donna. Conosceva le lacrime molto meglio di lui. Non conosceva ne' gli juvenilia di Swift, ne' i senilia di Wordsworth, ne' i diversi destini di Cressida nelle mani di Boccaccio, di Chaucer, di Robert Henryson, di Shakespeare. Non conosceva Proust. Ma conosceva le lacrime. Gina era la regina delle lacrime''). Magari ''Lei'', ha scritto anche questo Paolo, ''citava Seneca: Non riflettiamo mai abbastanza su quanto e' piacevole non chiedere nulla''. Giusto. Ma ''Lei'' aveva pure le sue verita' fisse, aveva sofferto talmente tanto con quella professoressa, D., che persino la sua morte prematura ''non fa differenza'' e basta, non si domandava con Paolo: ''E verita'. Ma quale? e di chi? La domanda di Pilato: quid est veritas? che cos'e' la verita'?''.
Eppure lui ha scritto ancora dell'altro nella Postfazione: ''Crescevano i dubbi, e nel frattempo la storia scritta si allontanava da me.'', ''Mi sono trovato a fare i conti piu' volte con la stessa delusione di Dencombe. La delusione non e' che la vita, dice il dottor Hugh nelle battute finali del racconto di James.'', ''Una seconda occasione, ecco l'illusione. Poteva essercene soltanto una... Tutto il resto e' la follia dell'arte''. Ha scritto pure, alla fine del libro: ''Questo libro, in origine era un altro libro...''.
Un altro libro, la follia dell'arte. Non so se sto perdendo il filo del discorso o mi stia impantanando in una terribile aporia, come quella che fa dire nella conclusione del libro a Paolo Di Paolo: ''Per qualche giorno ho pensato: non voglio scrivere piu'''. Allora questo libro e' un ossimoro, come avrebbe detto, credo, Gesualdo Bufalino? No, non e' un ossimoro.
Io non ho l'aureola del Letterato, ma posso essere sicuro dei miei sentimenti. Essi mi suggeriscono che, a un certo punto, bisogna tornare al ''semplice'' (non al banale, non scherziamo). Mi e' capitato di ascoltare recentemente un'intervista a Paco Ignacio Taib II, in occasione della Semana negra, se non ricordo male, nella quale afferma: la scrittura conta piu' della narrazione, del contenuto. O c'e' buona scrittura o non c'e' buona letteratura; non basta una buona storia. Che poi l'alfabeto possa ''uccidere'', come dice Nadia Fusini, o ''non uccidere'', a parte l'atteggiamento surreale di chi puo' accettare entrambe le posizioni con quell'indifferenza bretoniana a tutto ci┌ che accade o non accade, tutto questo riguarda la sfera delle opinioni soggettive. E non e' detto che la prima debba necessariamente appartenere all'Arte e la seconda alla Vita. Tempo fa, con Giorgio abbiamo disquisito sulla funzione della Letteratura (e se la filosofia avesse ancora un senso. Domanda che, sosteneva Giorgio, riguardo alla letteratura nemmeno si pone). E' tuttavia certo che la letteratura e l'arte hanno il compito primario di produrre un senso, non quello di dare necessariamente compiutezza al senso. Nietzsche, in ''Umano troppo umano'', ha scritto: ''L'incompleto come cio' che e' efficace. Come le figure in rilievo agiscono cosi' fortemente sulla fantasia per il fatto di voler uscire, per cosi' dire, dalla parete e, trattenute da qualche parte, di arrestarsi improvvisamente: cosi' l'esposizione incompleta - a modo del rilievo - di un pensiero, di un'intera filosofia, e' talora piu' efficace dell'esposizione esauriente: si lascia piu' lavoro a chi guarda, questi viene spinto a continuare e a compiere col pensiero cio' che si staglia davanti in cosi' forte chiaroscuro, e a superare egli stesso quell'ostacolo che gli aveva fino allora impedito di balzar fuori compiutamente''.
E anche questo Paolo Di Paolo sa. Ma io, non so se si e' capito, non sto muovendo alcun rimprovero. Il mio e' solo un pensiero, magari approssimativo, un po' confuso, puo' darsi esagerato anche (magari irrisolto), sull'irresolutezza. Chiamiamolo ''pensiero in atto''. Perche', a forza di pensare su questa parola, m'e' venuto in mente quel bellissimo articolo di Enzo Siciliano intitolato ''Giacomo Leopardi - Un viaggio nella mente del poeta'', apparso su La Repubblica del 24 gennaio 2004, che avevo conservato di buon grado. Lo trascriverei tutto qui: perche' ogni sua frase ci fa toccare l'universo e i vari periodi conducono verso universi paralleli.
Partendo dalla notizia del riordino completo dello Zibaldone compiuto da Fabiana Cacciapuoti ''e che si e' oggi completato con la pubblicazione dell'ultimo sesto volume, Memorie della mia vita (Donzelli...)'', Siciliano ''pone un interrogativo, se questa singolarissima opera, sempre sospesa fra pensiero in atto e progetti d'opere future, abbia necessita' d'essere verticalizzata per temi allo scopo d'essere maggiormente compresa dai lettori e percorsa, e realizzi cosi' un'intenzione dell'autore rimasta nel cassetto.''.
Cos'e' rimasto nel cassetto di Paolo Di Paolo, il ''racconto critico'', il ''pellegrinaggio letterario''... ''sulle tracce della scrittrice Lalla Romano?'' ╗ questo l'irrisolto? Teme, Paolo Di Paolo, che qualcuno possa usare su di lui qualcosa del genere di quella ''formula brusca e riduttiva'', di cui parla Siciliano, che us┌ Croce contro Leopardi: ''filosofia ad uso privato''? ''All'artefice della dialettica dei distinti - prosegue Siciliano - il magma leopardiano doveva apparire un irrisolto e irresoluto vagabondaggio fra appunti di lettura, riflessioni estemporanee sui comportamenti umani, esplosioni epigrammatiche di indisciplina psicologica, noterelle di filologia e poco di piu'''. Ma, annota argutamente Siciliano, ''nella brusca uscita crociana un ramo di proficua verita' c'e''': ''Questo scarto e questo incontro, questo affidamento al sentire che rimette alla malinconia quasi una funzione conoscitiva e', in sintesi estrema, il lato positivo del dire crociano che Leopardi non pensasse se non in funzione privata, secondo un fluire che giorno dopo giorno, proprio nel disordine delle riflessioni, o delle occasioni per le piu' diverse riflessioni, si fa concreto ˝ ed e' una concretezza puntuale, mai impropria nella sua convulsa e insieme meditata varieta'. Soggettivita' e societa', costume civile e sofferto isolamento dell'io, necessita' di definire in un colloquio perennemente intimo il proprio stato di consapevolezza...''. Quest'ultimo passo sembra sintetizzare anche il romanzo ''irrisolto'' di Paolo Di Paolo.
A questo punto, mi piace chiamarlo ''irrisolto'', perche' si accosta molto al diario ''irrisolto'' leopardiano. Perche', come conclude in quell'articolo Siciliano, ''Il compito che Leopardi aveva affidato a questo suo straordinario diario... era di aiutarlo a indirettamente conoscersi, non per scoprire i propri limiti ˝ cosa che l'avrebbe reso incongruente. [...] il conoscersi per uno scrittore passa attraverso la propria opera, e in seguito alla propria opera, e non per processi di razionalizzazione. Leopardi era convinto che l'esistenza non e' per l'esistente e che gli esistenti esistono perche' si esista: cosi' il pensare, per lui, non era pensare un oggetto ma pensare di per se' ˝ un pensiero risucchiato soltanto dal proprio destino.''
Soggettivita' e societa', costume civile e sofferto isolamento dell'io: pu┌ essere una buona formula. Anche se, ebbene si', non so ancora nemmeno io, per quanto le tocchi col pensiero, come chiamarle, queste lontananze cosi' vicine.
ORAZIO PARISI
| Invia ad un Amico | 919 letture

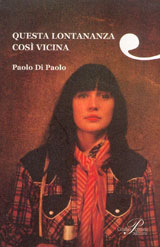
Paolo Di Paolo, Questa lontananza cosi' vicina
2009, pp. 128 Euro 10,00 ![]()
Succede cosi', succede che spesso, nell'immagine che in noi tracciamo degli altri, finiamo col trascurare dettagli essenziali: non li vediamo, non riusciamo a vederli. E non bastano gesti, scosse del capo, rughe, a definire un passato, un presente altrui. Se di qualcosa finalmente veniamo a capo assommando segni e indizi (carte ingiallite come queste che ho davanti), dobbiamo ritenerlo un piccolo, vitale miracolo.
Paolo Di Paolo e il suo romanzo ''irrisolto''
Voglio tornare sul termine ''irrisolto'' con il quale Paolo Di Paolo ha definito in un messaggio su FB, di risposta a uno mio precedente, il suo romanzo ''Questa lontananza cosi' vicina''(G. Perrone, Roma 2009). Non credo sia essenziale sapere se questa sua impressione, diciamo intima, l'abbia comunicata anche ad altri. Il fatto che, pur noi due non conoscendoci, l'abbia detta a me, la qual cosa mi potrebbe incuriosire maggiormente, si puo', credo facilmente, spiegare con l'entusiastico apprezzamento con il quale egli ha accolto il mio messaggio. D'altronde, perche' non credere nella funzione miracolistica delle parole, specie delle parole scritte, che all'improvviso possono abbattere d'un colpo solo ogni lontananza.
E' una di quelle banalita' che si dicono in certi momenti, questa parola ''irrisolto'', ho pensato di primo acchito. E gliel'ho pure comunicato senza indugiare piu' di tanto, sicuro del fatto che il libro mi aveva avvinto sin dalla prima lettura, non trovandovi oltretutto nulla di irrisolto. Eppure, quella parola, quell'aggettivo che ho sostantivato con tanta speditezza in ''banalita''', mi ha dato da pensare (e forse me ne da' ancora oggi). Forse e' una di quelle parole su cui non si smette mai di pensare.
''L'alfabeto che uccide'', diceva Nadia Fusini riguardo alla poetica di Wallace Stevens. Anche una sola parola puo' ''uccidere''; a volte, facendo del bene: puo' uccidere la nostra arroganza, presunzione, superficialita'.... Come racconta Paolo Di Paolo, quando fu ''ucciso'' da due sole parole: ''Ridere sull'altare! esclamo' don***. Non aggiunse altro, non era un vero rimprovero ne' uno schiaffo: ma ebbe piu' peso, mi fece piu' male''.
E' vero: a questa parola, irrisolto, se riusciamo a ficcarci dentro tutto il nostro sentire - le emozioni, i progetti, le illusioni, le vittorie, i fallimenti... tutto -, non si puo' rinunciare piu' a pensare. Credo che pensassi esattamente a questo, quando ho scritto in quel messaggio a Paolo, che irrisolta e' proprio la vita; e forse, proprio per questo, m'era sembrata una banalita', ossia qualcosa di notoriamente comune a tutti: banal, nel suo significato etimologico, appunto.
Ma si', in fondo cos'altro e' la vita se non il calderone incandescente in cui si mescolano di continuo gli elementi di quell'elenco, di cui parla Paolo nel libro, magari stucchevole e illegibile, con cui D. ''avrebbe tentato un'immagine del reale, delle cose e del loro senso, quello di cui aveva fatto esperienza''. Questa vita cos'e', se non la cifra, il registro delle banalita', una dopo l'altra. Non a caso Schopenhauer ammoniva, rinunciate alla vita! E Michelstaedter aggiungeva: la vita e' solo rettorica, non persuade di nulla; essa e' come un gancio che pende e, in quanto pende, dipende. Banalita'.
Certo, banalita'. Piu' questa parola si pronuncia e piu' diviene oscura, enigmatica. Ma cos'e', davvero, questa banalita'? Non sono cosi' stupido, da pormi una domanda che possa esaurirsi con quattro battute da filosofia spicciola o che si possa risolvere, banalmente, con un vocabolario. E' allora necessario fare un salto e tuffarsi, dal trampolino, comodo, ''sulla vita'', nelle acque che si agitano ''nella vita'', perche' e' nella vita che ogni cosa acquista il suo peso specifico, ed e' in essa che , all'improvviso, si puo' andare a fondo, e scoprire che molte cosiddette banalita' non sono affatto banali: ''Cosi' si muore, scoprivo, come se non lo sapessi gia''', si legge quasi all'inizio del romanzo.
Forse bisognerebbe, di tanto in tanto, tornare bambini, a sette anni, come scrive Paolo subito dopo, per apprendere le semplici verita' della vita, e per poterci stupire di esse nella quotidianita' (o di essa, della quotidianita'?). Insomma, per apprendere che per vivere occorre un ethos; soprattutto, direi, un ethos delle cose semplici: ''... quel giorno, senza un motivo preciso, stavo tornando al mio liceo, come si fa nel primo anno da orfani di scuola (e poi non piu'). Si torna ai banchi appena lasciati quasi per rimarcare, in un sorriso teso, la distanza che ci separa da li': finalmente. Anche per dire a bidelle e a giudici la cui toga non conta piu' niente per noi, che eccoci, che adesso la vita e' solo nostra. Cominciata universita' o risposte ai telefoni di un call-center, importa lo sguardo svagato che possiamo finalmente permetterci. Carlo, diplomato e miracolato, per almeno una ventina di ricreazioni, seguitava a comparire da quelle parti: forse perche' aveva interessi amorosi, ma forse soprattutto perche' adesso, adesso poteva rullare canne in santa pace, alla faccia di tutto e tutti - e di quanto mi avete fatto patire''. E allora, che cosa e' banalita'?, piu' che una semplice domanda, potrebbe essere un invito, un invito a riscoprire un ethos. Che non la si prenda a ridere, pero'. Capisco, la tentazione e' forte, quando si parla di ethos in questo Paese, in cui persino il Capo, colui che da' l'esempio, ha tutt'al pi' un ethos da escort.
L'ho chiamato l'ethos delle cose semplici. Mi viene in mente quell'etica del movente, enunciata per primo da Prodico, cosi' come la riferisce Senofonte: ''Se vuoi che gli dei ti siano benevoli, devi venerare gli dei. Se vuoi essere amato dagli amici, devi beneficare gli amici. Se desideri essere onorato da una citta', devi essere utile alla citta'. Se aspiri ad essere ammirato da tutta la Grecia, devi sforzarti di far bene alla Grecia, ecc.''. Non c'e' nulla di complicato in questo, eppure senza queste semplici (banali?) verita', non si vive ne' si sopravvive. Il Paese sta andando a fondo? Forse perche' ha smarrito le cose semplici, banali? E' che in questo Paese, cosi' com'e' oggi, niente puo' essere banale, ma anzi tutto diviene ''urgente''. Anche un romanzetto ''irrisolto'', come l'ha definito lo stesso autore.
Ma forse questo ragazzo vuole dissimulare cosi' la sua timidezza. Forse, questo ragazzo, ha gia' capito anche che non bisogna montarsi la testa, che occorre non confidare molto sugli onori e improntare uno stile di vita che non consideri gli oneri solo come sacrifici. E ha capito ancora molto di piu'. Che, a furia di ''libri sbagliati e di domande'', di ''Romanzi invecchiati nello sforzo scolastico di ringiovanire'', ci vuole poco a ritrovarsi estromessi ''dalla categoria dei Normali''. E a ''Impazzire'' per questo. E che, infine, occorre cercare, in tutto cio' che la vita offre, e sopra tutto, come ha insegnato Lalla Romano in quel passo di ''Nei mari estremi'' che lui riporta nel libro, la ''verita' chiara come l'aria e sostanziosa come il pane'', non la verita' ''comoda'', ma ''semplice''.
Pero', non ha capito forse, questo ragazzo, che in questo Paese, a forza di sminuire le cose buone, si continua a soffrire la solitudine. Perche' la maggior parte delle persone, in questo Paese, ha smarrito l'anima, e non sa piu' cosa sia, l'anima. E non la cerca piu', credendo che possedere un'anima non fosse di alcuna utilita'. Un bel libro di Romano Montroni, edito da Laterza nel 2006, s'intitola ''Vendere l'anima - il mestiere del libraio''. Aveva capito Montroni che oggi, in questo Paese, il mestiere del libraio e' un'attivita' in fallimento.
Non e' che Paolo Di Paolo non abbia capito tutto questo. Figuriamoci! E' che egli, forse per modestia, non riconosce chiaramente nel suo bel libro, uno dei rari buoni romanzi incentrati sui giovani e la scuola, l'''urgenza'' di essere letto da tutti. Affinche' in questo Paese, al quale oggi, per noti motivi, di giovani e di scuola non ''importa una emerita minchia, con rispetto parlando'', si possa trovare l'occasione giusta per ricominciare a parlare di cose serie. Altro che banalita'! ''Ma scusa Tubini, ma in fondo che cosa sapevamo noi, dei professori? Chi erano per noi? e chi eravamo noi per loro, oltre quel cognome-nome sul registro? Forse lo capiamo sempre troppo tardi. Forse e' tardi quando scopriamo che alcuni di loro hanno tracciato segretamente in noi le mappe di una geografia del cuore''.
Alcuni di loro. Enuclea, Paolo Di Paolo, gli sforzi dei professori: ''Li abbiamo visti leggere versi antichi...'', ''Li abbiamo visti completare alla lavagna lunghissime equazioni...''. ''Li abbiamo visti anche spolmonarsi ˝ prosegue subito dopo ˝, far la voce grossa, quando forse non c'era ragione...'', ''A volte ci hanno umiliato, di fronte a tutti, con parole che entravano dritte come lame nella nostra pelle di burro. Li abbiamo, con il tempo, scoperti piu' umani, mai infallibili, come ci era capitato talvolta di ritenerli; e capaci (come noi) di generosita', ma anche di azioni e frasi meschine, perfino cattive''. E, dulcis in fundo, verita' per verita': ''Li abbiamo giudicati incapaci, stolti, falliti (in alcuni casi lo erano)''. Il mio amico libraio-editore Ciccio Urso non esiterebbe ad aggiungere che i maggiori record del non comprare libri, e del non saper leggere (e scrivere), li hanno proprio loro, i professori.
Ma tutto questo non giustifica, non solo il rancore dei ragazzi, come scrive Paolo Di Paolo, ma soprattutto l'indifferenza della societa', delle famiglie, dei bravi padri di famiglia nelle loro faccende affaccendati (e le ''faccende'' dei vostri figli, di chi sono?). Non giustifica affatto l'approssimazione, per non dire altro, con cui i politici, i governanti affrontano le questioni serie, come queste. Tanto, la scuola cosa da' ai nostri ragazzi?, dicono i bravi padri di famiglia. E allora dai, escludiamo perfino Darwin dall'insegnamento, dicono i nostri bravi governanti. Tanto, i professori sono dei falliti, dice la societa'; i giovani sono incapaci, dicono i professori; e noi ci facciamo le canne, dicono i ragazzi ˝ e Vaffanculo!
Elsa Morante, nella sua raccolta di poesie Il mondo salvato dai ragazzini scritta nel 1968, diceva in conclusione: ''E adesso o voi che avete ascoltato queste canzoni, perdonatemi se sospiro ripensando a quanto era stata semplice la mia vita''. Lei si riferiva certamente alla vita ''semplice'' dei ragazzi degli anni Quaranta e Cinquanta, ai quali aveva fatto dono delle favole e poesie per bambini, scritte a tredici anni, e pubblicate nel 1942 sotto il titolo Le avventure di Caterina. Il 1968 era gia' un'altra epoca, la vita non era piu' semplice come prima; e di guasti alla societa' ne ha prodotti tanti. Eppure, ricordo che il due dicembre del Sessantotto, il giorno in cui accaddero i cosiddetti Fatti di Avola, avevo quindici anni, io e il mio compagno di classe al Ginnasio, e amico per tutta la vita, Giorgio Morale (oggi fa lo scrittore e vive a Milano), appena proclamato lo sciopero a scuola, ci siamo recati sul luogo, alle porte di Avola venendo da Siracusa, in cui avvennero i sanguinosi scontri fra braccianti e polizia. Subito ci siamo messi a scroccare sigarette ai manifestanti e abbiamo anche intavolato discorsi, discorsi seri, di quelli che tu puoi fare solo a contatto con gli adulti e con il loro mondo, e che ti lasciano il segno per gli anni a venire. Ecco, tra tutto un mare di cose sbagliate di quegli anni, una sola cosa giusta ricordo, che, come dice la Morante, rendeva ''semplice'' anche la vita di quell'epoca: il contatto dei ragazzi con gli adulti, e viceversa. Oggi dominano due slogan: indifferenza e esclusione ˝ e Vaffanculo!
Ma dove cazzo l'ha presa Paolo Di Paolo questa parola ''irrisolto''. Da quale cazzo di sinapsi dei suoi neuroni e' spuntata come fungo che avvelena il libro (o me)? Irrisolto, in che? nella storia? nella scrittura? Eppure, l'ha scritto nella Postfazione che ''Lei'', la sua compagna di liceo a cui aveva ''chiesto di leggere questa storia'' e con cui riteneva di poter cominciare un dialogo, ''in sostanza, aveva letto pensando alle persone''. Ha scritto pure, citando Philip Roth, che ''la gente non legge pensando all'arte: legge pensando alle persone'' (mi piace quel brano d'inizio del libro di Martin Amis ''L'informazione'': ''Gina era una donna. Conosceva le lacrime molto meglio di lui. Non conosceva ne' gli juvenilia di Swift, ne' i senilia di Wordsworth, ne' i diversi destini di Cressida nelle mani di Boccaccio, di Chaucer, di Robert Henryson, di Shakespeare. Non conosceva Proust. Ma conosceva le lacrime. Gina era la regina delle lacrime''). Magari ''Lei'', ha scritto anche questo Paolo, ''citava Seneca: Non riflettiamo mai abbastanza su quanto e' piacevole non chiedere nulla''. Giusto. Ma ''Lei'' aveva pure le sue verita' fisse, aveva sofferto talmente tanto con quella professoressa, D., che persino la sua morte prematura ''non fa differenza'' e basta, non si domandava con Paolo: ''E verita'. Ma quale? e di chi? La domanda di Pilato: quid est veritas? che cos'e' la verita'?''.
Eppure lui ha scritto ancora dell'altro nella Postfazione: ''Crescevano i dubbi, e nel frattempo la storia scritta si allontanava da me.'', ''Mi sono trovato a fare i conti piu' volte con la stessa delusione di Dencombe. La delusione non e' che la vita, dice il dottor Hugh nelle battute finali del racconto di James.'', ''Una seconda occasione, ecco l'illusione. Poteva essercene soltanto una... Tutto il resto e' la follia dell'arte''. Ha scritto pure, alla fine del libro: ''Questo libro, in origine era un altro libro...''.
Un altro libro, la follia dell'arte. Non so se sto perdendo il filo del discorso o mi stia impantanando in una terribile aporia, come quella che fa dire nella conclusione del libro a Paolo Di Paolo: ''Per qualche giorno ho pensato: non voglio scrivere piu'''. Allora questo libro e' un ossimoro, come avrebbe detto, credo, Gesualdo Bufalino? No, non e' un ossimoro.
Io non ho l'aureola del Letterato, ma posso essere sicuro dei miei sentimenti. Essi mi suggeriscono che, a un certo punto, bisogna tornare al ''semplice'' (non al banale, non scherziamo). Mi e' capitato di ascoltare recentemente un'intervista a Paco Ignacio Taib II, in occasione della Semana negra, se non ricordo male, nella quale afferma: la scrittura conta piu' della narrazione, del contenuto. O c'e' buona scrittura o non c'e' buona letteratura; non basta una buona storia. Che poi l'alfabeto possa ''uccidere'', come dice Nadia Fusini, o ''non uccidere'', a parte l'atteggiamento surreale di chi puo' accettare entrambe le posizioni con quell'indifferenza bretoniana a tutto ci┌ che accade o non accade, tutto questo riguarda la sfera delle opinioni soggettive. E non e' detto che la prima debba necessariamente appartenere all'Arte e la seconda alla Vita. Tempo fa, con Giorgio abbiamo disquisito sulla funzione della Letteratura (e se la filosofia avesse ancora un senso. Domanda che, sosteneva Giorgio, riguardo alla letteratura nemmeno si pone). E' tuttavia certo che la letteratura e l'arte hanno il compito primario di produrre un senso, non quello di dare necessariamente compiutezza al senso. Nietzsche, in ''Umano troppo umano'', ha scritto: ''L'incompleto come cio' che e' efficace. Come le figure in rilievo agiscono cosi' fortemente sulla fantasia per il fatto di voler uscire, per cosi' dire, dalla parete e, trattenute da qualche parte, di arrestarsi improvvisamente: cosi' l'esposizione incompleta - a modo del rilievo - di un pensiero, di un'intera filosofia, e' talora piu' efficace dell'esposizione esauriente: si lascia piu' lavoro a chi guarda, questi viene spinto a continuare e a compiere col pensiero cio' che si staglia davanti in cosi' forte chiaroscuro, e a superare egli stesso quell'ostacolo che gli aveva fino allora impedito di balzar fuori compiutamente''.
E anche questo Paolo Di Paolo sa. Ma io, non so se si e' capito, non sto muovendo alcun rimprovero. Il mio e' solo un pensiero, magari approssimativo, un po' confuso, puo' darsi esagerato anche (magari irrisolto), sull'irresolutezza. Chiamiamolo ''pensiero in atto''. Perche', a forza di pensare su questa parola, m'e' venuto in mente quel bellissimo articolo di Enzo Siciliano intitolato ''Giacomo Leopardi - Un viaggio nella mente del poeta'', apparso su La Repubblica del 24 gennaio 2004, che avevo conservato di buon grado. Lo trascriverei tutto qui: perche' ogni sua frase ci fa toccare l'universo e i vari periodi conducono verso universi paralleli.
Partendo dalla notizia del riordino completo dello Zibaldone compiuto da Fabiana Cacciapuoti ''e che si e' oggi completato con la pubblicazione dell'ultimo sesto volume, Memorie della mia vita (Donzelli...)'', Siciliano ''pone un interrogativo, se questa singolarissima opera, sempre sospesa fra pensiero in atto e progetti d'opere future, abbia necessita' d'essere verticalizzata per temi allo scopo d'essere maggiormente compresa dai lettori e percorsa, e realizzi cosi' un'intenzione dell'autore rimasta nel cassetto.''.
Cos'e' rimasto nel cassetto di Paolo Di Paolo, il ''racconto critico'', il ''pellegrinaggio letterario''... ''sulle tracce della scrittrice Lalla Romano?'' ╗ questo l'irrisolto? Teme, Paolo Di Paolo, che qualcuno possa usare su di lui qualcosa del genere di quella ''formula brusca e riduttiva'', di cui parla Siciliano, che us┌ Croce contro Leopardi: ''filosofia ad uso privato''? ''All'artefice della dialettica dei distinti - prosegue Siciliano - il magma leopardiano doveva apparire un irrisolto e irresoluto vagabondaggio fra appunti di lettura, riflessioni estemporanee sui comportamenti umani, esplosioni epigrammatiche di indisciplina psicologica, noterelle di filologia e poco di piu'''. Ma, annota argutamente Siciliano, ''nella brusca uscita crociana un ramo di proficua verita' c'e''': ''Questo scarto e questo incontro, questo affidamento al sentire che rimette alla malinconia quasi una funzione conoscitiva e', in sintesi estrema, il lato positivo del dire crociano che Leopardi non pensasse se non in funzione privata, secondo un fluire che giorno dopo giorno, proprio nel disordine delle riflessioni, o delle occasioni per le piu' diverse riflessioni, si fa concreto ˝ ed e' una concretezza puntuale, mai impropria nella sua convulsa e insieme meditata varieta'. Soggettivita' e societa', costume civile e sofferto isolamento dell'io, necessita' di definire in un colloquio perennemente intimo il proprio stato di consapevolezza...''. Quest'ultimo passo sembra sintetizzare anche il romanzo ''irrisolto'' di Paolo Di Paolo.
A questo punto, mi piace chiamarlo ''irrisolto'', perche' si accosta molto al diario ''irrisolto'' leopardiano. Perche', come conclude in quell'articolo Siciliano, ''Il compito che Leopardi aveva affidato a questo suo straordinario diario... era di aiutarlo a indirettamente conoscersi, non per scoprire i propri limiti ˝ cosa che l'avrebbe reso incongruente. [...] il conoscersi per uno scrittore passa attraverso la propria opera, e in seguito alla propria opera, e non per processi di razionalizzazione. Leopardi era convinto che l'esistenza non e' per l'esistente e che gli esistenti esistono perche' si esista: cosi' il pensare, per lui, non era pensare un oggetto ma pensare di per se' ˝ un pensiero risucchiato soltanto dal proprio destino.''
Soggettivita' e societa', costume civile e sofferto isolamento dell'io: pu┌ essere una buona formula. Anche se, ebbene si', non so ancora nemmeno io, per quanto le tocchi col pensiero, come chiamarle, queste lontananze cosi' vicine.
ORAZIO PARISI
| Invia ad un Amico | 919 letture