Dopo lo sbarco, le operazioni militari si sviluppano lungo la
costa settentrionale della Sicilia, da ovest verso est, e, quindi,
il Val di Noto non è nemmeno sfiorato da questi eventi;
tuttavia le notizie delle prime vittorie garibaldine, che nei
primi tempi vi arrivano in ritardo di parecchi giorni, innescano
la rivolta da tempo preparata dai liberali del luogo. Le autorità
borboniche si dimostrano sfiduciate e rassegnate al peggio.
 A
A
Noto, allora capoluogo di una provincia che comprendeva le attuali
province di Siracusa e di Ragusa, risiede, circondato da uno stuolo
di funzionari, l’intendente Nicola Mezzasalma, massima autorità
civile del territorio. A Siracusa, che rivendica sempre il capoluogo
che le era stato tolto dopo la disastrosa rivolta del 1837, risiede
il capo militare della provincia, il generale Giovanni Rodriguez:
sono al suo comando circa 3000 soldati, acquartierati al castello
Maniace.
E’ massimamente tra questi due poli, Noto e Siracusa, che
si giocherà il destino della provincia, anche se è
doveroso sottolineare che la libertà d’azione dei
siracusani è quasi del tutto annullata dalla presenza della
forte guarnigione napoletana, che tiene sotto il tiro dei cannoni
l’intera popolazione. Tuttavia anche la posizione delle
due maggiori autorità borboniche è notevolmente
indebolita da diverse circostanze sfavorevoli.
L’assenza di truppe a Noto, mette di fatto l’intendente
alla mercé del ceto dominante locale, che si professa filoborbonico
da sempre ma, allo stesso tempo, si tiene segretamente in contatto
col concittadino avvocato Matteo Raeli, in esilio a Malta con
altri liberali siciliani e capo carismatico dei moderati netini.
Il Mezzasalma, da uomo accorto ed esperiente, coltiva rapporti
di amichevole collaborazione con gli esponenti del gruppo Raeli,
che comprende la nobiltà e l’alta borghesia netina.
A Noto esiste anche un battagliero gruppo democratico, (capeggiato
dal dottor Lucio Bonfanti che si trova a Catania)  che spera
nell’imminente rivoluzione per sostituirsi alla nobiltà
ai vertici del potere locale.
Il generale Rodriguez risiede a Siracusa da ben sette anni ed
è molto stimato dai siracusani: forse troppo, a giudizio
di alcuni suoi ufficiali di sicura fede borbonica. Egli sa bene
che, se la truppa è nel complesso fedele al re, alcuni
dei suoi ufficiali, per contro, sono in ottimi rapporti coi liberali
siracusani. La Massoneria, che ha il suo massimo esponente nel
vecchio barone Pancali, è molto potente in tutta la provincia
e, probabilmente, promuove e facilita i rapporti con gli ufficiali
di fede liberale.
Quando la notizia dell’insurrezione della Gancia arriva
nel Val di Noto, i democratici notinesi prendono prontamente l’iniziativa
e organizzano una manifestazione per la domenica di Pasqua (8
aprile). Anche i siracusani, dopo una riunione in casa Bufardeci,
decidono di muoversi e, il giorno della vigilia, distribuiscono
cautamente ad alcuni soldati napoletani in libera uscita un invito
a fraternizzare. Il generale, da poco nominato maresciallo di
campo, fa pubblicare immediatamente un proclama per richiamare
l’esercito alla fedeltà e, l’indomani, invia
un distaccamento di truppa a presidiare piazza Duomo. A Siracusa
la Pasqua trascorre del tutto tranquillamente: non altrettanto
a Noto, dove alcuni manifestanti vengono arrestati dalla polizia
prima ancora di aver dato inizio alla programmata distribuzione
delle coccarde tricolori. Molti di essi si salvano con la fuga
e imprecano contro i moderati che sospettano di tradimento.
Ai primi di maggio il generale Rodriguez, nel tentativo di sedare
i fermenti dei siracusani, distribuisce 600 ducati a 500 cittadini
tra i più bisognosi. Giorno 10 una nave della Regia Marina
piemontese attracca al porto di Siracusa e una delegazione di
liberali locali si reca a bordo per esternare al comandante i
più vivi sentimenti nei confronti del re Vittorio Emanuele.
Giorno 11 Garibaldi sbarca a Marsala e inizia la sua marcia vittoriosa
verso Palermo e, successivamente, verso Messina e Napoli.
 A mano a mano che la notizia dello sbarco raggiunge i Comuni
della Sicilia, i liberali insorgono contro le autorità
borboniche mentre i contadini, guidati a volte da esponenti del
partito democratico ma più spesso spontaneamente, danno
inizio alla “loro” rivoluzione, attaccando ferocemente
i benestanti.
A Noto il locale gruppo dei liberali moderati lavora prudentemente
d’intesa con l’intendente Mezzasalma per arrivare
all’ormai prossimo cambio della guardia in modo indolore
e, a un tempo, per garantirsi la continuità del predominio
anche nel futuro panorama politico. I democratici mordono il freno
e giocano d’anticipo, tentando di sfruttare il vantaggio
iniziale. Quando Lucio Bonfanti avverte segretamente da Catania
i suoi amici dell’avvenuto sbarco di Garibaldi, costoro,
il pomeriggio del 16 maggio, danno inizio all’insurrezione,
cogliendo stavolta di sorpresa la polizia e gli stessi moderati
che aspettano notizie da Malta. Agendo con rapidità e determinazione
gli insorti liberano i detenuti politici, danno l’assalto
al commissariato di polizia, disarmano i poliziotti e si installano
nel palazzo comunale, sperando inutilmente che il loro esempio
venga seguito dalla popolazione. Durante una riunione notturna
che immaginiamo parecchio agitata, i moderati concordano il da
farsi col connivente intendente il quale, l’indomani, convoca
amichevolmente i parenti dei ribelli (che sono asserragliati al
palazzo Ducezio) e, alternando le minacce alle blandizie, comunica
loro la falsa notizia del prossimo arrivo di una forte truppa
da Siracusa che sistemerà tutto con la forza; infine li
invita a convincere gli insorti a uscire spontaneamente e a disperdersi
nelle vicine campagna, promettendo in tal caso che avrebbe chiuso
non uno ma entrambi gli occhi. Il piano funziona alla perfezione
e, la notte del 17, i ribelli si allontanano indisturbati da Noto.
I moderati non hanno però nemmeno il tempo di godersi
in santa pace lo scampato pericolo: infatti, il pomeriggio del
18, ricevono da Malta una lettera del Raeli (recapitata da due
emissari del comitato di Modica) che annuncia la notizia dello
sbarco di Garibaldi. Altra nottataccia in casa del marchese Trigona
di Cannicarao! I moderati sanno bene che tocca a Noto, in quanto
capoluogo, l’incombenza di dare il segnale della rivolta
a tutti i comitati segreti della provincia e sanno pure che non
possono permettersi molte tergiversazioni per evitare di essere
accusati di doppiogiochismo, come avvenne nel 1848. Decidono quindi
di prendere a loro volta e rapidamente l’iniziativa e, a
notte fonda, fanno piazzare una bandiera tricolore raffazzonata
alla buona sulla statua di Ercole, in piazza Teatro.
 All’alba
All’alba
la bandiera viene “scoperta” dalla guardia urbana
che informa il comandante, guarda caso lo stesso marchese di Cannicarao,
il quale ordina risolutamente di non rimuoverla. Le autorità
borboniche stavolta si guardano bene dall’intervenire, anzi
restano chiuse in casa e non vengono molestate da nessuno. Più
tardi spuntano altre bandiere portate in giro dai nobili; a quel
punto i cittadini capiscono che è scoppiata la rivoluzione
“giusta” e si forma un imponente corteo che percorre
le vie dietro la banda musicale. I nuovi ribelli richiamano i
ribelli di giorno 16 (che rientrano esterefatti in città),
eleggono alla svelta un comitato rivoluzionario nel quale si riservano
una schiacciante maggioranza e, il 19, stilano un proclama che
comunica l’avvenuta rivolta a tutti i comitati della provincia,
retrodatandolo al 16 e appropriandosi in tal modo dell’iniziativa
dei democratici. L’indomani i funzionari borbonici, che
a giudizio dei democratici dovrebbero essere arrestati, abbandonano
indisturbati la città e si dirigono chi al proprio paese
d’origine e chi in altro luogo ritenuto più sicuro,
ma non a Siracusa, come imporrebbe un loro preciso dovere. La
loro diserzione è un segno tangibile del precipitare degli
eventi.
Mentre a Noto si verificano questi avvenimenti, a dire il vero
non molto gloriosi ma che comunque detrminano la fine del potere
civile borbonico nella provincia, a Siracusa si lavora alacremente
per smantellare il ben più pericoloso potere militare.
Il 16, in concomitanza col primo tentativo di Noto, si verifica
qualche lieve disordine, facilmente represso. Il 18 il generale
Rodriguez pubblica un manifesto che annuncia la falsa notizia
del fallimento dello sbarco di Garibaldi e invita tutti alla calma:
i liberali rispondono con un altro manifesto che smentisce la
notizia e invita il generale a fraternizzare. Il 21 il duca della
Montagna (o Montagnareale) assume le funzioni di intendente della
provincia, in sostituzione del fuggiasco Mezzasalma ma il suo
potere, reso per giunta alquanto debole dalla mancata collaborazione
dei siracusani, è limitato alla sola città di Siracusa.
I rapporti fra i soldati napoletani e i cittadini, in passato
abbastanza cordiali, si vanno deteriorando progressivamente, provocando
un crescente nervosismo fra i soldati, i quali, non a torto, sospettano
alcuni loro ufficiali di tradire la causa del re. Alcuni soldati,
forse per un equivoco, danno l’assalto alla casa del vice-console
di Malta provocando, il 24, le vibrate proteste di tutti i consoli
stranieri presenti in città. Il Rodriguez cerca di smorzare
la tensione, scontentando tutti, mentre si verificano alcune diserzioni.
In quei giorni Lucio Bonfanti, rientrato a Noto da Catania, dopo
aver constatato l’emarginazione operata dai moderati nei
confronti del suo gruppo, reagisce violentemente e si dà
a percorrere i centri vicini cercando, con scarso successo, di
organizzare il rovesciamento dei moderati, i quali continuano
a rafforzare il loro potere. La situazione si evolve rapidamente
a loro favore: tra la fine di maggio e i primi di giugno i vari
comitati rivoluzionari della provincia riconoscono ufficialmente
al comitato di Noto il diritto di guidare il movimento e, il 31
maggio, Garibaldi nomina il cavaliere Giuseppe Di Lorenzo Borgia
dei marchesi del Castelluccio governatore del distretto di Noto.
Il 2 giugno il generale Nicola Fabrizi sbarca a Pozzallo con un
gruppo di liberali esiliati a Malta e comincia a raccogliere armi
e volontari da inviare a Garibaldi. L’11 arriva a Noto e
vi trova 60 volontari netini che si aggiungono alla sua colonna
e che combatteranno a Milazzo e al Volturno.
Mentre a Noto le cose vanno per il meglio, a Siracusa la situazione
diventa incandescente. I liberali si fanno sempre più aggressivi:
ai primi di giugno organizzano delle manifestazioni che suscitano
le ire dei soldati napoletani, inviano una delegazione a Garibaldi
e si rifiutano di sottostare al duca della Montagna. Il generale
è costretto a minacciare l’uso della forza e, giorno
11, si verifica un fatto assolutamente straordinario: per il timore
di restare intrappolati in Ortigia alla mercé di una truppa
sempre più aggressiva e ostile, quasi tutti i siracusani
abbandonano la città. Circa 8000 si rifugiano a Floridia,
2000 ad Avola e altre migliaia nei centri più vicini. Garibaldi
nomina Antonino Monteforte governatore del distretto di Siracusa
e il comitato provvisorio si insedia a Floridia esautorando di
fatto il duca della Montagna. Il 24 il Rodriguez viene sostituito
dal generale Ferdinando Lo Cascio e il 25 il re di Napoli concede
la Costituzione e tenta disperatamente di riconquistare il favore
dei siracusani trasferendo il capoluogo da Noto a Siracusa. Il
2 luglio arriva in città la notizia dei provvedimenti di
cui sopra ma il 3 i liberali, per tutta risposta, espongono dei
manifesti che contestano apertamente l’autorità borbonica.
Il nuovo generale si comporta con correttezza e moderazione ma
non ottiene nessun risultato, tranne il rientro di parte della
popolazione. A Floridia intanto il Monteforte viene sostituito
da Raffaele Lanza, un altro esule rientrato da Malta.
Il 13 anche Matteo Raeli rientra a Noto e viene accolto trionfalmente.
Il 17 il comitato di Noto spedisce a Garibaldi la considerevole
somma di 1869 onze, frutto di una sottoscrizione popolare, per
sostenere le operazioni militari (altre 623 onze saranno spedite
il 13 agosto). Tutto sembra andare per il meglio quando, il 22
luglio, si registra un tentativo insurrezionale operato dai democratici
netini che tentano di subentrare ai moderati (accusati di malversazioni
varie) alla guida del comitato rivoluzionario. La sommossa è
soffocata sul nascere e vengono operati parecchi arresti. Uno
degli arrestati, tale Vincenzo Càtera, tenta di uccidere
il marchese di Cannicarao: la sera stessa si riunisce la commissione
di guerra che l’indomani, fra gli altri provvedimenti, condanna
alla pena capitale il Càtera.
La sentenza viene eseguita il 25 mattina. L’esecuzione
del Càtera simboleggia tragicamente la completa disfatta
dei democratici che verranno gradatamente emarginati un po’
dappertutto.
Dopo la battaglia di Milazzo (20 luglio) si tratta un armistizio
e, di conseguenza, il 2 agosto i napoletani si apprestano ad abbandonare
Siracusa. L’indomani le operazioni vengono sospese e i siracusani
passano dalla gioia più grande al più nero sconforto.
Le notizie dell’inarrestabile avanzata garibaldina incoraggiano
gli ufficiali filoliberali a venire allo scoperto, minando sempre
più il morale della truppa. Il 24 il duca della Montagna
s’imbarca e lascia per sempre la città; il povero
Lo Cascio si deve sobbarcare ora anche il lavoro amministrativo.
Il 26 la truppa sollecita vivacemente l’indeciso generale
ad assumere energiche iniziative di repressione ma questi rimanda
ogni decisione.
Verso la fine del mese la situazione precipita. Il colonnello
Galluppi assicura i liberali che l’11° reggimento da
lui comandato è pronto a fraternizzare. Il 31 i consoli
stranieri invitano il generale al Comune per trattare mentre il
tricolore sventola sul Duomo.
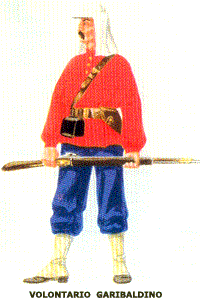 La
La
delegazione siracusana è guidata da Emilio Bufardeci e
da Raffaele Lanza e dimostrerà eccezionali qualità
di astuzia e sangue freddo. In sostanza il generale viene invitato
ad evitare un inutile spargimento di sangue e si riserva di dare
una risposta. All’uscita trova l’11° reggimento
col suo colonnello in testa che distribuisce un manifesto di adesione
alla causa nazionale, mentre una marea di popolo festante inneggia
all’Italia unita e offre gelati e rinfreschi ai soldati
presenti: rientra sconcertato al castello e, l’indomani,
sempre più confuso, torna a incontrare la delegazione cittadina.
Accenna a qualche protesta e, alla fine, acconsente a firmare
la resa a patto di restare comandante della piazza. Il Lanza,
vedendo che ormai il topo è in trappola, lo congeda dicendo
di non avere il potere di assicurargli quanto richiesto. Le truppe
vengono consegnate al castello mentre i rappresentanti del governo
rivoluzionario rientrano trionfalmente da Floridia.
Nel pomeriggio sbarca al porto, proveniente da Napoli, il figlio
del generale con un carico di farina, vettovaglie e denaro e con
la consegna di resistere a oltranza. La sera i siracusani tentano
di entrare nel castello ma trovano l’ingresso sbarrato da
una compagnia di soldati che, armi in pugno, sventano il tentativo.
La notte al castello trascorre molto agitatamente: gli ufficiali,
in maggioranza, propendono per la resa; ma i soldati, in grande
maggioranza vi si oppongono gridando ripetutamente “viva
il re”.
Il 2 Lo Cascio cede e concorda col comitato rivoluzionario la
resa che viene sottoscritta l’indomani. I patti prevedono,
tra l’altro, l’immediato abbandono del castello e
l’imbarco della truppa per Napoli. Quando i 3000 soldati
si recano alla Marina per imbarcarsi, si accorgono che nel porto
c’è solo una nave francese che può ospitare
400 uomini. Il generale, che a questo punto ci asteniamo dal definire,
riporta i suoi uomini al castello che, nel frattempo, è
stato occupato dai siracusani, i quali, armi alla mano, lo respingono:
riporta allora i soldati (che lo accusano di tradimento) alla
Marina e, l’indomani, fa imbarcare  400 uomini sulla
nave francese. Tutti gli altri restano per molti giorni a bivaccare
all’aperto, come tante bestie, sotto la minaccia dei cannoni
dei forti e vengono sfamati dai siracusani che, mossi a compassione,
fanno a gara nel rifornirli di cibo che viene calato in panieri
legati a funi lungo le mura che cingono la città. Questo
miserevole episodio evidenzia efficacemente una caratteristica
della storia d’Italia pre e post unitaria: quella che vede
la gente del popolo quasi sempre umiliata dall’incapacità
e dalla mancanza di dignità di quanti, di volta in volta,
si trovano a esercitare una qualsiasi forma di potere.
Per finire, il 13 settembre, otto bastimenti e due vapori imbarcano
gli sventurati, molti dei quali riaffermeranno la loro fedeltà
al re combattendo al Volturno e anche dopo la fine del regno (in
quell’occasione saranno sbrigativamente definiti “briganti”).
Il 19 l’evacuazione della piazzaforte di Augusta segna la
fine della rivoluzione nel Val di Noto che si appresta a diventare,
da lì a cinque anni, provincia di Siracusa.
Il 21 ottobre si svolge il plebiscito-farsa che sancisce frettolosamente
l’annessione del regno delle Due Sicilie al futuro regno
d’Italia e la contestuale caduta dalla padella borbonica
alla brace sabauda, che si rivelerà ben più scottante
per la grande maggioranza delle popolazioni meridionali.
Bibliografia essenziale: C. Appolloni, “Cu manca
sarà sospettu” in “I Siracusani” n. 56,
agosto-settembre 2005; G. Buttà, “Un viaggio da Boccadifalco
a Gaeta”, A. Berisio Ed., Napoli 1966; C. Gallo, “Il
1860 a Noto” in “Archivio Storico Siciliano”
serie III vol. XI, Palermo 1961; G. Giammanco, “Avvenimenti
netini”, manoscritto ricopiato nel 1881 dal sac. C. Puglisi,
Biblioteca comunale di Noto; E. Papa, “La città dei
fratelli”, Ed. dell’Ariete, Siracusa 1983; S. Privitera,
“Storia di Siracusa”, vol. III, Ediprint, Siracusa
1984 (ristampa).
 Nei primi mesi del 1860 la Sicilia si presenta come una polveriera pronta a esplodere da un momento all´altro. La prima miccia viene accesa nella notte fra il 3 e il 4 aprile, al convento della Gancia, da un gruppo di coraggiosi che tentano di far sollevare Palermo contro l´odiato potere borbonico. L´insurrezione viene repressa prontamente e, una decina di giorni dopo, 13 ribelli vengono fucilati. Tuttavia la rivolta riprende forza nei dintorni di Palermo e apre la strada allo sbarco dei ´Mille´ (Marsala, 11 maggio); questa seconda miccia, a rapidissima combustione, provocherç l´esplosione della polveriera, determinando il rapido disfacimento del regno delle Due Sicilie.
Nei primi mesi del 1860 la Sicilia si presenta come una polveriera pronta a esplodere da un momento all´altro. La prima miccia viene accesa nella notte fra il 3 e il 4 aprile, al convento della Gancia, da un gruppo di coraggiosi che tentano di far sollevare Palermo contro l´odiato potere borbonico. L´insurrezione viene repressa prontamente e, una decina di giorni dopo, 13 ribelli vengono fucilati. Tuttavia la rivolta riprende forza nei dintorni di Palermo e apre la strada allo sbarco dei ´Mille´ (Marsala, 11 maggio); questa seconda miccia, a rapidissima combustione, provocherç l´esplosione della polveriera, determinando il rapido disfacimento del regno delle Due Sicilie.
 A
A  All’alba
All’alba 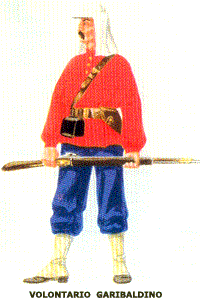 La
La