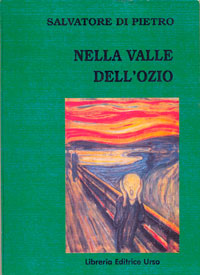Alla fine tutti gli autori presenti si sono trovati concordi sulla necessità di
difendere la libertà di espressione artistica, non potendo accettare di
ricevere da un anonimo ufficio marketing della casa editrice, chiunque essa
sia, l’imput su cosa, quando e come scrivere.
In una calda serata dell’agosto netino poeti e scrittori del Val di Noto scelgono di ribellarsi e viene lanciata la proposta di costituire
Il Gruppo degli
arrabbiati
Perché da
una timida fiammella di rivolta civile possa, un domani, divampare l’incendio
che servirà a riscattare la cultura nel nostro paese. A tal fine rivolgiamo
l’invito a poeti e scrittori, non solo siciliani, che
vogliano portare il loro contributo ad aderire all’iniziativa. A tal fine
preghiamo di volere segnalare i propri dati identificativi, se poeti o
scrittori e il proprio indirizzo e-mail al sito della Libreria editrice Urso di
Avola, una delle poche se non l’unica ancora indipendente.
www.libreriaeditriceurso.com - info@libreriaeditriceurso.com
La
mobilitazione che ci auguriamo di realizzare non ha alcun fine né economico né
di bassa politica ma vuole soltanto risvegliare nell’animo di quei pochissimi
autori, specie di quelli che attualmente si stanno
prostituendo alle regole del denaro, un moto di orgoglio ricordando loro che da
sempre la competizione tra il denaro e la parola ha visto sempre il trionfo di
quest’ultima. Siete, pertanto, tutti invitati a dare la vostra adesione perché
è arrivato il tempo dell’azione.
Tra le azioni da intraprendere da subito ci sono:
Una denuncia: Denunciamo la inattendibilità di tutti i concorsi letterari a carattere
nazionale per la scarsa trasparenza e la possibilità di partecipazione
riservata ai soliti noti.
Un rifiuto: Rifiutiamo le
recensioni e i giudizi dei critici letterari perché, essendo i medesimi sul
libro paga di riviste, giornali e tv, che notoriamente utilizzano le
sovvenzioni della legge dell’editoria per scopi privati, non possono essere ritenuti
obiettivi.
Una richiesta: Invochiamo dalla
politica una legge editoriale che combatta i monopoli e i conflitti di interesse e garantisca a tutti i cittadini la libera
espressione del pensiero.
La cultura non garantisce la ricchezza ma rende la nostra vita degna d’essere
vissuta.
Caro Ciccio e amici tutti,
il problema sollevato da Fulvio Maiello, e da altri ripreso, merita un approfondimento maggiore. Sì, è vero che le grandi case editrici pensano solo agli incassi e i loro critici sono degli scribacchini prezzolati. È vero pure che i concorsi letterari sono delle truffe legalizzate soprattutto quando si esige una cosiddetta tassa di segreteria o per la lettura della opere che nessuno sfoglierà; e poi, ha senso un concorso in cui non esistono dei criteri certi e oggettivi di valutazione? È altresì vero che i libri vengono venduti sugli scaffali dei supermercati o dei centri commerciali e che fanno bella mostra di sé tra dischi, detersivi e cocomeri. Siamo in mano a degli imbonitori culturali il cui unico interesse è quello di fare cassa e di lucrare su opere insignificanti paludate da giudizi critici inconsistenti. E quel che fa più rabbia è che la cosiddetta stampa locale tace su tutto ciò che vera cultura del luogo produce e dà, invece, ampio spazio a un libro banale presentato magari in un contesto scenico accattivante a un pubblico non di potenziali lettori, ma di persone invitate per far numero e accrescere così la sontuosità e l’importanza dell’evento. E sì, la presentazione di un libro viene considerata come un evento! Nessuno pensa alla fatica dell’autore che, parola dopo parola e pagina dopo pagina, ha dato corpo alle sue idee e alla sua visione del mondo o delle cose. Un libro, come qualsivoglia opera dell’arte umana, rappresenta l’esito finale del lungo travaglio dell’autore che rifugge ogni tentativo di classificazione critica, di commercializzazione e di confronto concorsuale. Ogni autore è un essere unico e irripetibile e le sue opere sono, come lui, uniche e irripetibili, non confrontabili, né monetizzabili. Chi scrive o si dedica a qualunque opera artistica o non divulgativa lo fa in primo luogo per se stesso e non per avere gloria o riconoscimenti.
L’otium e il negotium
…
Per chi come lui è amante della lettura, e fa del leggere, non un piacevole intrattenimento, ma un’abitudine radicata, una libreria rappresenta il porto d’approdo dopo lo stanco navigare tra i flutti perigliosi e tempestosi della futile e inutile quotidianità. Entrarono e, immediatamente, rimasero sbigottiti dalla spropositata estensione del locale. Si trattava di un negozio di almeno trecento metri quadrati. Le luci multicolori mettevano in risalto le ultime pubblicazioni. Lui cominciò il tour culturale attraverso le innumerevoli copertine esposte come su uno scaffale da supermercato, con relativi prezzi e sconti, e subito si reso conto che in quella libreria c’era tutto, di tutto un po’, ma in effetti non c’era nulla, niente che potesse interessarlo. Copertine variamente colorate, titoli altisonanti, innumerevoli pagine che avevano il precipuo scopo di intrattenere il probabile, o improbabile, lettore con vacue sciocchezze insaporite di fragorose espressioni verbali che, a loro volta, avevano il preminente compito di non dire assolutamente nulla. Una libreria per i lettori del nulla che si abbandonano a frivole elucubrazioni, leggendo magari la trama dell’ultimo romanzo alla moda in qualche rivista, per poter dire che leggono, che sono a conoscenza di tutto e sono soprattutto delle persone colte. Ma la cultura non è né la vana ostentazione del sapere fine a se stesso né il cibreo parolaio, fatto di significanti senza significato, che ritiene di poter contribuire a chiarire le più svariate questioni di lana caprina. La cultura è ben altro, vola più in alto fino a raggiungere le alte mete della conoscenza per poi ridiscendere e affermare che chi pensa e conosce è ed esiste. Inoltre l’uomo, che fa della cultura il suo modo di esistere, non rimane isolato in se stesso, è naturale che si apra agli altri e faccia di sé, come scriveva Albert Camus, l’homme solitarie qui devient solidaire, ovvero l’uomo solitario che diventa solidale. Sua moglie, anche lei del tutto disinteressata alle banalità messe in bella mostra, comprò un piccolo manuale di giardinaggio, quasi un obolo doveroso da versare nelle casse della splendida magnificenza della cultura, mentre lui diede un’occhiata alle pubblicazioni economiche inerenti gli autori francesi e inglesi. Nessun titolo attrasse la sua curiosità, si trattava di libri noti che aveva già letto e che possedeva. E sì, perché per leggere un libro era necessario che fosse suo, non riusciva a leggere un libro passatogli da qualche altra persona o preso in prestito dalla biblioteca comunale. Conservava da sempre l’abitudine, leggendo, di sottolineare le frasi salienti che lo attiravano, di appuntarle in un notes e poi trascriverle al computer. La qual cosa era abbastanza agevole visto lo spazio esiguo del suo studio che gli permetteva di tenere i libri a portata di mano, in modo da poter rileggere tutto ciò che aveva evidenziato a una prima lettura. Uscirono stanchi, ma soprattutto annoiati, dalla libreria e decisero di fare un giro nel centro storico della città vecchia. …
Immediatamente la sua attenzione fu attirata da un negozietto quasi mimetizzato tra le brutture degli edifici dissestati, quasi in disfacimento e sicuramente poco curati. Un’insegna scolorita lo incuriosì: Leggenda. Invitò sua moglie ad avvicinarci alla vetrina e subito si resero conto che i libri esposti, pur nella luce crepuscolare del pomeriggio che scemava per lasciar posto alla sera, sembravano brillare di un chiarore proprio. Si trattava di testi scritti da autori del luogo che mettevano in risalto il dialetto e la cultura calabrese; c’era persino la traduzione della Divina Commedia di Dante Alighieri o Allighieri. Attratti da tanto ben di Dio, non si accorsero neppure che la porta, con un cigolio incredibile, si aprì e un signore anziano li invitò a entrare. Lo seguirono, imitando quasi il suo andamento claudicante - visto che si sosteneva appoggiandosi ad una stampella - ed entrarono nel suo regno. Descriverne l’interno è un compito immane in quanto il negozietto, di un’ampiezza ridicola, forse tre metri per tre, era un insieme di mensole e scaffali ricolmi di libri e pubblicazioni varie. Ci si muoveva a stento nella semioscurità del locale; pur tuttavia, con grande fatica, riuscirono a sedersi davanti a un tavolo, anch’esso ricolmo di libri. Dall’altra parte stava un uomo, come detto prima, anziano. I radi capelli imbiancati conferivano al suo volto la parvenza di un santo pronto a benedirli, mentre i suoi occhi vispi, di un colore indefinibile, descrivevano loro il precoce invecchiamento della sua vita travagliata tra la solitudine impostagli dagli uomini e dal mondo e la compagnia offertagli dai libri. Gli chiese immediatamente come facesse a vivere e a passare il suo tempo in quel luogo angusto, o quantomeno poco spazioso. Le parole della risposta che ottenne lo lasciarono di stucco: Sicuramente la vita merita di essere vissuta, altrimenti non avrebbe senso continuare a dibattersi in un limbo di pulsazioni estenuanti, mai proficue o determinanti, e senza un fine ben prefissato. La vita va vissuta vivendo il tempo che passa e non passando il tempo nell’attesa di un evento che sia in grado di attenuare la noia mentale a cui fatalmente ci abbandoniamo. Notando il suo sbigottimento, forse per farlo sentire più a suo agio, chiese loro da dove venivano e, sentendo che erano siciliani e in modo particolare netini, frugò tra i libri e i fogli che ingombravano il suo tavolo-altare e tirò fuori un librettino impolverato a cui mancavano soltanto le ragnatele. Sfogliandolo delicatamente e con devozione, così come un prete sfoglia il messale, mostrò loro una poesia su Noto, o meglio sul moscato di Noto, scritta da un autore che non conosceva. Lo invitò a leggerla e subito dopo gli disse che lui, attraverso i libri e la lettura, conosceva il mondo, pur se claudicante e restando rinchiuso nel suo negozio. Ancora una volta rimase stupito dal suo modo di parlare e di porsi nei confronti dei suoi interlocutori. Ci fu un attimo di silenzio e ne approfittò per alzarsi e dare un’occhiata ai libri sistemati sugli scaffali. Non fece in tempo a leggere alcun titolo che subito fu richiamato dal libraio che lo esortò a non perdere tempo a cercare qualcosa di interessante. Mentre parlava, continuava a rovistare tra le sue carte ed infine gli porse un certo numero di fogli fotocopiati che recavano i versi di autori a lui totalmente sconosciuti. Con una voce improntata a una certa bonarietà, quasi con paziente indulgenza, gli disse che era inutile cercare tra i libri esposti le pagine più belle da leggere, era un lavoro insignificante, o quanto meno superfluo, in quanto l’aveva già fatto lui, e le pagine che gli offriva rappresentavano il florilegio o, ancor meglio, la crestomazia del pensiero poetico dell’uomo. Non poteva non accettare, per cui allungò la mano per ricevere quel dono inaspettato e gli chiese quanto doveva pagare per le fotocopie. Non l’avesse
mai fatto, l’uomo, con uno scatto improvviso, si alzò dalla sedia e, con voce
indignata, esclamò: In tutta fretta prese i fogli, lo ringraziò e invitò sua moglie ad andar via. Uscirono che fuori era già buio e, nella luce fioca emanata dai pochi e radi lampioni sparsi per la piazza, si rese conto che non aveva capito nulla della vita. Era bastato un semplice incontro, magari imprevisto e del tutto casuale, con una persona del tutto sconosciuta, ma pregna di buoni propositi, per fargli capire che la vita non è l’esistenza volta al guadagno e al profitto, ma l’accettazione dell’essere così come siamo, piuttosto che il cercare di ottenere l’avere che non possediamo e di cui non potremo mai essere padroni.
In linea di condivisione e partecipazione di idee e di pensiero a quanto afferma Fulvio Maiello nella nota "Il gruppo degli arrabbiati", inserita ed inviata nell' ultima mail della Libreria lascio qui i miei dati personali, sperando di aver colto il msg insito nello scritto... Mi capita spesso, quando vado a Firenze, di passare da via San Gallo dove un tempo c'era la storica libreria Le Monnier e vedere che oggi è stata fagocitata ed inglobata da quella grande editoria di potere chiamata Mondadori... e non entrare e non soffermarmi più come una volta tra gli scaffali, le pile di libri o presso il bancone di legno... anche a ragionare col personale... come non mi è più possibile aggirarmi nei corridoi della Marzocco con quel suo bel leone rampante o del Marzocchino, libreria specializzata in editoria per ragazzi e in quella per insegnanti, situate entranbe lì in via Martelli nel cuore della Fi antica e adesso soppiantate da "altri" esercizi commerciali...come non mi piace più sedermi ad un tavolo all' interno del locale "Le giubbe rosse", sorseggiando come una volta del the e sfogliare qualche pagina di libro proprio lì dove un tempo si riunivano i nomi che hanno fatto la storia della letteratura italiana, fondando anche riviste culturali di pregio e lo stesso D. Campana cercava disperatamente di vendere i suoi "Canti Orfici". Lucia Bonanni |
|---|
|
Quanto scrive Fulvio Maiello in “Gli
arrabbiati” è, a mio credere, un ottimo spunto per aprire un dibattito che
possa mettere a confronto queste due questioni, editoria e cultura, che
sembrerebbero costituire un binomio inscindibile, ma che sono, in realtà, due
questioni affatto diverse.
E così le pone, in fondo, anche Maiello,
pur se, a me pare, oscuri un po’ la primarietà della cultura rispetto
all’editoria, ponendo su questa più aspettative di quelle che può darci, anche
se c’è del vero nelle colpe che imputa agli editori.
L’amico Fulvio sembra non tener conto
del tempo che viviamo, tempo dominato dal mercato, divenuto una sorta di moloch
universale (a altri piacerà meglio globale), a cui tutto va sacrificato.
Viviamo, oggi, in una società mercantile alla quale uniformiamo la nostra
mentalità, la nostra cultura, la nostra logica, il modo di vivere, i rapporti
umani, ogni nostra manifestazione vitale.
Ora, a questa ‘Weltanschauung’ non
possiamo pretendere, per quanto augurabile, che potesse sfuggire l’editoria,
nei cui fini neanche lontanamente rientra quello di promozione culturale del
popolo. L’editore è un imprenditore che deve fare affari e denaro. Niente di
più! Un’azienda editoriale non pubblica libri perché la gente possa arricchire
la propria cultura, emanciparsi culturalmente sempre più, ma perché possa
nutrirsi del nutrimento che loro vogliono fornire, in ossequio alla concezione
di vita che deve essere mantenuta: il dominio della finanza e del mercato sul
mondo intero, e un potere politico asservito a tale dominio.
Non per niente è dominante nelle grandi aziende editoriali la
figura dell’editor, esperto non culturale, ma di mercato, il quale studia i
sondaggi d’opinione attraverso i quali prima vengono convinti i potenziali
lettori a farsi piacere ciò che a loro conviene che piaccia (persuasione
occulta, la chiamò Marcuse), e, poi, su quei sondaggi modellano i libri che
decidono di pubblicare, soltanto perché meglio si prestano ai loro stravolgimenti con quelle operazioni dette di editing,
consistenti in tagli modifiche aggiunte fino a farne ciò che loro hanno voluto
che il lettore vuole.
E l’editore fa i suoi affari, che è ciò
che veramente gli interessa. Egli è, in pratica, perfettamente conforme agli
ideali di questa società.
Mi sembra altrettanto vero (risulta
anche a me), ma anche più assurdo, invece, l’altro argomento contro il quale
Maiello sfoga la sua “rabbia”. Mi riferisco a quello dei librai che non accettano
per la vendita libri stampati dai piccoli editori o in proprio dagli autori, e
se li accettano, chissà per quale ‘magnanimità’, li tengono per un po’ di tempo
nascosti e poi li restituiscono, rifiutandosi, persino, di venderli a qualche ‘aspirante’
acquirente che glieli chiede. Ciò che appare incomprensibile, irrazionale, per
non dire stupido, fuori della loro stessa logica di librai, che stanno lì per
vendere libri e, quali che essi siano, vendendoli, accrescerebbero comunque i
loro introiti.
Pertanto, il problema è molto più arduo e
più ampio di come prospettato da Fulvio Maiello, e necessita che si punti
sull’altro corno della questione: sulla cultura, cioè, e non sulla ‘cultura
negata’ di questa nostra società e di questo nostro tempo dominati dalla
sottocultura del denaro, dell’arricchimento, della sovrapproduzione, di tutti
quei disvalori, ci ricorda Lucia Bonanni nel suo intervento, ai quali, ancor
più i giovani vengono indotti, gabellandoli, magari, come i nuovi valori del postmoderno.
Viene così a essere eclissata la vera cultura, che è conoscenza del lungo
cammino dell’uomo; che è promozione di ricchezza interiore; che è acquisto
della capacità di godere del bello; che dà sentimenti elevati. Cultura che non
interessa più il mondo mercantile del produrre vendere arricchirsi; né i
traffichini della politica, che per mandato di quel mondo, amministrano la cosa pubblica.
Lamenta, l’amica Anna Maria Folchini
Stabile l’assenza, oggi, di quei libri per ragazzi che educarono le nostre
generazioni ai buoni sentimenti, agli ideali di apertura e rispetto dell’altro,
a sentire ciò che l’altro ha da dirci (questo, in fondo, è, anche, la cultura);
a vedere nell’altro un nostro eguale, quale che sia il colore della sua pelle o
il suo modo di vivere. Sì, hai ragione, cara amica, ma in questa sottocultura
dominante non c’è spazio per questi valori e per quei libri che tu ricordi, e
che hanno fatto di noi quel che siamo. Perché tutti siamo il prodotto di ciò di
cui ci nutriamo. E noi siamo il prodotto di quell’humus nel quale vivemmo. E
qual è quello dove oggi si vive? Quale può essere l’humus culturale in un paese
dove ci sono governanti che considerano la prima istituzione culturale, la
scuola, soltanto come causa di spesa passiva e improduttiva, perciò si riduce
costantemente il numero degli insegnanti, si chiudono scuole e classi; dove si
sopprimono (allo scopo c’è pronto un decreto), istituzioni di riconosciuto
prestigio internazionale come l’Accademia della Crusca, e l’Accademia dei
Lincei; dove diminuiscono le pubblicazioni.
E, ancora, un paese dove le biblioteche
comunali, gli stessi musei, le pinacoteche, i teatri, gli auditorium continuano ad avere una funzione
marginale per la diffusione della cultura, mentre potrebbero e dovrebbero essere
centri propulsori di cultura attiva; potrebbero e dovrebbero diventare
laboratori culturali e artistici, aperti a molteplici iniziative di incontri
culturali su iniziativa di queste stesse istituzioni o di iniziativa di
associazioni o gruppi di liberi cittadini.
Ritengo questi modi, né tutti, né i soli,
ovviamente, atti a promuovere una politica di espansione culturale intesa, anche, a elevare gli
interessi e i ‘gusti’ letterari e artistici, e a spingere in avanti tutta la
società determinando, in definitiva, anche l’evoluzione dell’editoria verso una
diversa politica editoriale.
In carenza di queste condizioni, a me
pare, che quanti siamo consumatori e amanti di cultura non possiamo far altro
che autoinvestirci di una funzione vicaria delle istituzioni pubbliche culturali
più o meno assenti, e farci, oltre che fruitori, anche, ‘propagandisti’ e organizzatori
di eventi culturali.
Al di là di questo non saprei cos’altro
proporre.
|