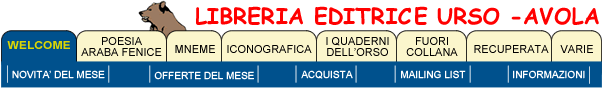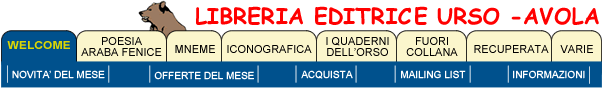...penso a tutti quelli che di qui sono passati
e che hanno toccato queste pietre...
Oggi 21 gennaio 2012 è morto lo scrittore Vincenzo Consolo, dopo lunga malattia, all'età di 78 anni.
Vincenzo Consolo amava la Sicilia e gli piaceva tornare a visitare la città greca di Eloro (attorno a cui ci ritroviamo spesso un po' di amici a chiacchierare, e filosofeggiare, ogni seconda domenica del mese).
All'amico Sebastiano Burgaretta, che l'accompagnava in una di quelle visite, espresse così questo suo attaccamento alla sua terra d'origine: "Io non so che voglia sia questa, ogni volta che torno in Sicilia, di volerla girare e girare, di percorrere ogni lato, ogni capo della costa, inoltrarmi all'interno, sostare in città e paesi, in villaggi e luoghi sperduti, rivedere vecchie persone, conoscerne nuove".
E l'amico Burgaretta in quella occasione sospettò che qualcosa stesse per avere un termine, al sentire quelle parole, tant'è vero che scrisse queste parole nell'articolo seguente: "...sia questo una sorta d'addio, un volerla vedere e toccare prima che uno dei due sparisca".
Lo avevamo avuto nostro ospite nel salone comunale di Avola per la presentazione di un suo libro (io e altri amici di "Avola in laboratorio"; ci autotassammo per consentirgli di venire fra noi, praticando con onore il cammino duro e sempre in salita di uomini liberi dal potere e dall'assistenza clientelare...).
Ricordo ancora con piacere la sua visita alla mia libreria e non dimenticherò il modo garbato di come si rivolse a me, il suo inchino (che non ebbe nulla di rumoroso, o fuori misura, a proposito di altri inchini, che a tanti disastri spesso portano).
Dopo la morte di Sciascia e Bufalino, un altro grande se n'è andato. Siamo ancora una volta più poveri...
Francesco Urso
| Alle soglie
del "témenos" |
di Sebastiano
Burgaretta
Un racconto quasi sommesso, che
emoziona, dando l'impressione d'esser lì, nascosti dietro ad un
carrubo, a spiare i "due amici" impegnati nella loro ricerca della memoria
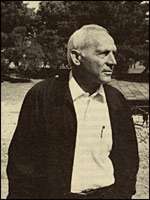
In uno degli innumerevoli ritorni in
Sicilia, tra quelli ispirati dal "desiderio di conforto, d'amici costanti
lungo il tempo", capitò, nel cuore di un'estate torrida, che Vincenzo
Consolo si spingesse ancora una volta fino alla plaga ubertosa dell'Eloria
Tempe, alle soglie del "témenos", del recinto sacro a Demetra.
Durante il tragitto in automobile,
lungo il segmentato intreccio dell'antica via Elorina con le moderne strade
provinciali di campagna, l'amico che l'accompagnava, di tanto in tanto,
rompeva il silenzio, per dare indicazioni e spiegazioni sui particolari
naturalistici e storici del territorio via via attraversato. Lo scrittore
assentiva, chiedeva qualche chiarimento, domandava, sempre in tono sommesso
e con riferimenti precisi. Fotografava ogni cosa, in immagini e pensieri,
nella sua mente. Da nessuno mai è stato visto scrivere appunti
nel corso di visite o escursioni. Probabilmente la memoria gli ha sempre
consentito di rimandare l'urgenza dello scritto al momento solitario del
confronto serale col taccuino.
In campo non si concede distrazioni,
non perde alcunché di ciò che vede. Osserva, scruta, registra,
conserva; nulla si lascia scivolare via, tutto invola con ansia conoscitiva
sempre nuova.
Lungo il pendio leggero che immette
nella vallata amena l'amico gli indicò un gruppo di cinque o sei
piante secolari, le cui fronde lambivano il terreno. "Son carrubi! Disse
di colpo lo scrittore. Fermiamoci un momento. Da molto tempo non prendo
in mano e non mangio una carruba". Fermata l'automobile al bordo della
strada, nel silenzio totale di quel luogo, i due violarono il limite del
campo, ch'era senza recinzione. A pochi metri sorgevano, custodi di memorie
senza tempo, gli immensi carrubi, sotto il primo dei quali Consolo entrò,
chinandosi, seguito dall'amico. Sparsi, qua e là in cerchio sul
tappeto soffice di foglie, stavano grosse pietre calcaree squadrate, disposte
a mo' di ceppi con funzione di sedili preparati, in tutta evidenza, dai
gitanti domenicali, di quelli che cercano riparo dal solleone nell'ampio
ventre di questa pianta ricca di foglie coriacee e larghe. Allungato un
braccio, lo scrittore staccò una carruba da un ramo. Prese a tastarla,
carezzandola quasi col movimento delle dita contro il cavo della mano.
L'amico ne colse due e porgendogliele
disse: "Sciabbuli son dette queste al mio paese. Quelle piccole e ricurve
si chiamano jacuna". Si chinava nel frattempo Consolo, a raccogliere dal
tappeto di fogliame due carrube giacenti al suolo asciutte e rinsecchite.
"No, no, basta così. Non prenderne più. Bastano queste",
rispose, addentandone una e avviandosi a lasciare l'ombra protettiva dell'albero
secolare. Pochi minuti di macchina e furono alla meta di quel giorno:
la città greca di Eloro, dove lo scrittore tornava volentieri.
Dai ruderi del tempio della Madre risalirono
lungo le mura a settentrione, penetrando nei recinti cosparsi di cocciame,
tra i conci fatti luminosi dalla luce solare meridiana.
Era un giorno dell'estate malinconica
che l'uomo delle Chesterfield viveva a Milano, in via Solferino, accogliendo
nella casa amica, con pazienza senza fine, gli amici che andavano a trovarlo.
Era in pena Consolo per lui, e nel silenzio preferiva sciogliere il dolore,
lui che pure in pubblico si affida alla parola salvifica, alla parola
che esprime i sentimenti, alla parola tagliente che redime la memoria
degli uomini. Precedeva l'amico di pochi passi, lentamente avanzando tra
le pietre. Era assorto, isolato a tratti nei pensieri. Si chinava qua
e là a toccare i conci, seguendone con le dita della mano le pieghe
modellate dal piccone e levigate dal tempo.
Il tocco attento finì, a un
certo punto, per risolversi in carezza delicata e perdurante della mano.
Il viso poi, rosso per la commozione, trattenne malamente la pressione
di una lacrima al ciglio inumidito. Qualche minuto dopo, fuori dal recinto,
infranse quel silenzio debordante oramai verso il rito: "Scusami, disse,
se mi sono emozionato. E' che penso a tutti quelli che di qui sono passati
e che hanno toccato queste pietre…".
Finché raggiunsero la macchina
i due più non proferirono parola. Da solo a casa, poi, l'amico
corse a rileggere quanto l'uomo aveva scritto un anno prima: "Io non so
che voglia sia questa, ogni volta che torno in Sicilia, di volerla girare
e girare, di percorrere ogni lato, ogni capo della costa, inoltrarmi all'interno,
sostare in città e paesi, in villaggi e luoghi sperduti, rivedere
vecchie persone, conoscerne nuove".
Una voglia, una smania che non mi lascia
star fermo in un posto. Non so. Ma sospetto sia questo una sorta d'addio,
un volerla vedere e toccare prima che uno dei due sparisca.

Vincenzo Consolo con Sebastiano Burgaretta

Vincenzo Consolo con Benito Marziano
(…)Nell’agosto del levante secco, del turbine africano, entra più addentro nell'abbaglio, nell'intaglio della pietra, nel cuore del calcare, nel seme della mandorla, dal tavolato delle gazze e delle erbe, dai casali, dai conventi abbandonati, dai cigli degli abissi, delle cave tortuose e risonanti, discende sulla piana dell'arsura, dei tufi, delle sabbie, solcata dal Cassibile, dal Tellàro, si muove fra mezzo a muri a secco, tumuli, capanni pastorali, edicole di santi (e tu nell'ombra, nel nero delle lave, nella perdita, nella fissità del tempo, e tu per sempre nella dimora sigillata). Pendono dai rami intorno alla nicchia di san Sebastiano, oscillano lievi, si stemperano nel sole le tunichette rosse del voto, gli abitini della devozione. Nella festa di maggio issano i bambini erniosi, nudi e strillanti, sopra il fercolo del santo. Viene il culto da Melilli, si spande la passione per il languido soldato a Palazzolo Acreide, Francofonte, Feria, Avola, per tutto il Val di Noto; in onore del giovane infrecciato corrono nella notte i nudi con nastri sanguigni ai fianchi, sul petto, portano in mano fiori, ceri, comprano nella fiera tamburelli.
Si muove tra i fitti filari di mandorli, fra l'oro delle foglie, dei malli sparsi a terra. Si muove sulla strada dove avvenne in un dicembre ormai lontano l'eccidio dei braccianti.
Su quella statale centoquindici, su quel terreno della Chiusa di Carlo, all'improvviso sparò e sparò la polizia contro i lavoratori scioperanti per il rispetto dei contratti, contro l'ingaggio di mano d'opera in piazza, la prepotenza di padroni e caporali. Saltarono i muretti, corsero per la campagna dell'inverno, sotto i rami spogli, caddero morti a terra Scibìlia e Sigona, caddero i feriti.
Avola del terreno arso, del mandorlo, dell'ulivo, del carrubo, della guerra con il sole, con la pietra, la città nuova di geometrica armonia, di vie diritte, d'ariose piazze, d'architettura di luce e fantasia, Avola dei liberi braccianti era adusa alle proteste, alla lotta per la difesa dei diritti: nel Venti i soci di cooperative e leghe occuparono il feudo Stradicò della marchesa di Cassibile, nel Ventidue si scontrarono coi fascisti, nel Ventiquattro distrussero gli uffici daziari...
La vasta piazza quadrata, il centro del quadrato inscritto nell'esagono, lo spazio in cui sfociano le strade del mare, dei monti, di Siracusa, di Pachino, fu sempre il teatro d'ogni incontro, convegno, assemblea, dibattito civile, la scena dove si proclamò il progetto, si liberò il lamento, l'invettiva. È fuori dagli agglomerati secolari, dagli intricati labirinti, dalle viuzze scoscese e serpeggianti, dalle fabbriche ammassate, dalle piazze anguste, dai muri gonfi d'umidore, crepati per vecchiezza, dalle eredità paralizzanti, dalle ipoteche umilianti, è dentro gli spazi piani e razionali, nelle misure d'Archimede e di Cartesio, è nella chiarità solare, è nella luce di ragione il tempio di Democrazia? Un tempio umile, paesano, di tufo luminoso, simile nell'idea, nella sostanza a quello nobile dello Sposalizio di Raffaello, della Prospettiva attribuita a Piero, è stato forse al centro di questa rara Avola in Sicilia, di quest'Apicola soave e laboriosa, di questo nuovo paese ricostruito al piano dopo il terremoto, di questa vittoriniana città del mondo che dalla bellezza trae giustizia e armonia.
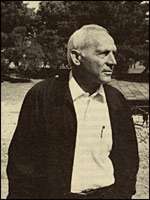 Vincenzo Consolo, in “L’olivo e l’olivastro”, capitolo XIII Vincenzo Consolo, in “L’olivo e l’olivastro”, capitolo XIII |
|