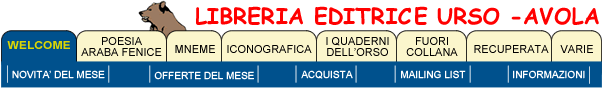

|
 Stella
Giovanni, Una
Vita. Opere (1989-2003) (Libreria
Editrice Urso, Collana Omnia 1), 2003, 16°, pagine 1312, € 22,00 – 978-88-6954-255-8
Stella
Giovanni, Una
Vita. Opere (1989-2003) (Libreria
Editrice Urso, Collana Omnia 1), 2003, 16°, pagine 1312, € 22,00 – 978-88-6954-255-8
Una
Vita
L’ultima opera di Giovanni Stella, Una Vita (Libreria Editrice
Urso, Avola, 003), non ha bisogno di presentazioni per chi conosce
l’autore, le sue precedenti iniziative letterarie e, soprattutto,
l’uomo. Il senso dell’odierno, immane lavoro reca un sentimento
intuibile già dalle prime pagine.
L’opera racchiude tutte le precedenti e ne contiene delle inedite,
sia in forma poetica sia in prosa, con note critiche di autori vari
in appendice. Un lavoro immane, per l’appunto.
Dal canto della poesia Stella rivela una personalità sensibile,
capace di cogliere dalla realtà la sua musa ispiratrice. L’animo
poetico si enfatizza e ne resta influenzato sotto le spinte propulsive
del realismo quotidiano, mentre i significati allegorici ne costituiscono
l’essenza principale. La poesia diventa così una realizzazione
dell’animo dove i componimenti vengono alla luce con la sensibilità
del cuore piuttosto che con la superbia dell’intelletto. La predisposizione
d’animo, funzionale al concepimento poetico, si materializza
in un significato che porta il lettore ai tempi di innamorata gioventù.
Ma la personalità poetica di Stella è intrisa anche
di significati complessi che riflettono la sua stessa dimensione di
uomo: la vita come inizio, il modo di viverla, la morte come fine,
come ignoto, il mondo siciliano e la stessa Sicilia, appaiono come
costanti nelle sue opere.
Non di rado è ravvisabile una punta di pessimismo: forse non
si esagera nell’affermare che siamo quasi in presenza di un pessimismo
leopardiano cagionato, chiaramente, da eventi e sentimenti esistenziali
differenti.
Nelle opere in prosa, invece, siamo in presenza, tra le altre cose,
di una dolce nostalgia del passato dove più sentiti erano i
valori, basati sulla normale quotidianità di paese: nel “Museo
della memoria” (opera inedita), per empio, è tangibile
questo sentimento. È un invito al ritorno a quelle piccole
gesta che facevano l’identità dei luoghi e delle persone
che li vivevano; ma al tempo stesso vuole essere una critica all’odierna
società in cui proprio quelle piccole cose si sono smarrite
e con esse l’identità della comunità.
L’opera in prosa presenta anche una peculiarità intrinseca:
contiene forse un inconsapevole contenuto antropologico, credo importante
per chi volesse tra qualche ventennio e più intraprendere studi
sul modo di vivere dei siciliani e degli avolesi in particolare.
Complessivamente Stella risente della influenza di Gesualdo Bufalino,
suo insigne e preferito autore. Al pari del comisano scrittore e poeta,
anch’egli mette in discussione tematiche di rilievo: la memoria,
la Vita e la Morte, l’esistenza o meno di Dio, anche se in Stella
quest’ultimo elemento, ancorché riscontrabile nella complessità
dell’opera, è forse meno manifesto; gli ossimori, poi,
ne fanno anche qui un tratto caratteristico.
La differenza, tuttavia, la si coglie nel modo di approcciarsi con
la scrittura: Bufalino, come lo stesso Stella ha riferito, è
un cesellatore della parola, un orafo della lingua italiana; Stella,
invece, adotta un linguaggio marcatamente allegorico, ravvisabile
soprattutto nella poesia, a tratti forse anche scontato e prolisso,
ma ciò trova la sua giustificazione nel fatto che il modo di
scrivere di Stella risponde ad una necessità, l’immediatezza.
E pur di raggiungerla, pur di non avere incertezze circa la sua destinazione
verso il lettore, pur di colpire il lettore Stella preferisce essere
prolisso ed allegoricamente scontato. Ritengo sia un pregio oggigiorno
per i poeti e per gli scrittori in genere: la lettura e, soprattutto,
la sua comprensione diventa fruibile per tutti e non solo per gli
“addetti ai lavori”.
Tuttavia, il libro di Giovanni Stella pur essendo in commercio non
è stato concepito per la vendita: è un libro che quasi
“corrompe” il lettore, lo corteggia, soprattutto le opere
inedite, fino a farlo uscire dal guscio morale che lo circonda. In
questo caso una particolare predisposizione d’animo è
importante se non addirittura necessariamente richiesta.
<<Una
vita>> di Giovanni Stella per lavarsi il cuore scrivendo
E’ una fotografia dall’alto di
Avola e delle sue tradizioni, ma non solo, il nuovo libro di Giovanni
Stella, edito dalle stamperie di Ciccio Urso, col titolo “Una
Vita”. La tela sulla quale il letterato avolese dipinge fatti,
personaggi e sensazioni è molto ampia, poiché abbraccia
circa mezzo secolo di notti insonni, trascorse con le proprie emozioni
e la “montblanc” nervosamente rigirata tra le dita.
Il “tomo”, quasi milletrecento linde pagine in bilico
tra poesia, prosa e pittura, parte dalle prime opere giovanili del
’67, chiamate Miraggi, snodandosi fino alla completa maturità
letteraria dei nostri giorni.
Nutritosi alla poesia di Jacques Prévert, da un lato, ed
“all’amaro miele di Gesualdo Bufalino”, dall’altro,
Giovanni Stella ha saputo fornire una unità d’insieme
in un unico testo, raccontando non una sola vita, ma disegnandone
molteplici. L’autore ha definito Avola come ”il posto
delle fragole”, l’isola che alimenta la sua “isolitudine”,
eppure non si è limitato ad essa. Dall’inchiostro nero
della sua stilografica traspare l’amore per Parigi, Roma, ma
soprattutto per i personaggi della Sicilia. Risaltano, ad ogni passo,
le figure dei suoi più cari amici del luogo, come “Ciccio
e Liliana Urso”, paragonati a dei novelli Renzo e Lucia all’interno
dell’opera.
Copiose le informazioni di cronaca dei sentimenti fornite da “Una
Vita” trascorsa a “lavarsi il cuore scrivendo”.
Un filo rosso unisce le sue prime liriche, permeate da un “senso
dolente della vita” ed i quadri descrittivi dell’Osteria
Margutta, dei “Momenti Parigini” e dei “Pomeriggi
Veneziani”, in una serenità di fondo dell’autore,
sempre proteso al ritratto del sogno e dell’inconscio. Poi
di nuovo Bufalino, “quel comisano che gli era entrato nella
testa e nel cuore”, rimanda ad una concezione negativa della
vita, superata ancora una volta in momenti di serena contemplazione
del territorio.
Le altre fasi della sua evoluzione passano attraverso titoli che
rievocano la terra: “Datteri verdi”, “Gusci di Mandorle”,
“Foglie secche”, “Lapilli”, “Cinquantesimo”,
“L’Approdo Felice”, “Edera” e “Timo
degli Iblei”, dove nella lirica intitolata “11 Settembre”,
l’autore descrive lo sgretolamento “dell’effimera
certezza di un occidente opulento”.
Nella sezione dedicata alla prosa, si fa subito sentire, tonante,
la voce di Nunzio Bruno, il floridiano di “Cozzu ‘Zu Cola”,
dai lunghi e ricciuti capelli che reclamano da tempo uno sciampo”.
Paragonato ad un “clochard” parigino con una limpida ricostruzione
scenica della sua personalità artistica, della sua genialità
mista ad improvvise rudezze e della sua “anarchia” indissolubilmente
legata a momenti di intensa generosità, Nunzio, ama ripetere
Giovanni Stella, è uno degli uomini di una Sicilia che lentamente
scompare, ma che tuttavia “sopravvive in uomini come Ciccio
Urso, Sebastiano Burgaretta e Vincenzo Consolo”.
Dopo “Le Sirene e l’Isola”, cospicua è la
galleria di ritratti fornita da un altro periodo della prosa di
Stella, e cioè “Amici Cari”.
Qui troviamo i ricordi paterni, ma anche le amicizie costruite durante
anni di esercizio professionale, come quelle con Ettore Randazzo,
“sempre in attesa di un volo in partenza” o del giurista
Titta Madìa, senza dimenticare Piero Filloley, il letterato
netino Salvatore Salemi, o il siracusano Corrado Piccione. La seconda
parte del testo comprende gli scritti nominati “Il rigattiere
e l’avventore”, il “Museo della Memoria”, le
“Lettere” e la “Pulce al libro”, sempre catalizzatrici
della attenzione del lettore, mediante uno stile efficace ed allo
stesso tempo prezioso.
Da non mancare, quindi, questo appuntamento con la cultura del nostro
tempo, che l’opera di Giovanni Stella ha cercato di affrescare,
assecondando il suo “vizio impunito dello scrivere”, necessario,
a suo avviso, per cercare la verità e per mentire, per persuadere
e sedurre, per conoscersi e per sapere chi siamo, come amava ripetere
Gesualdo Bufalino.
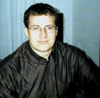 Roberto
Rubino
Roberto
Rubino
 Stella
Giovanni, Una Vita. Opere (1989-2003)
(Libreria
Editrice Urso, Collana Omnia 1), 2003, 16°, pagine 1312,
€ 22,00
Stella
Giovanni, Una Vita. Opere (1989-2003)
(Libreria
Editrice Urso, Collana Omnia 1), 2003, 16°, pagine 1312,
€ 22,00
Libreria
Editrice Urso
Corso
Garibaldi 41 96012 AVOLA (SR) ITALIA
e-mail info@libreriaeditriceurso.com
sito internet https://www.libreriaeditriceurso.com
Dal
1975 un angolo di cultura ad Avola
Welcome
| Poesia Araba Fenice
| Mneme | Iconografica
| I quaderni dell'Orso
| Fuori collana
|
| Recuperata |
| Catalogo |Novità
Edizioni Urso | Offerte
del mese | Acquista
| Iscriviti alla nostra
Mailing List | webdesigner
|SEGNALA
il nostro sito
![]() Stella
Giovanni, Una
Vita. Opere (1989-2003) (Libreria
Editrice Urso, Collana Omnia 1), 2003, 16°, pagine 1312, € 22,00 – 978-88-6954-255-8
Stella
Giovanni, Una
Vita. Opere (1989-2003) (Libreria
Editrice Urso, Collana Omnia 1), 2003, 16°, pagine 1312, € 22,00 – 978-88-6954-255-8
Una
Vita
L’ultima opera di Giovanni Stella, Una Vita (Libreria Editrice
Urso, Avola, 003), non ha bisogno di presentazioni per chi conosce
l’autore, le sue precedenti iniziative letterarie e, soprattutto,
l’uomo. Il senso dell’odierno, immane lavoro reca un sentimento
intuibile già dalle prime pagine.
L’opera racchiude tutte le precedenti e ne contiene delle inedite,
sia in forma poetica sia in prosa, con note critiche di autori vari
in appendice. Un lavoro immane, per l’appunto.
Dal canto della poesia Stella rivela una personalità sensibile,
capace di cogliere dalla realtà la sua musa ispiratrice. L’animo
poetico si enfatizza e ne resta influenzato sotto le spinte propulsive
del realismo quotidiano, mentre i significati allegorici ne costituiscono
l’essenza principale. La poesia diventa così una realizzazione
dell’animo dove i componimenti vengono alla luce con la sensibilità
del cuore piuttosto che con la superbia dell’intelletto. La predisposizione
d’animo, funzionale al concepimento poetico, si materializza
in un significato che porta il lettore ai tempi di innamorata gioventù.
Ma la personalità poetica di Stella è intrisa anche
di significati complessi che riflettono la sua stessa dimensione di
uomo: la vita come inizio, il modo di viverla, la morte come fine,
come ignoto, il mondo siciliano e la stessa Sicilia, appaiono come
costanti nelle sue opere.
Non di rado è ravvisabile una punta di pessimismo: forse non
si esagera nell’affermare che siamo quasi in presenza di un pessimismo
leopardiano cagionato, chiaramente, da eventi e sentimenti esistenziali
differenti.
Nelle opere in prosa, invece, siamo in presenza, tra le altre cose,
di una dolce nostalgia del passato dove più sentiti erano i
valori, basati sulla normale quotidianità di paese: nel “Museo
della memoria” (opera inedita), per empio, è tangibile
questo sentimento. È un invito al ritorno a quelle piccole
gesta che facevano l’identità dei luoghi e delle persone
che li vivevano; ma al tempo stesso vuole essere una critica all’odierna
società in cui proprio quelle piccole cose si sono smarrite
e con esse l’identità della comunità.
L’opera in prosa presenta anche una peculiarità intrinseca:
contiene forse un inconsapevole contenuto antropologico, credo importante
per chi volesse tra qualche ventennio e più intraprendere studi
sul modo di vivere dei siciliani e degli avolesi in particolare.
Complessivamente Stella risente della influenza di Gesualdo Bufalino,
suo insigne e preferito autore. Al pari del comisano scrittore e poeta,
anch’egli mette in discussione tematiche di rilievo: la memoria,
la Vita e la Morte, l’esistenza o meno di Dio, anche se in Stella
quest’ultimo elemento, ancorché riscontrabile nella complessità
dell’opera, è forse meno manifesto; gli ossimori, poi,
ne fanno anche qui un tratto caratteristico.
La differenza, tuttavia, la si coglie nel modo di approcciarsi con
la scrittura: Bufalino, come lo stesso Stella ha riferito, è
un cesellatore della parola, un orafo della lingua italiana; Stella,
invece, adotta un linguaggio marcatamente allegorico, ravvisabile
soprattutto nella poesia, a tratti forse anche scontato e prolisso,
ma ciò trova la sua giustificazione nel fatto che il modo di
scrivere di Stella risponde ad una necessità, l’immediatezza.
E pur di raggiungerla, pur di non avere incertezze circa la sua destinazione
verso il lettore, pur di colpire il lettore Stella preferisce essere
prolisso ed allegoricamente scontato. Ritengo sia un pregio oggigiorno
per i poeti e per gli scrittori in genere: la lettura e, soprattutto,
la sua comprensione diventa fruibile per tutti e non solo per gli
“addetti ai lavori”.
Tuttavia, il libro di Giovanni Stella pur essendo in commercio non
è stato concepito per la vendita: è un libro che quasi
“corrompe” il lettore, lo corteggia, soprattutto le opere
inedite, fino a farlo uscire dal guscio morale che lo circonda. In
questo caso una particolare predisposizione d’animo è
importante se non addirittura necessariamente richiesta.
<<Una
vita>> di Giovanni Stella per lavarsi il cuore scrivendo
E’ una fotografia dall’alto di
Avola e delle sue tradizioni, ma non solo, il nuovo libro di Giovanni
Stella, edito dalle stamperie di Ciccio Urso, col titolo “Una
Vita”. La tela sulla quale il letterato avolese dipinge fatti,
personaggi e sensazioni è molto ampia, poiché abbraccia
circa mezzo secolo di notti insonni, trascorse con le proprie emozioni
e la “montblanc” nervosamente rigirata tra le dita.
Il “tomo”, quasi milletrecento linde pagine in bilico
tra poesia, prosa e pittura, parte dalle prime opere giovanili del
’67, chiamate Miraggi, snodandosi fino alla completa maturità
letteraria dei nostri giorni.
Nutritosi alla poesia di Jacques Prévert, da un lato, ed
“all’amaro miele di Gesualdo Bufalino”, dall’altro,
Giovanni Stella ha saputo fornire una unità d’insieme
in un unico testo, raccontando non una sola vita, ma disegnandone
molteplici. L’autore ha definito Avola come ”il posto
delle fragole”, l’isola che alimenta la sua “isolitudine”,
eppure non si è limitato ad essa. Dall’inchiostro nero
della sua stilografica traspare l’amore per Parigi, Roma, ma
soprattutto per i personaggi della Sicilia. Risaltano, ad ogni passo,
le figure dei suoi più cari amici del luogo, come “Ciccio
e Liliana Urso”, paragonati a dei novelli Renzo e Lucia all’interno
dell’opera.
Copiose le informazioni di cronaca dei sentimenti fornite da “Una
Vita” trascorsa a “lavarsi il cuore scrivendo”.
Un filo rosso unisce le sue prime liriche, permeate da un “senso
dolente della vita” ed i quadri descrittivi dell’Osteria
Margutta, dei “Momenti Parigini” e dei “Pomeriggi
Veneziani”, in una serenità di fondo dell’autore,
sempre proteso al ritratto del sogno e dell’inconscio. Poi
di nuovo Bufalino, “quel comisano che gli era entrato nella
testa e nel cuore”, rimanda ad una concezione negativa della
vita, superata ancora una volta in momenti di serena contemplazione
del territorio.
Le altre fasi della sua evoluzione passano attraverso titoli che
rievocano la terra: “Datteri verdi”, “Gusci di Mandorle”,
“Foglie secche”, “Lapilli”, “Cinquantesimo”,
“L’Approdo Felice”, “Edera” e “Timo
degli Iblei”, dove nella lirica intitolata “11 Settembre”,
l’autore descrive lo sgretolamento “dell’effimera
certezza di un occidente opulento”.
Nella sezione dedicata alla prosa, si fa subito sentire, tonante,
la voce di Nunzio Bruno, il floridiano di “Cozzu ‘Zu Cola”,
dai lunghi e ricciuti capelli che reclamano da tempo uno sciampo”.
Paragonato ad un “clochard” parigino con una limpida ricostruzione
scenica della sua personalità artistica, della sua genialità
mista ad improvvise rudezze e della sua “anarchia” indissolubilmente
legata a momenti di intensa generosità, Nunzio, ama ripetere
Giovanni Stella, è uno degli uomini di una Sicilia che lentamente
scompare, ma che tuttavia “sopravvive in uomini come Ciccio
Urso, Sebastiano Burgaretta e Vincenzo Consolo”.
Dopo “Le Sirene e l’Isola”, cospicua è la
galleria di ritratti fornita da un altro periodo della prosa di
Stella, e cioè “Amici Cari”.
Qui troviamo i ricordi paterni, ma anche le amicizie costruite durante
anni di esercizio professionale, come quelle con Ettore Randazzo,
“sempre in attesa di un volo in partenza” o del giurista
Titta Madìa, senza dimenticare Piero Filloley, il letterato
netino Salvatore Salemi, o il siracusano Corrado Piccione. La seconda
parte del testo comprende gli scritti nominati “Il rigattiere
e l’avventore”, il “Museo della Memoria”, le
“Lettere” e la “Pulce al libro”, sempre catalizzatrici
della attenzione del lettore, mediante uno stile efficace ed allo
stesso tempo prezioso.
Da non mancare, quindi, questo appuntamento con la cultura del nostro
tempo, che l’opera di Giovanni Stella ha cercato di affrescare,
assecondando il suo “vizio impunito dello scrivere”, necessario,
a suo avviso, per cercare la verità e per mentire, per persuadere
e sedurre, per conoscersi e per sapere chi siamo, come amava ripetere
Gesualdo Bufalino.
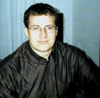 Roberto
Rubino
Roberto
Rubino

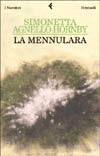 C’è
un bel romanzo da qualche settimana negli scaffali delle librerie italiane:
si tratta de La mennulara di Simonetta Agnello Hornby, palermitana trapiantata
a Londra, dove esercita la professione di avvocato in quel di Brixton.
E’ una bella storia quella che narra questo romanzo, una storia
ambientata in un paese della nostra isola nella prima metà del
secolo scorso. Diciamo subito però che affermare che si tratta
di un bel romanzo non significa sostenere anche che sia un capolavoro:
è un’opera prima ed è, complessivamente, un lavoro
di buona fattura anche se non del tutto privo di ingenuità. La
storia narra retrospettivamente, con intelligente coralità e
plurivocità e con una buona capacità di dar vita a personaggi
credibili, la vicenda di una donna, Maria Rosaria Inzerillo detta La
mennulara (voce dialettale che sta per raccoglitrice di mandorle), che
da serva (da criata, in dialetto) rivela, prima e dopo la sua morte,
prodigiose doti di amministratrice del patrimonio di terre e ricchezze
della famiglia Alfallipe (piccola nobiltà di paese, gente inetta
e comunque culturalmente inadeguata a reagire alle spinte della società
industriale che sta irresistibilmente affermandosi sulla civiltà
contadina), nonché una ferma, rigorosa e quasi feroce, capacità
di far rispettare la propria dignità di donna. Il tutto intrecciato
ad una storia di violenza e di mafia (una mafia all’antica però,
ammesso sia mai esistita, fatta d’uomini d’onore per davvero…)
e ad una segreta storia d’amore vista da una prospettiva femminile,
motivi che rendono davvero avvincente la lettura del romanzo. Particolarmente
gradevole è poi il tono complessivo di leggera ed affettuosa
ironia che l’autrice non abbandona quasi mai, e giustamente, nel
corso dell’intera narrazione. Un tono di diffusa leggerezza che
si nota persino nell’impianto linguistico e sintattico della scrittura
che presenta solo un leggero velo regionalistico (nella costruzione
dei periodi ad esempio, oppure usando magari al posto di anche), ma
non cade mai nel macchiettistico.
C’è
un bel romanzo da qualche settimana negli scaffali delle librerie italiane:
si tratta de La mennulara di Simonetta Agnello Hornby, palermitana trapiantata
a Londra, dove esercita la professione di avvocato in quel di Brixton.
E’ una bella storia quella che narra questo romanzo, una storia
ambientata in un paese della nostra isola nella prima metà del
secolo scorso. Diciamo subito però che affermare che si tratta
di un bel romanzo non significa sostenere anche che sia un capolavoro:
è un’opera prima ed è, complessivamente, un lavoro
di buona fattura anche se non del tutto privo di ingenuità. La
storia narra retrospettivamente, con intelligente coralità e
plurivocità e con una buona capacità di dar vita a personaggi
credibili, la vicenda di una donna, Maria Rosaria Inzerillo detta La
mennulara (voce dialettale che sta per raccoglitrice di mandorle), che
da serva (da criata, in dialetto) rivela, prima e dopo la sua morte,
prodigiose doti di amministratrice del patrimonio di terre e ricchezze
della famiglia Alfallipe (piccola nobiltà di paese, gente inetta
e comunque culturalmente inadeguata a reagire alle spinte della società
industriale che sta irresistibilmente affermandosi sulla civiltà
contadina), nonché una ferma, rigorosa e quasi feroce, capacità
di far rispettare la propria dignità di donna. Il tutto intrecciato
ad una storia di violenza e di mafia (una mafia all’antica però,
ammesso sia mai esistita, fatta d’uomini d’onore per davvero…)
e ad una segreta storia d’amore vista da una prospettiva femminile,
motivi che rendono davvero avvincente la lettura del romanzo. Particolarmente
gradevole è poi il tono complessivo di leggera ed affettuosa
ironia che l’autrice non abbandona quasi mai, e giustamente, nel
corso dell’intera narrazione. Un tono di diffusa leggerezza che
si nota persino nell’impianto linguistico e sintattico della scrittura
che presenta solo un leggero velo regionalistico (nella costruzione
dei periodi ad esempio, oppure usando magari al posto di anche), ma
non cade mai nel macchiettistico. Paolo
Randazzo
Paolo
Randazzo