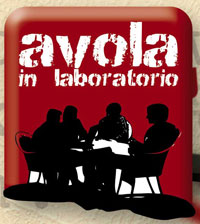Questo e' un invito!
|
SUCCESSIVO APPUNTAMENTO PREVISTO: mercoledi' 30 GIUGNO 2010 |
|
Una
di alcune sere fa, alla Gepas, con Ciccio, prima di iniziare la routine del
lavoro di correzione delle bozze, stavamo rivedendo alcune foto e qualche
filmato degli incontri di ''Avola in Laboratorio'', e l'attenzione cadde sulla
videoripresa, fatta da me, e poi anche sulle foto, di quell'unico incontro,
dell'ottobre 2006, in cui fu ospite Lucia Sortino. Ciccio, guardando quanti
amici oggi scomparsi, a parte Lucia, erano presenti a quell'incontro (molti:
Claudio il Milanese, Corrado Tiralongo, Antonio Caldarella, Libero
D'Agata, Sebastiano Di Rosa; e forse, ma sarebbe il colmo, ne dimentico qualche
altro), mi fece notare come quel filmato, uno dei pochissimi che avevo fatto
io, fosse un rarissimo esempio, per certi versi ''esilarante'', di ''testimonianza
premonitrice'' (non aggiungo all’esempio gia' abbastanza esilarante, per
questione di ''convenienza'', come e' facile comprendere, l’altro aspetto che mi
si vorrebbe accollare, cioe' quello relativo alle circostanze evocatrici di gesti
scaramantici; come a dire, o meglio a ribadire, che al senso del tragico si
accompagna sempre una paradossale ''spinta'' alla comicita'). E subito dopo
aggiunse, quasi sorprendendosi pure lui, che anche il tema di quell'incontro
era abbastanza ''leggero'', verteva addirittura sul riso (''Riso, sorriso, risotti
e risate!'', il titolo). Certo, quel titolo era stato voluto, per donare, per
così dire, un po' di serenita' a Lucia, scrittrice esordiente, che da lì a
qualche anno (cercavamo di nascondercelo, ma ''si sapeva''!) avrebbe lasciato
questo mondo. Non si poteva immaginare, viceversa, con altrettanta facilita' che
l’ironia di quel titolo avesse toccato a breve anche il destino di tutti gli
altri. In fondo, quella metonimica serata, per quel che e' accaduto a partire da
quella ''sfortunata'' videoripresa, ci ha fatto toccare con mano che la morte in
un certo senso fa anche ridere, perché e' imprevedibile, ci sorprende e gioca
magari a nascondino, nel senso che, come diceva Epicuro, quando ci siamo noi,
lei non c'e', e quando c'e' lei, noi non ci siamo.
Il lato ridicolo dei nostri desideri Non ho voluto ricordare questo episodio per affermare una nostra presunta originalita' riguardo alle tematiche esistenziali. Trattando in questo scritto il concetto di desiderio, potrei comunque dire che, di essere originali, coltiviamo (come tutti gli intellettuali, sic!) sicuramente quantomeno una segreta speranza. Ma la realta', come ci mostra senza infingimenti il filmato dell'incontro di cui ho appena parlato, spesso ci sbatte in faccia brutalmente il lato ridicolo dei nostri desideri. E qual e' questo lato ridicolo del desiderio? Diciamolo chiaramente: la (nostra) vanita' (Leopardi nei Pensieri: ''Le persone non sono ridicole se non quando vogliono parere o essere cio' che non sono''). Di non essere originali, e' oltretutto una (nostra) evidente consapevolezza. Come ci ricorda la memoria storica, fu proprio il secolo appena trascorso, il Novecento, ad avere un ''esordio filosofico'', come lo chiama Lucio Villari nel suo libro ''L'insonnia del Novecento'' (Bruno Mondadori, 2005), del tutto corrispondente alla nostra ''testimonianza premonitrice'': ''L'esordio filosofico del Novecento e' stato un Saggio sul significato del comico apparso nelle librerie parigine nel maggio 1900. Era il sottotitolo de Il riso e non poteva rappresentare con migliore spirito una stagione del pensiero filosofico francese ed europeo che e' stata tra le piu' vive e coinvolgenti di tutto il secolo. L'autore era Henri Bergson, un signore di quarantun anni che da alcuni mesi aveva iniziato le lezioni di filosofia al Colle'ge de France''. Villari prosegue dicendo come il gia' famoso (e affascinante, e molto desiderato dalle dame dell'alta borghesia parigina) autore fosse stato trascurato e frainteso riguardo a questo scritto (da Sorel soprattutto, che definì tale scritto non ''soddisfacente'', ''... perché il riso non e' suscettibile di una unificazione''). Si e' molto sbagliato al riguardo Sorel. Le tragedie del Novecento, dalle due guerre mondiali, al nazismo e allo stalinismo, al Vietnam, alla guerra del Golfo sino agli ultimi rantoli di questo martoriato secolo, e direi sino ai nostri giorni (che di esso ereditano, anche se poi sviluppatesi in forme nuove e per certi versi inedite) le nefandezze, vanno lette, con Villari, anche alla luce di una sottovalutazione della leopardiana ''potenza del riso'' (Leopardi, in Zibaldone 4391: ''Terribile e awful e' la potenza del riso: chi ha il coraggio di ridere, e' padrone degli altri, come chi ha il coraggio di morire''). ''Ho l'impressione – scrive Villari – che solo Oscar Wilde, scomparso proprio nell'anno della pubblicazione del Riso, vi avrebbe visto significati che ad altri sembravano sfuggire. Infatti per Bergson il comico esige, per produrre tutto il suo effetto, qualcosa come un'anestesia momentanea del cuore: si dirige alla pura intelligenza. Una provocazione liberatoria che Wilde avrebbe accettato pienamente e che aveva attinenza solo parziale con la pratica e l'ideologia dell'humour sulle quali, dopo Bergson, si esercitarono, nei primi anni del Novecento, scrittori inglesi, francesi, tedeschi e italiani (compreso Luigi Pirandello, il cui saggio L'umorismo e' del 1909). Pensiamo anche ai vantaggi che ne avrebbe tratto il quasi coetaneo di Bergson, Freud, se (pur avendo letto Il riso) ne avesse saputo estrarre gli elementi positivi, liberatori e terapeutici per uno stato interno (e profondo quanto la psiche) come l'intelligenza umana. Tale intelligenza – scriveva Bergson – deve sempre rimanere in contatto con altre intelligenze. Ecco il fatto al quale conviene prestare attenzione: noi non gusteremmo il comico se ci sentissimo isolati. Sembra che il riso abbia bisogno di un'eco. Ascoltatelo bene: non e' un suono articolato, netto, finito; e' qualcosa che vorrebbe prolungarsi ripercuotendosi successivamente, qualcosa che comincia con uno scoppio e continua con rullii, come il tuono nella montagna. Per parlare di desiderio, bisogna partire dall'imprenscindibilita' del sociale nell'equilibrio caratterizzante l'esistenza umana La 'potenza
del riso' di cui parlava Leopardi diventa così piu' intelligibile come forza
creativa del linguaggio, di ogni linguaggio (lo era nella letteratura e nel
teatro, lo sara', nel Novecento, nel cinema) e come parte integrante di
relazioni sociali (Per comprendere il riso, bisogna riportarlo nel suo
ambiente naturale che e' la societa', bisogna anzitutto determinare la sua
funzione utile, che e' funzione sociale). Una lezione, questa di Bergson,
che, cent'anni dopo, ci sembra non discutibile''.
Allora, per parlare di desiderio, io credo
che bisogna partire proprio da cio' che indica questa lezione bergsoniana
dell'imprenscindibilita' del sociale nell'equilibrio caratterizzante l'esistenza
umana. Il desiderio, che come il riso e' incontenibile nell'individuo, deve
''apprendere'' il senso del limite perché l'individuo puo' trovare il suo
equilibrio solo nella societa'. Al giorno d'oggi, specie nelle societa' cosiddette democratiche in cui, come ci
ricorda ancora Lucio Villari citando l'ultima intervista di Popper, rilasciata
al giornale ''La Repubblica'' nel 1992, e' invalsa ''la terribile idea che la gente
debba essere in grado di fare in tutto e per tutto cio' che vuole'', questa
consapevolezza del limite (cioe', il richiamo al senso di responsabilita') e'
divenuta una necessita' ineludibile. e' chiaro come questo sia anche un aspetto
umoristico, sicuramente ironico della vita: proprio quando l'uomo raggiunge,
nella modernita', una invidiabile liberta', deve, pena la sua stessa sopravvivenza,
riconoscere che la liberta' ha il proprio limite nella liberta' stessa come
fattore di convivenza sociale: la mia liberta' deve tener conto della liberta'
degli altri.
Dunque, anche il mio desiderio non puo'
essere ''sconfinato''. E questa consapevolezza acquista un'importanza senza pari,
se si tiene presente quanto ha affermato ancora Popper (nell'intervista citata)
riguardo a quella che lo scienziato ritiene essere la ''vera'' conquista del
Novecento: ''Ai nostri ragazzi, specialmente in Europa, si va ripetendo che
vivono in un mondo terribile: la verita' e' che viviamo nel migliore dei mondi
che sia mai esistito in Occidente: non perché sia il piu' ricco, ma perché e' il
piu' giusto''. Villari commenta in maniera esemplare questa riflessione: ''Ecco
individuato qualcosa di 'moderno' che il passato non ha mai conosciuto. C'e'
infatti in questo giudizio la ferma convinzione che, rispetto al passato, non
vi sia una differenza di valori e di saperi; la novita' e' invece sul piano della
giustizia (intesa, mi pare, nel senso plurale di legge eguale per tutti e di
equita' sociale tra gli uomini)''.
Senso pubblico e sociale dei desideri La nostra societa', democratica e legalitaria, nonostante le ''imperfezioni'' che vi si possano riscontrare (o forse, probabilmente, proprio in virtu' di tali imperfezioni, che attestano comunque il fatto, indiscutibile anche questo, che la democrazia ha posto il problema della giustizia come questione centrale del nostro tempo), ha dunque rafforzato la sua legittimazione rispetto ai bisogni dell'individuo, e paradossalmente cio' avviene proprio quando in essa si affermano nel contempo in forma molto ampia i principi liberali. Come dire: questa societa' riconosce e tutela i sogni e i desideri di tutti gli individui che la compongono in quanto da' ''senso pubblico e sociale'' ai desideri stessi, li rende cioe' ''accettabili'' a tutti in virtu' del fatto che al contempo ne segna, e assegna, i limiti entro cui e' dato, per l'individuo, ''desiderare''. E questi limiti sono proprio il ''fattore'' sociale, ossia il fatto che gli individui sono liberi, non dalla societa', ma nella societa'. Occorre infatti rivedere il concetto di
liberta', e proprio alla luce del fatto che l'individuo (uomo), non potendo non
avere un desiderio eccedente, e trascendente, in quanto ''animale mancante'',
come l'ha definito Paolo Flores d'Arcais, non puo' essere libero proprio nella
sua mancanza di ''animale eccedente'', ma lo e' (o meglio, lo puo' essere)
invece nel ''comportamento'' sociale. Che non e', e' bene precisare, un
comportamento dettato dall'istinto. Proprio perché l'uomo e' ''l'essere
imperfettissimo, l'animale malformato [dal caso, cioe' da un errore di
trascrizione del dna stocasticamente certo, di cui e' nota la frequenza]
strappato irreversibilmente alla rotondita' degli istinti... l'animale cacciato
una volta e per sempre dall'habitat senza tempo dell'istinto cogente, dal
paradiso immutabile della certezza dell'essere... l'essere imperfettissimo
definitivamente liberato nell'esilio dell'in-certezza, definitivamente
precipitato nell'aperto del comportamento possibile...'' (P. Flores d'Arcais, in
Micro Mega n. 4/2005), nella (sua) societa' agisce attraverso il suo nuovo
''istinto'' che e' il nomos (la legge, le Norme fatte dall'uomo). E questo
nomos ''... che e' sempre auto-nomos, per essere deve sempre essere il nomos di un gruppo. (La scimmia nuda non puo' chiamarsi Robinson. Una scimmia
nuda di nome Robinson non sarebbe mai nata. Se e' nata, non e' sopravvissuta, e
non ne sapremo mai nulla). Il nomos deve essere dover-essere-del gruppo'' (Ibidem).
L'uomo ''animale mancante'' Niente istinto, dunque, nell'''animale
mancante'' che e' l'uomo. O meglio, niente istinto, nel significato che
usualmente si da' a questa parola. Lo chiarisce molto bene Flores d'Arcais,
questo concetto: ''L'animale e' quello che e'... Nell'animale bisogno e
soddisfazione si corrispondono. Il bisogno non eccede mai la possibilita' della
soddisfazione e la soddisfazione la necessita' del bisogno. Questa necessita' e
questa possibilita' sono istinto... ('Immagazzinare' acqua e' parte
dell'istinto del cammello: quella quantita' e non di piu'. 'Immagazzinare' miele
– e la 'perfezione' di quelle celle – e' l'istinto delle api. Non
oltrepassa nulla: e' l'immediato dell'istinto, del suo essere-cammello e del suo
essere-ape). L'animale puo' quel che deve e deve quel che puo'. Né piu' né meno.
Presso l'animale, possibilita' e dovere non hanno luogo''. L'istinto dell'uomo e'
invece quello di un animale ''mancante'' ''per cui la necessita' diviene
possibilita' e la possibilita' necessita'''. e' allora evidente che la ''scimmia che
tutti noi siamo e' ontologicamente l'eccesso''.
Se l'animale e' (solo) istinto,
l'animale-uomo e' allora (anche) desiderio: ''Se il dna prevede un pansessualismo
orgiastico-egualitario (come per le felici scimmie bonobo, o pigmy chimps,
nome scientifico Pan paniscus), tutti gli esemplari del branco
sperimenteranno il kamasutra di promiscuita' in-derogabile per istinto
(in-derogabile nella forbice di variabilita' individuale de-finita
dall'istinto). Nella scimmia deontica che tutti noi siamo, come cacciare la
preda non e' piu' de-finito dall'istinto. Quando attaccare e quando fuggire non e'
piu' circo-scritto nel codice genetico. Come combattere e fino a che punto
combattere, per la supremazia e per la femmina, non e' piu' dettato dai
cromosomi. L'elica del dna non ditta e comanda secondo che avvolge sulla
distribuzione della soddisfazione e dei bisogni. Il conflitto e' s-vincolato
dall'istinto, gettato nell'il-limitato della possibilita'... L'eccedenza di
possibilita' e' possibilita' di eccedenza nel conflitto, fino all'hybris e
all'autodistruzione'' (Ib.).
L'essenza del desiderio e' la ''trascendenza'' L'uomo e' pertanto il solo animale che desidera cio' che non e' (per questo desidera di possedere il futuro) e cio' che non ha (ancora), perché, gettato (non dall’essere ma dalla selezione naturale) nell'imprevedibile spazio della possibilita' oltre il bisogno e la necessita', e' ''mancante'' di essere, e questa mancanza gli suscita un desiderio illimitato: ''L'animale eccedente e' un animale mancante. Piu' ha e piu' manca. L'eccedere della soddisfazione trascina con sé l'eccedere del bisogno e lo spinge piu' avanti... L'animale eccedente era gia' animale mancante. Non ha organi specializzati di aggressione e difesa: zanne, corazze, velocita', fuga sugli alberi, volo. Non ha riparo di pelliccia contro il freddo, il vento. e' inerme. La scimmia della spirale dei bisogni e' la scimmia inerme, armata solo delle sue possibilita', dell'hybris e del caos delle sue possibilita''' (Ib.). e' logico, a questo punto, che l'acme e
diciamo pure l'essenza del desiderio e' la ''trascendenza'' (desiderio d'infinito,
d'immortalita', d'eternita', ecc.). E questo bisogno di trascendenza possiamo
chiamarlo, con Mario Ruggenini (in ''Filosofia 92'', pp. 117-144), ''bisogno
metafisico'', che consiste nel bisogno dell'uomo di ''alleggerirsi'' del peso
della finitezza. Saggio, questo, non senza spunti interessanti di riflessione,
che mostra come sul bisogno metafisico in fondo pesi ''...il limite che
l'esistenza incontra da ogni parte e che l'attende, rendendo vana ogni fuga,
all'appuntamento ineludibile con la morte''. Ma che alla fine ''ripropone'' la
necessita' del ''mistero'' (metafisico) proprio attraverso l'''ironia del
limite'', che ''consiste dunque non nella dialettica fittizia, per cui esso non
potrebbe che rinviare all'illimite, ma nella necessita' per la quale esso rivela
la finitezza dell'alterita' stessa che lo costituisce come tale. La terra, a cui
aderisce l'esistenza finita, e' dunque abitata dall'alterita' che non trova sede
altrove''. Insomma, Ruggenini vuole dire, per dirla con il Gianni Vattimo e il
Maurizio Ferraris dell'''Introduzione'' a ''Filosofia 92'', che ''l'uomo e' finito
perché c'e' dell'altro''.
E, da qui, tutti a immaginare (ecco che ''su
questo mistero si costruisce un rinnovato incanto del mondo'') cos'altro ci possa essere oltre la finitezza in cui l'uomo e' gettato e di
cui e' parte integrante. Non vorrei essere irriverente, ma mi e' venuta alla
memoria l'ilare storiella di un mio concittadino, che da ragazzo, dopo aver
fatto il bagno a mare, ha detto alla madre: ''Ho una tale fame, che mi mangerei
una balena con i peperoni''. Evidentemente, in questo caso, il ragazzo non
manifestava tanto la richiesta di soddisfare un bisogno naturale, ma il
desiderio ''illimitato'' di eccedere il bisogno: non le bastava la balena, voleva
pure dell'altro, cioe' il contorno dei peperoni. Se la mia e' irriverenza,
vediamo ora cosa dice Wikipedia alla Voce Hume:
''Ci sono, per Hume, due tipi di filosofia,
una facile e ovvia, l'altra difficile e astrusa. Quella ovvia e'
esortativa, precettista, consolatoria e alla fine risulta fin troppo banale,
l'altra e' astratta, decisamente inservibile per la vita, perché orientata all'esaltazione
di dispute interminabili; e spesso scade in una forma di "malattia
metafisica" o sapere astratto perché pretende di conoscere
l'inconoscibile''. Riprorre il senso del mistero, anche alla luce di una
maggiore consapevolezza del finito, significa in definitiva riproporre anche
una giustificazione superiore (metafisica, appunto) all'illimitato desiderio dell'uomo, quasi che
l'uomo-finito fosse il risultato di una ''volonta''' che supera la stessa
finitezza della realta'. Non avrebbe senso, d'altronde, se ci si mettesse a
cercare ''dell'altro'', sapendo di trovare cio' che gia' conosciamo. Se andiamo a
cercare ''altro'' (rispetto a cio' che sappiamo essere la realta'), e questo
cercare ci conduce verso un ''mistero'', significa evidentemente che aspiriamo a
trovare, nel mistero (e, si badi bene, non nella scienza), qualcosa che non e'
certamente la realta' che conosciamo (o che aspiriamo a conoscere).
Si ripropone così, anche se in forma
indiretta, il ''Disegno finalistico intelligente'' della Religione. Che vuol farci credere ancora oggi, cioe' al tempo di
Darwin (diciamo anche questo chiaramente!), che tutto il ''trambusto'' della
storia dell'Universo, ''14 o 15 miliardi di anni e di sconvolgimenti cosmici'', e'
servito, ''per mettere infine al mondo, a compimento e coronamento dell'intera
faccenda, la scimmia nuda che tutti noi siamo'' (in ''Micro Mega'', n. 4/2005, p.
5). Non vi sembra molto comico anche questo ''smascheramento''
dell’autoreferenzialita', tipica della scimmia nuda? Proprio perché ''nuda'', la
scimma che s’e' fatta uomo, ignara della sua casuale e (purtroppo!) umiliante posizione in un universo che,
per quanto finito, al suo confronto sembra illimitato, ha camuffato da sempre
il suo pathos, la sua megalo-mania,
con il sentimento del sublime.
L'uomo ha certamente il senso
dell’infinito, ma solo perché, come ho gia' detto, con Flores d'Arcais, casualmente (dalla selezione naturale) gettato nello spazio infinito (illimitato,
imprevedibile, vorticoso e caotico) della possibilita'. Prima degli
''ermeneutici'', la giustificazione del senso del mistero era stata affrontata, e
in un contesto certamente meno ermeneutico e piu' scientifico, dai cosiddetti
''teorici di una teologia naturale'' dell’Ottocento. ''Ma, – come scrive
Alessandra Attanasio nell’Introduzione ai ''Taccuini filosofici'' di Darwin
(Utet, 2010) – nella costruzione della theory darwiniana, insieme al vacillare della stabilita' delle
specie, va in frantumi anche quel disegno divino tanto minuziosamente descritto
dai Kirby, dai Paley, dai Macculloch''. Darwin, come aveva gia' fatto Hume,
raggiunge il cuore del problema: il libero arbitrio. Il libero arbitrio
appartiene secondo Darwin a quelli che Hume nel Trattato sulla natura umana aveva definito ''i fantasiosi sistemi di
liberta''', la cui confutazione e' scientificamente inevitabile. ''Se –
scrive la Attanasio – la necessita' che vediamo nel mondo fisico era stata
ridotta da Hume a una ‘impressione della mente’ che percepisce solo l’unione
costante di causa e effetto, allora anche la volonta' e' una ‘impressione
interna’ che ci da' l’ebbrezza della liberta' incondizionata, cioe' il libero
arbitrio, l’anima donata da Dio. La liberta' invece e' condizionata, dal mondo
fisico e sociale, dal corpo, dal cervello'' (Ib.).
Tutto il resto, e' riso In definitiva, il desiderio illimitato, inteso come prerogativa essenzialmente umana,
non e' un dono divino, ma il frutto di una situazione, derivata dalle ''semplici''
leggi di natura, in cui e' venuto a trovarsi un animale che per ''errore'' ha
dovuto, per sopravvivere, sostituire l’istinto cogente con l’insicuro,
impreciso e caotico ''calcolo'' delle probabilita'. E a tale calcolo dell’insicurezza ha dovuto affidare per
sempre il suo destino di sopravvivenza in questo mondo. Non ha dunque alcun
carattere eccezionale il suo desiderio, quanto e' invece eccezionale proprio
questa evoluzione intelligente del
babbuino. E non solo del babbuino: ''Dall’animale di pietra, il corallo, al
verme, alle emozioni, alle ragioni dimenticate, alla nuova teoria degli
istinti, alla coscienza morale, questa, dice Darwin, e' una spiegazione straordinaria'' (Ib.).
Il desiderio, pertanto, va ricollegato,
come ho detto all’inizio, al suo carattere sociale e va considerato all’interno
del naturale mondo della vita. Tutto il resto, e' riso. E il riso, si badi bene,
e' certamente necessario per la felicita' dell’uomo nel mondo; ma acquista
importanza e positivita' solo se svincolato dalle vane sequele del desiderio dell’Assurdo e della sua ''ritualita''' che
non conosce spiegazione alcuna.
E invece catturato interamente nel
linguaggio dell’arte:
Le vele le vele le vele
Che schioccano e frustano al vento
Che gonfia di vane sequele
Le vele le vele le vele!
Che tesson e tesson: lamento
Volubil che l'onda che ammorza
Ne l'onda volubile smorza...
Ne l'ultimo schianto crudele...
Le vele le vele le vele
Dino Campana, Barche amorrate
|
| Invia ad un Amico | 579 letture