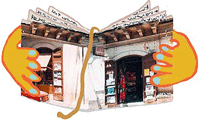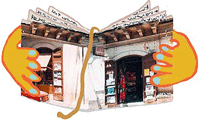| 65) |
Leonardo Miucci  |
| leon.miucci@vodafone.it |
Località:
Avola |
  
|
|
PER LE MANETTE Dramma in tre atti di Teocrito Di Giorgio
È molto difficile fare e parlare di cultura al giorno doggi perché si rischia di non essere capiti o, peggio ancora, di essere derisi. Esistono tuttavia ancora baluardi, che si pongono autenticamene e caparbiamente e, aggiungerei, instancabilmente il proposito di portare avanti questa missione impossibile in unepoca nichilista come la nostra.
Certamente uno di questi baluardi è costituito dalla Libreria Editrice Urso di Avola, che non ha mai smesso un solo attimo di organizzare eventi culturali aperti a tutti e senza onere per alcuno , capaci di restituire la perduta identità della nostra città.
È risaputo che il patrimonio culturale di una comunità, piccola o grande che sia non ha importanza, esprime il significato della nostra identità: chi siamo, possiamo capirlo soltanto se non trascuriamo la conoscenza del nostro patrimonio cultuale e la sua tutela.
E daltronde, un motivo ci sarà stato se anche i padri costituenti hanno avvertito lesigenza di consacrare allart. 9 della Costituzione, quindi tra i principi fondamentali (che non possono essere oggetto di modifica alcuna), il riconoscimento e la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico.
Tutelare il patrimonio culturale significa, nella sostanza, custodirlo per le generazioni future perché queste possano apprendere della loro origine e capire ciò che sono.
Ciò dovrebbe essere compito di ognuno di noi e principalmente delle istituzioni preposte e degli amministratori locali fare in modo che la conoscenza delle opere, degli autori, dei monumenti, del patrimonio culturale nel suo complesso, che ha segnato la nostra comunità non venga dimenticato o ignorato.
Uno degli ultimi lavori edito dalla Libreria Editrice Urso di Avola si indirizza proprio in questo senso con la pubblicazione del dramma teatrale Le Manette di Teocrito Di Giorgio, a cura dellavvocatessa Maria Suma, che ne ha appunto curato la pubblicazione e la prefazione al testo.
Teocrito di Giorgio era un figlio della nostra città di Avola, avvocato e giurista, personaggio poliedrico, come lo definisce la stessa Maria Suma, per essere stato poeta, scrittore, musicista ed altro ancora.
Ma Di Giorgio è pressoché sconosciuto ad Avola nonostante due precedenti pubblicazioni: il racconto Per un pugno di case dello stesso Di Giorgio, edito da Trevi; e la biografia Teocrito Di Giorgio. Poeta, scrittore, traduttore di Salvatore Salemi, pure edito dalla Libreria Editrice Urso di Avola.
Maria Suma non si è limitata a pubblicare lopera teatrale Le manette, ma ha svolto una ben più approfondita e scrupolosa ricerca sulla persona del Di Giorgio, ricerca che tuttavia non trova spazio nella presente pubblicazione ma che ci auguriamo venga restituita alla collettività in una prossima pubblicazione.
Lopera teatrale Le manette è stata presentata sabato 7 luglio 2018, nel cortile di quella che fu labitazione di Teocrito, ora abitata dal figlio Enzo, alla presenza della stessa curatrice avvocatessa Maria Suma, che, dopo aver tracciato la biografia dello stesso Teocrito, ha spiegato magistralmente il senso dellopera, nonché alla presenza delleditore Ciccio Urso e di un numero considerevole di partecipanti.
Già dalla presentazione di Maria Suma ho avuto la sensazione che lopera si innestasse nel solo culturale inaugurato dal grande drammaturgo siciliano quale è stato Luigi Pirandello; la conferma ne è poi venuta dalla lettura del testo.
Senza voler svelarne lintero contenuto, anche per rispetto di chi volesse leggere il testo, cosa che personalmente invito a fare sin da subito, si tratta della storia possiamo dire di un dissidio tra due giudici, i quali discutono attorno alla responsabilità penale di un giovane avvocato accusato di appropriazione indebita, ed uno dei due, di stampo colpevolista e tutto sicuro di sé, è persuaso che alla condanna di un individuo possa pervenirsi attraverso lapplicazione dei principi di diritto; e laltro, invece, ritiene che debba tenersi conto della persona incriminata, del suo essere persona e quindi decidere della sua colpevolezza tenendo bene a mente la dimensione umana, esistenziale oserei dire.
Lepilogo è drammatico non solo per lesito del dissidio, che non sto qui a rivelare, ma soprattutto per le forti implicazioni giuridiche-esistenziali, se così posso dire, e al tempo stesso filosofiche che a mio parere sembrano scaturire dallopera.
Uno dei due protagonisti, il giudice Clemente, paradigmatico il nome scelto dallautore come afferma la stessa Maria Suma , si pone un problema di coscienza: come può un giudice condannare un suo simile pur sapendolo innocente? In altri termini, come può un giudice condannare un uomo solo sulla base dei principi del diritto, nonostante i fatti storicamente accaduti depongono a favore della innocenza dellincolpato?
La coscienza, ritengo, sia un po la questione nodale di tutta lopera, ossia quella componente del nostro Io che ci interroga incessantemente e ci pone di fronte alle nostre responsabilità. Chi non ricorda, per citare unopera letteraria di conoscenza planetaria quale è Delitto e castigo di Dostoevskij, dove il giovane Raskòl'nikov, dopo essere stato devastato dai morsi della coscienza, decide di confessare latroce crimine e di assoggettarsi alla relativa pena?
La società scopre la coscienza attraverso lopera di Freud, il quale la descrive attraverso le tre topiche dellIo, dellEs e del Super-Io, assegnando a ciascuna di esse una ben precisa funzione.
La letteratura fa sua questa ricostruzione e lopera di Pirandello partorisce capolavori quali Uno, Nessuno e Centomila, e Il fu Mattia Pascal, per citarne alcuni.
Teocrito Di Giorgio è, a tutti gli effetti, un pirandelliano perché, attraverso il giudice Clemente del dramma Le manette, pone sul tappeto una questione fondamentale: la coscienza.
Ma lopera contiene anche altri significati.
Se dobbiamo paragonare Di Giorgio alla figura di Pirandello, non possiamo trascurare lepoca in cui i due vissero e produssero le loro opere letterarie.
Lepoca è il 900, e il Romanticismo, quale movimento culturale che poneva alla base del suo pensiero lo spirito, aveva lasciato il posto al Positivismo, quale movimento culturale che pone a base del suo ideale il progresso scientifico.
Ma siamo anche nellepoca del Nichilismo, come profetizzata da Friedrich Nietzsche, nella quale tuttora viviamo, che si caratterizza per la totale mancanza di valori a cui luomo possa ancorarsi, manca, in altri termini, una risposta, che sia una, al perché.
Siamo nellepoca della alienazione delluomo, il quale è diventato merce di scambio in un processo consumistico e capitalistico nel quale egli assume valore solo nella misura in cui è in grado di vendere la sua forza lavoro.
I tre maestri del sospetto, Marx, Freud e Nietzsche, hanno sviscerato, ognuno secondi i rispettivi ambiti, molto bene la condizione in cui versava (e tuttora versa) luomo moderno.
Dalla fallacia dellesistenza umana ne nasce uno spaesamento delluomo, una frammentazione dellIo, perché egli non riesce a capacitarsi del fatto che le sue certezze, proprio come il giudice colpevolista del dramma Le manette, non possono essere definite tali; non riesce a trovare una risposta al perché.
Ecco, io credo che lopera Le manette di Teocrito Di Giorgio, curata da Maria Suma, voglia dirci soprattutto di questo spaesamento delluomo, di questa forma crudele di nichilismo alla quale come farmaco sembra esserci solo la pazzia.
Una considerazione finale va fatta anche alle accezioni giuridiche che lopera importa.
Vi è un moto di coscienza da parte dellautore, ma vi è anche una esigenza di verità.
Di quale verità?
Nel libro Il Maestro e Margherita di Michail Bulgakov, Ponzio Pilato, nellinterrogare Gesù, gli chiede: E perché tu, vagabondo, nel bazar sobillavi il popolo raccontando della verità, di cui non hai idea? Che cosè questa verità?
Oh dèi! Gli pongo domande inutili ai fini del processo
la mia ragione non mi obbedisce più
La verità è innanzitutto nel fatto che ti duole il capo, e ti duole tanto forte da suggerirti vili pensieri di morte. Tu non solo non hai la forza di parlare con me, ma ti è persino difficile guardarmi. E ora io involontariamente sono il tuo torturatore, e questo mi addolora.
La verità cui tende il processo, e in particolar modo il processo penale, è una verità processuale alla quale si accede attraverso lo svolgimento del processo secondo le norme che lo disciplinano: il giusto processo, come mirabilmente affermato in sede di presentazione la curatrice avvocatessa Maria Suma.
Al processo non interessa la verità storica, ossia la verità scaturita dai fatti fenomenologicamente verificatisi; quei fatti, perché possano dirsi a fondamento della responsabilità penale del soggetto imputato, debbono cristallizzarsi davanti agli occhi di un soggetto terzo ed imparziale, quale è il giudice, che dovrà poi in relazione alla loro sussistenza o insussistenza giudicare, quindi condannare o assolvere.
Capite allora quale compito immane spetta al giudice, quello di trovarsi di fronte a fatti anche di una certa crudeltà e tuttavia assumere decisioni prescindendo dagli stessi qualora non risultassero provati secondo le norme.
Come dire che forse sono le norme le sole portatrici di verità, di tante verità o di nessuna verità.
Come vedete, siamo a Pirandello o, se preferite, a Teocrito Di Giorgio.
Infine, desidero esprimere il mio ringraziamento a Maria Suma per avermi fatto conoscere questopera di Teocrito di Giorgio, a me sconosciuta, e per leccellente lavoro di ricerca svolto, che, come innanzi già detto, ci auguriamo possa trovare in tempi brevi la necessaria pubblicazione a beneficio della collettività.
Un ringraziamento lo devo anche a Ciccio Urso per la sua instancabile attività culturale che quotidianamente svolge in favore della collettività avolese, sebbene questa non ne dimostri riconoscenza.
Un particolare omaggio voglio indirizzarlo alla bella Liliana che, con la sua dolcezza, è riuscita ancora una volta a solleticare le corde del cuore con le sue canzoni ed in particolare con il brano Salve sono la Giustizia dei Nomadi, a me totalmente sconosciuto.
Come vedete, non si smette mai di imparare.
Ecco, questa potrebbe essere la verità!
Avola, 8 luglio 2018
Leonardo Miucci
|
| 64) |
Angelo Fortuna  |
| fortunangelo@tin.it |
Località:
- |
  |
|
Giuseppe Pignatello
Il dialetto della mia terra natia
(Il Siciliano della mia Avola) 2017, 8°, pp. 616, ill.
27,00
Considerazioni su Il dialetto della mia terra natia
di G. Pignatello
Lopera postuma, complessa e corposa, Il dialetto della mia terra natia al vaglio dellesperienza critica e dellassimilazione personale (il Siciliano della mia Avola) di Giuseppe Pignatello esige, per chi vi si accosta, un chiarimento preliminare. Anzitutto, il ripetersi già nel titolo dellaggettivo possessivo mia terra natia e mia Avola rivela una incondizionata adesione emotiva e un amore senza misura per la sua città natale da parte dellAutore, che ad essa ha dedicato il più e il meglio della sua produzione letteraria. Basti fare, a tale riguardo, un semplice riferimento ai due volumi di Avola degli Anni Trenta (Catania, Istituto Siciliano di Cultura Regionale, 1978), alla Guida di Avola (Ispica, Martorina, 1980, seconda edizione 1993) e ad Avola dalla Preistoria al Duemila (Rosolini, Santocono, 2007), per rendersi conto di questo suo viscerale attaccamento al suolo natio.
In secondo luogo, va subito evidenziato come il suddetto titolo sia fortemente riduttivo rispetto alla copiosa materia trattata con sicura competenza e meticolosa applicazione, dopo lunga e meditata preparazione. Non siamo dinanzi a una semplice lista di vocaboli tratti dal vernacolo avolese, a una fredda raccolta di termini in ordine alfabetico del patrimonio lessicale locale.
Il dialetto della mia terra natia al vaglio delesperienza critica e dellassimilazione personale (il Siciliano della mia Avola) è il risultato di un vasto progetto di lavoro articolato, multiforme e originale nella sua impostazione: una summa, una trattazione organica dei modi di essere, elaborati, praticati e passati al vaglio di molti secoli di esperienza dalla 'gens hyblensa', da sempre distintasi per la sua laboriosa operatività, che le ha consentito di affrontare con dignità fasti e nefasti della sua comunitaria avventura esistenziale.
Siamo dinanzi al frutto di una fatica certosina che solo la curiosità intellettuale e la dedizione costante di un innamorato dellavolesità poteva concepire e portare a compimento, lumeggiando il genio della comunità sociale di Avola, che si esprime attraverso il suo particolare dialetto, rigorosamente autonomo rispetto alle parlate dei centri viciniori.
La plurisecolare saggezza e lidentità culturale e umana degli avolesi trovano, secondo il Pignatello, la loro sedimentazione più convincente in quello che egli identifica come sermo cotidianus. Egli è persuaso che il parrari a carcarara vada praticato nella quotidianità, proprio per evitare alle nuove generazioni di avolesi il rischio della perdita della ricchezza delle proprie radici. Della suddetta espressione, parrari a carcarara, lo scrittore offre con immediatezza la spiegazione, chiarendo che lespressione deriva da carcara, fornace calcinatoria dove u carcararu cuoceva la calce viva, caucina virgini; pertanto in dialetto stretto equivale a parlare alla buona. Si tratta insomma della rivalutazione del sermo humilis che, secondo lui, savissa a sturiari ni li scoli (si dovrebbe studiare nelle scuole).
Ecco perché esterna il proprio compiacimento nel constatare come il suo desiderio non sia unutopia. Con ogni probabilità egli si riferisce alla legge regionale n. 85 del 8 maggio 1981 sullinsegnamento del siciliano nelle scuole di ogni ordine e grado, che, peraltro, non ha mai avuto reale applicazione. Allo stesso modo, più di recente, un ulteriore disegno di legge in tal senso, approvato dalla Commissione Cultura del Parlamento Regionale nel 2011, è rimasto lettera morta. Il che non mortifica ma potenzia il valore del suo voluminoso lavoro linguistico-filosofico-letterario-sociale: un dono alla comunità avolese e non solo.
Una così meticolosa attenzione alla parlata locale della città dellEsagono si spiega anche con il timore che si voglia toglierle diritto di cittadinanza in nome di una malintesa emancipazione culturale, che si esprime nel pregiudizio secondo cui il dialetto, posto incautamente per ignoranza alla stregua di una rozza deformazione della lingua nazionale, profanerebbe linviolabile tempio del sapere accademico. È questa anche una frecciata contro gli ammalati di snobismo, che vorrebbero confinare nelloblio la ricchezza culturale e umana di cui il dialetto è veicolo privilegiato.
Gli si farebbe torto, però, se la sua ricerca di modelli comportamentali che costituiscono il modus essendi degli avolesi fosse interpretato come invito a una sorta di chiusura paesana: unincongruenza al tempo del villaggio globale teorizzato da Marshall McLuhan. In realtà, la sua particolareggiata incursione nel cuore della avolesità è un appello a battersi per la crescita morale e civile della comunità avolese e un invito a non trascurare il sermo cotidianus perché molta parte della nostra vita trova in esso riscontro.
Unopportuna precisazione chiarisce il taglio specifico della sua densa trattazione: Non essendo opera di un glottologo o filologo dichiara (questo lavoro) non ha la pretesa di una rigorosa ortodossia nellanalisi etimologica di tutti i termini, ma di evidenziare il senso in essi racchiuso, talora il più recondito. Ciò non toglie che egli abbia consultato svariati e autorevoli dizionari del siciliano dall Introduzione allo studio del Dialetto Siciliano di Corrado Avolio (Noto, Zammit, 1882) al Nuovo Dizionario Siciliano-Italiano di Vincenzo Mortillaro (Palermo, Vittorietti, 1971), al celebre Vocabolario Siciliano in cinque volumi di Giorgio Piccitto, portato a compimento dopo la prematura scomparsa dellentusiasta iniziatore da Giovanni Tropea e infine da Salvatore Carmelo Trovato (Catania Palermo, Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani, 1997 2002), al Vocabolario Etimologico Siciliano di Alberto Varvaro (Palermo, C.S.F.L.S., 1986) e a tante altre opere che hanno curato particolarmente laspetto delletimologia. Certamente notevole è laiuto che il Pignatello ne ha ricavato. Va precisato tuttavia che, il più delle volte, quanto alletimo dei termini, egli ha adottato il criterio della verosimiglianza, fondandosi sullintuizione, sulla critica, sullesperienza, sullassimilazione personale, aiutate e confortate dalle (sue) reminiscenze classiche.
Queste qualità troviamo agevolmente nellimpegnativa introduzione su La facoltà del parlare ed il linguaggio, trattata dal punto di vista filosofico, fisiologico, psichico e sociale, senza escludere le sue convinzioni religiose. Che cosa rappresenta per lui il cervello? E il ponte di coniugazione fra la realtà spirituale e quella materiale, che, nel loro complesso armonico, formano luomo; è lo strumento delle operazioni dello spirito umano. Non ci stupisce dunque che lAutore citi a questo punto San Tommaso dAquino, là dove il doctor angelicus affermava che lanima, pur essendo ovunque nel corpo con la sua piena essenza, si manifesta con potenza diversa nelle varie parti di esso. Tale premessa gli serve per affermare che la mirabile sintesi di senso, intelletto e movimento, ricca di quellaltissima carica psicologica che solo la natura possiede, si attua nella funzione del linguaggio.
Queste espressioni richiamano irresistibilmente alla memoria le elaborazioni filosofiche di Louis de Bonald (Millau, 1754 1840), fondatore della sociologia ben prima di Emile Durkheim (Epinal, 1858 Parigi, 1917) e precursore dello strutturalismo. Come è noto, lo studioso francese, specialista dei meccanismi della facoltà del parlare, individuava nel linguaggio, non solo la radicale differenza ontologica tra luomo e lanimale, ma anche la prova più evidente dellesistenza di Dio. Il che è implicito anche nel Pignatello, allorché non esita a sostenere che per luomo il linguaggio esprime tutta la sua natura razionale, la sua potenza spirituale, la sua ricchezza interiore, quel quid imponderabile che trascende la materia. Che cosa sia per lui, cristiano-cattolico convinto e praticante, quel quid è facilmente intuibile dalla seguente conclusione: La parola è veramente λόγος (logos). Il che Louis de Bonald avrebbe sottoscritto senza indugio.
Di fondamentale importanza per penetrare allinterno dello spirito dellopera e riviverne lavventura è il primo capitolo: Il Dialetto della mia terra natia al vaglio dellesperienza critica e dellassimilazione personale. LAutore esplicita il ruolo e il significato che la parlata popolare assume nella vita di ciascuna persona: Il dialetto è il linguaggio che occupa il posto predominante nella vita di relazione e quindi ha strettissimi rapporti con parecchi momenti del nostro curriculum vitae. Il Pignatello ricorda con particolare commozione che le nostre mamme ci hanno trasfuso il dialetto assieme alle cure e allalimentazione infantile. Irresistibilmente allora il suo pensiero vola al periodo pre-scolastico e alla scuola elementare dove apprese il sillabario ed i primi rudimenti della nostra lingua nazionale assieme alla lettura e allo scrivere. Da quel momento il dialetto fu per lui, come, daltra parte, per la totalità dei fanciulli suoi coetanei, veicolo di conoscenza diretta ed immediata dellanima popolare, degli usi, costumi e folclore locale. Nel corso della sua esistenza, in nessun momento considerò lespressione vernacolare come una limitazione o una profanazione del tempio del sapere. Al contrario, lo studio dellitaliano, del latino e del greco gli permise di scoprire e di porre in evidenza le ricchezze nascoste nel sermo humilis.
Una volta fatte queste precisazioni, lAutore si impegna in una full immersion nel vernacolo avolese, che, insieme a indubbie e sostanziali affinità con le altre parlate siciliane, ha caratteristiche sue proprie, nella terminologia, nella pronuncia, nellintonazione, nella scrittura.
È a questo punto che, segnalando il mutamento della d in r (dente renti), della b in v (banco vancu) ecc., prendendo a modello litaliano, si sofferma sul cambiamento della doppia ll nella doppia dd, vale a dire nella cacuminale DD, il cui suono si articola appoggiando la parte anteriore della lingua al palato (quello chiDDu, capello capiDDu, stella stiDDi e così via). In tutta lopera egli trascrive la cacuminale DD appunto con due d maiuscole. Si tratta, beninteso, per intenderci, della famosa doppia d sonante, tipica della maggioranza dei vernacoli siciliani, assai vicina nella pronuncia alla d della lingua inglese, per es. del verbo to do (fare).
Il resto del primo capitolo è una puntuale analisi degli aspetti grammaticali e sintattici del dialetto avolese, su cui il lettore potrà indugiare per le sue personali riflessioni in merito a certe particolarità e diversità rispetto ai dialetti dei centri vicini. Per quanto ci riguarda, ci soffermiamo soltanto sullimperfetto indicativo dei verbi della prima coniugazione, le cui desinenze sono completamente diverse da quelle riscontrabili in tutti gli altri dialetti di Sicilia. Se prendiamo ad es. il verbo cantari, notiamo che limperfetto in avolese è il seguente: Iu cantàia, tu cantàitu, iddu cantàia, nui o nuiàutri cantàimu, vuiàutri cantàivu, iddi cantàinu. In vernacolo netino, pachinese, rosolinese ecc., invece, così suona: Iu cantava, tu cantàvutu, iddu cantava, nuiàutru cantàvumu, vuiàutri cantàvutu, iddi cantàvunu.
Unaltra annotazione di sicuro rilievo per la collocazione geografica e le particolarità del dialetto avolese riguarda il fatto che Avola costituisce la città-soglia nella quale il chiù tipico del dialetto siracusano e degli altri centri del nord della Sicilia si trasforma in ciù. In una parola, a chiavi appizzata o chiovu diventa nella città dellEsagono a ciavi appizzata o ciovu, come avviene in tutti gli altri centri del sud-est siculo.
Altra particolarità della parlata avolese è costituita dalluso molto moderato delle dittongazioni: lesatto contrario di quanto avviene nella Perla Barocca a sette chilometri di distanza, dove in dittongazioni si abbonda al punto che ivi Noto nel dialetto locale si pronuncia Nuotu. Ma su questo punto gli esempi potrebbero essere centinaia. Ci limitiamo soltanto ad alcuni termini avolesi come ventu, sentu, serra, vegnu, tempu, che, a Noto e in tutto il sud-est diventano vientu, sientu, sierra, viegnu, tiempu. Altra specificità linguistica esclusiva della città esagonale è la trasformazione di stra e stru in scia e sciu, per cui minestra diventa minescia e mastru masciu. Ben nota lespressione siciliana che recita: O ti mangi sta minestra o ti jetti ra finestra che, ad Avola, così suona: O ti mangi sta minescia o ti jetti ra finescia.
Ma eccoci pervenuti al capitolo centrale, il secondo, che rappresenta circa i quattro quinti dellintera opera e riguarda il Dizionario Dialettale Comparato, che ha pure un sottotitolo Demopsicologia (Endoscopia Popolare). Va subito precisato che il suo Dizionario non si esaurisce in un comune vocabolario, ma si propone il fine di far conoscere, nei suoi vari aspetti, il mondo della gente che parlava la lingua che costituisce largomento di questo modesto lavoro. Va rilevato che il dizionario non si limita alla elencazione alfabetica dalla a alla zeta di vocaboli dellavolese, ma contiene detti, proverbi, locuzioni proverbiali, adagi, massime, sentenze, espressioni tipiche popolari, motti, aforismi, facezie, arguzie, anchessi alfabeticamente trascritti utilizzando la lettera iniziale della prima parola di ciascuno di loro per stabilirne la collocazione in seno al Dizionario.
Una puntigliosa verifica delle voci registrate nellopera ci pone dinanzi alla presenza di circa 4200 termini, a cui bisogna aggiungere un migliaio di detti, precisando che con questo termine indichiamo linsieme dei suindicati proverbi, adagi, sentenze ecc. Dunque, nel complesso siamo dinanzi a circa 5200 voci, a cui vanno annesse 100 locuzioni proverbiali dialettali che il Pignatello ha collocato in un capitolo a parte, dal titolo Antologia di cento locuzioni proverbiali dialettali fuori testo, prese dalle miriadi così asserisce espressamente esistenti nel dialetto di Avola di ieri e ancora fiorenti ai nostri giorni.
A tutto ciò, bisogna associare un altro migliaio di detti, riportati e il più delle volte tradotti e comunque spiegati in italiano. Numerose sono anche le citazioni di termini arabi, greci, latini, italiani, francesi, spagnoli, turchi ecc. che, a suo avviso, aiutano a spiegare lorigine e la presenza nel vernacolo avolese delle parole e locuzioni da lui registrate nel Dizionario. Non di rado, poi, quando il risalire alletimo è dubbio o non convincente, lAutore si affida al suo fiuto di uomo di cultura, alla sua erudizione e alla sua esperienza di vita.
A questo punto non possiamo eludere alcune considerazioni che ci vengono imposte dai conteggi numerici effettuati e sopra riportati. Il Pignatello registra dunque circa 4200 vocaboli del dialetto avolese che arricchisce con i numerosi detti. Malgrado tutto ciò, se consideriamo che un normale vocabolario italiano, francese, tedesco, spagnolo, ma anche siciliano contiene da 20000 a 30000 voci e oltre, ci chiediamo quale sia stato il criterio dellAutore nellescludere gran parte dei vocaboli peraltro di uso comune. Ci limitiamo a qualche esempio per meglio intenderci. Non cè traccia nel suo Dizionario di termini di uso quotidiano come maestru, prufissuri, bidellu, divanu, segretariu, caccia, cacciaturi, miningiti o meningiti, pleuriti, tila (tela), sacristanu o sarristanu, sogghiru/a (suocero/a), jenniru (genero), nora (nuora), cucinu/a (cugino/a), ziu/a, ottobri o utturuu, ricembri o ricemmuru, novembri o novemmuru), campusantu, firraru (fabbro ferraio), pinnula (pillola) et cetera et multa cetera.
Non avendo la possibilità di confrontarci con lui per ottenere una chiarificazione plausibile, non possiamo esimerci dallobbligo di formulare alcune ipotesi esplicative. In primo luogo, è probabile che egli abbia limitato il suo interesse ai vocaboli che maggiormente caratterizzavano il dialetto stretto avolese degli Anni Trenta del Novecento. Se così fosse, verrebbe potenziata la convinzione, che poi è un dato di fatto, che suo obiettivo nel redigere il Dizionario è di sostenere la memoria storica dellessere avolese in forma simpaticamente estremista, fornendoci una summa della condizione esistenziale dei suoi concittadini con particolare riguardo a quelli di modesta condizione, prima che il vento di una dubbia emancipazione e di uno sviluppo schizofrenico, disordinato e senza progetto ne scuotesse dalle fondamenta i valori umani conquistati nei secoli, esponendo lessenza della avolesità al rischio di estinzione, tuttaltro che peregrino nellepoca della globalizzazione.
Ad ulteriore conferma di questa ipotesi osserviamo lesclusione di vocaboli come radiu, televisioni, schermu, canali, comodinu, settimanili, terrazza, albergu, nuvula, cassettu, immagini, cuperta, linzolu, tavulu, vacca, ma lelencazione potrebbe continuare con centinaia, anzi migliaia daltre voci mutuate dalla lingua italiana e non originariamente sorte in seno al dialetto né sottoposte alla sua mediazione. A maggior ragione, lassenza totale di termini attinti o desunti dalla cibernetica, dallinformatica, dalla telematica e dalle neuroscienze non ha bisogno di alcuna spiegazione. Nulla essi hanno a che vedere con il dialetto stretto che, negli anni pre-bellici e fino a buona parte degli anni Cinquanta, era predominante ad Avola, come in tutto il resto della Sicilia, rispetto alla lingua nazionale che già subiva, a sua volta, le prime contaminazioni dallinglese e dai linguaggi scientifici internazionalizzati. Non si tratta è bene chiarirlo di opposizione acritica ai fenomeni della modernità e post-modernità, ma di semplice fedeltà alle finalità che egli si proponeva nel suo vastissimo e impegnativo lavoro, da cui emerge la palpitante identità culturale e la ricchezza spirituale del popolo avolese e del suo molto colorito vernacolo.
Limpegnativo lavoro di Giuseppe Pignatello, modello esemplare dellavolese laborioso, tenace e determinato nel portare a termine ogni fatica a qualunque costo, contiene un capitolo, il quarto, intitolato Le Denominazioni, che elenca in ordine alfabetico ben 226 toponimi del territorio avolese, assicurando sempre unadeguata spiegazione della loro origine e significazione.
Al punto b del capitolo quarto troviamo una lista di 92 nomi propri di persona, ma con tutta evidenza volontariamente non esaustiva, al punto da escludere, solo per attestarci a un solo esempio tipico, il nome di Sebastiano, Vastianu o Janu, che è di gran lunga il più comune ad Avola grazie al fatto che il compatrono locale, accanto alla patrona Santa Venera, è San Sebastiano. LAutore sceglie e riporta, in realtà, i nomi propri sovente con i diminutivi caratteristici se non esclusivi del luogo e precisa che ha considerato lonomastica avolese nelluso, nel costume e nellhumour popolare della Avola di ieri. Ecco perché nomi propri come Vastianu o Armandu, così per dire, non avrebbero aggiunto alcunché a quanto già metabolizzato linguisticamente dalla popolazione avolese.
Pregevole infine è lappendice con componimenti di tre poeti dialettali locali. Struggenti i versi che il contadino analfabeta Antonino Inturri, inteso Lucerta, analfabeta, cieco e abbandonato dai figli, compose in memoria di sua moglie Angela Cassibba, morta tragicamente il 1° novembre 1881 in contrada Cavalata, in seguito allo straripamento del torrente a causa delle incessanti piogge.
Ne trascriviamo alcuni: Arma di lu mè pèttu Angilìna/ a lu to spùsu mmèmzu e vài lassàsti,/ n-navìssi agghiurnàtu mai ssa matìna/ jòrnu ri tutti li Santi nnuminàtu (Anima del mio cuore Angelina/ il tuo sposo hai lasciato in mezzo ai guai,/ ah se non si fosse fatto giorno quella mattina/ giorno di tutti i Santi nominato).
Ci sembra questa una conclusione idonea per porre in evidenza, più che lopportunità, la necessità storica del voluminoso trattato di Giuseppe Pignatello, che, con scienza, coscienza, umiltà e sapienza ha rappresentato con grande efficacia la straordinaria vitalità e i notevoli pregi del dialetto avolese, del sermo humilis della sua amata terra natia.
Un tesoro che spetta agli avolesi, ma anche ai linguisti e agli appassionati di demologia, custodire rispettosamente e con amore.
Angelo Fortuna
|
| 63) |
Gracia Maria Schirinà |
| graziamaria.schirina@gmail.com |
Località:
Avola |
  |
|
Umberto Confalonieri
È gioia anche per voi POESIE
2016, 8°, pp. 56
Libreria Editrice Urso
Collana "ARABA FENICE" n. 229
10,00 ISBN 978-88-6954-060-8
Salone Paolo VI, Avola 14 ottobre 2916
Nuove note per Umberto: È gioia anche per voi
Da settembre a settembre, un percorso che nellimmaginario poetico dura un anno, un anno nel quale si cerca di fare chiarezza, anche se da Settembre a Un altro settembre, gli ossimori presenti lasciano presagire che in questa ricerca cè ancora una fase di incompiuta indeterminatezza. Così il tepore che avvolge, nella prima lirica, diventa straziante e, nellultima, le ferite sono gioiose. Ma settembre è il mese dinizio in cui ci si rimette in movimento dopo la pausa estiva, che ci ha regalato momenti vari e diversi; è il mese del bilancio e della speranza, tempo di fine e di inizio di nuovo cammino e di nuove speranze.
È il periodo del bilancio, ma, la cosa più importante, in questo percorso, è avere la consapevolezza di avere conosciuto il sé nascosto nelle intime fibre del proprio cuore (36).
In tutto 45 liriche in versi liberi e di varia lunghezza, testimonianza di vita vissuta nella sofferta ricerca del senso da dare alla propria vita.
Da queste liriche si deduce la sensibilità del poeta, la gioia di vivere e la volontà di fare chiarezza nelle scelte di vita, allontanando il superfluo che addobba il fuori e inaridisce lanimo (18). Non consiste nel culto dellesteriorità lamore che andiamo cercando (pag. 42); lamore per il quale si vive non appartiene al mondo fisico, non è fatto di materia ma di puro spirito, anche se la sua manifestazione fisica la possiamo vedere trasparire attraverso lo sguardo, riflettendo le pupille in quelle dellaltro, soprattutto quando laltro è unumanità sofferente, bisognosa di aiuto. È un amore disinteressato. Quando ciò si verifica e si entra in sintonia, lo stesso sguardo inebria e fa cadere in amore (20), quasi in un processo estatico e purificante nello stesso tempo.
I contenuti sono critici e riflessivi nei confronti dei comportamenti personalissimi e di chi gli sta accanto, volti alla ricerca di sé tramite un linguaggio lirico e composito allo stesso tempo, nel quale predomina un Tu ora scritto in maiuscolo ora in minuscolo, a fare notare la differenza concettuale del proprio percorso, in un atteggiamento che va dal Trascendente alluomo e viceversa. A volte un po oscuro, il linguaggio adoperato è tuttavia carico di una forte spinta emozionale, determinata dalla adesione vissuta alla tematica trattata.
Il dubbio e la ricerca di sé, che pervadono tutta la silloge, sincrociano col bisogno dellaltro che non può essere dimenticato (11); solo con lascolto ogni incomprensione può essere dissipata e la parola diventa latrice di conforto e schiude il cuore alla speranza.
Se tuttavia lapertura allaltro è importante, e ne è testimonianza anche il tu generico di riferimento, mi piace cogliere in questi versi un percorso in solitudine, perché solo facendo deserto si può entrare nellintimo e ritrovare non solo se stessi, ma addirittura un dialogo con il Trascendente, un intimo conforto di cui si va alla ricerca (12).
Come si diceva, i temi fondamentali sono quelli relativi alla scelta di vita (13), al tempo che avanza con la paura che sia infruttuoso (15) e alla consapevolezza degli errori commessi, anche quando dopo le cadute cè sempre la capacità di rialzarsi, di guardare con bonaria serietà alle proprie difficoltà (34) e di andare incontro ai propri sogni (17); la paura inoltre che le proprie preghiere non vengano ascoltate e di non riuscire a operare secondo il progetto di vita che lo riguarda (18).
La vita, sebbene il dono di sé è vero e appassionato, non è mai facile, perché le fatiche riescono a piegare il corpo.
Ogni tanto fotogrammi del precedente vissuto riaffiorano alla memoria quasi a voler evidenziare un prima e un poi dello spaccato di tempo vissuto; spezzoni di vita diversa e certamente più spensierata rispetto alla nuova consapevolezza (19/30), che sembra di tanto lontana e che invece è ancora alle porte, anche se sentirsi legato a una storia, seppur piccola, determina il senso dellappartenenza a una comunità, ed è rassicurante fare parte di un tutto al quale si appartiene (38); lorizzonte ora si fa più chiaro ma la situazione di crescita comporta un senso di dolore anche fisico che stringe il cuore mentre la vita va avanti e la mente vola oltre (24) e si dirige verso gli affetti più cari, al calore misericordioso del padre (25) e alla carezza della madre (27) sul cui volto, quandanche stanco, risplende il sorriso (40), alle preoccupazioni di entrambi dinanzi alle quisquilie quotidiane (37).
Ma bisogna imparare a conoscersi, a sapere qual è il progetto di vita personale, il colore e il sapore della vita e la risposta, che il poeta si dà, è che, solo vivendo il dono di cui si è portatori inconsapevoli, si troverà la chiave dellamore (26). Solo infiammati così si può andare avanti con fiducia e percorrere il cammino assegnato.
Se poi, come è il caso del nostro autore, a infiammare è la fede, allora tutto diviene realmente più semplice e la gioia della vita verso cui si tende, pur quando la fatica del cammino intrapreso sarà pesante (35), diventa la realizzazione di un sogno, il proprio sogno, che non bisogna mai dimenticare (32); in definitiva, diventa Amore (31) per lumanità intera.
Cuore e testa, se riescono ad andare in sintonia, riusciranno a produrre i fotogrammi della vita tra i sogni e la realtà (21), a trovare la necessaria forza di decidere in autonomia e scansare lumana indifferenza (44).
Luomo è solo sempre di fronte alle scelte individuali, ma la solitudine è proficua, perché apre le porte della comprensione, dellascolto e della giustizia (50); e tuttavia le sue giornate, se vissute in sintonia con se stessi, saranno piene di gioia, di speranza nel dolore e di promesse di certezze (45): sarà gioia anche per lui. Certamente il periodo intercorso tra un settembre e laltro ha aperto cuore e mente in solitudine e ascolto, ha determinato nuove conoscenze ed esperienze che hanno favorito una nuova maturità. Si può dunque ripartire verso una nuova ricchezza.
Grazia Maria Schirinà
|