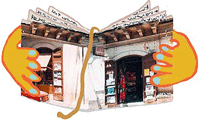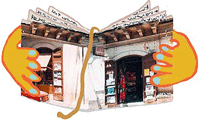| Nome |
Riflessioni con eventuali Commenti |
| 39) |
Erika Coffa |
|
Località:
- |
  
|
|
 Venerdì, 4 Giugno 2010 00:54 Host: 93-46-35-153.ip105.fastwebnet.it

Natalia Romano, I colori del silenzio - Racconti,
Libreria Editrice Urso, Collana Opera prima n. 13, 2008, 8°, pp. 88, Euro 10,00
...ho fatto una sintesi a modo mio del libro di Natalia Romano.
Il libro mi è piaciuto moltissimo. Tutte le storie erano belle, però a dir la verità mi hanno colpito particolarmente questi racconti:
LA COSA PIU' IMPORTANTE
Una ragazza di nome Lisa che è felice di esistere, si pone mille domande su come era nata e perché non era nata durante nove mesi come le altre ragazze della sua età. Lisa è quasi perfetta, tranne che per un motivo. Un pomeriggio cercava di prepararsi per la serata che avrebbe passato da un'amica, e siccome voleva essere carina per un ragazzo aveva deciso di prepararsi al meglio. Mentre cercava gli orecchini a forma di rosellina, trova qualcosa sulla sua nascita. Da lì scopre che era artificiale e che i suoi due fratellini non erano riusciti a sopravvivere. Poi, però, si guarda allo specchio e vede una ragazza carina, dolce e vera. Perciò, non è diversa dalle altre. Lei, Lisa è una ragazzina come tutte ed è felice di esistere. Ed è questa la cosa più importante.
AL DI LA' DEL SILENZIO
Siamo più o meno durante la seconda guerra mondiale, ai tempi della Shoah. Un bambino di nome Karl, vede piangere spesso sua madre. Il bambino pensa che forse è per la morte di persone che conosceva.Ogni giorno moriva qualcuno. Forse sua madre piangeva perché era sparito suo padre. Un giorno li fecero mettere in fila e decisero se mandarli "a destra o a sinistra". Il bambino, la madre e la sorellina andarono a destra, mentre il papà a sinistra. Quella sera la madre li mette a nanna. Dopo un bel po' la mamma sveglia i bambini e gli raccomanda di nascondersi. I soldati che, nel frattempo entrano in casa, trovano subito sua sorella Catrina e la portano via. Invece, non trovano Karl. Karl quella notte va da un signore con gli occhi buoni. Il bambino si sveglia quando è giorno. Vede che i soldati puntano il fucile a tutti loro e li fanno andare verso una collinetta. Arrivati sulla collina sente tanti spari e dopo un po' anche lui va al di là del silenzio, come Catrina e il suo papà.
Niente male, eh?
A proposito di libri ho trovato due frasi bellissime.
La prima è: "Essere liberi è un dono, essere semplici è un dono. Un dono è trovare il posto giusto per noi".
La seconda, la mia preferita, è: "Bisogna scrivere la verità e metterci dentro il cuore".
Erika Coffa
|
| 38) |
Raffaele La Capria  |
|
Località:
- |
  |
|
 Venerdì, 7 Maggio 2010 17:02 Host: 93-46-17-93.ip105.fastwebnet.it

Raffaele La Capria
Trascrizione dell'intervento tenuto a Napoli
presso l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
in occasione della presentazione del romanzo
GILBERTE di Ignazio Apolloni
edito dalla Editrice Novecento
Io e Ignazio Apolloni ci conosciamo poco in realtà, questa sera è una delle poche volte in cui ci siamo incontrati, un'altra volta è stata a Palermo fuggevolmente. Il nostro era un rapporto soltanto epistolare dove lui, con l'ironia che gli appartiene, tante volte ha commentato alcune cose mie che aveva letto, e così ha sollecitato la mia curiosità. Io mi sono interessato a quello che faceva proprio perché è completamente diverso da me. Lui ha tutto l'estro, la genialità, la complicazione e direi anche la pazzia della gente siciliana, mentre invece io sono un napoletano, nato sotto la costellazione di Benedetto Croce, con forti tendenze illuministiche, quindi razionale. Lui è un irrazionale, per lui tutto ciò che è irrazionale è fondamentale, ciò che è razionale invece è da capovolgere. E forse non ha tutti i torti se vediamo che il mondo va più sulla strada dell'irrazionale che sulla strada delle cose razionali. È razionale quello che sta succedendo in Iugoslavia? È una cosa del tutto irrazionale, però accade; e purtroppo è questo il destino dell'uomo, di sapere come le cose dovrebbero essere e invece comportarsi in maniera contraria. Questo è l'Irrazionale, per me. Tutti sanno, per esempio, che la guerra è terribile però tutti fanno le guerre da sempre, da quando c'è la storia. Io però non ritengo superiore chi è razionale, penso che c'è una lotta continua tra i due estremi, da sempre, e ciò fa parte del mondo umano. Apolloni ed io pensiamo cose diverse sulla letteratura, sulla bellezza e soprattutto sul fare artistico, su come si scrivono i romanzi. Siamo diversi, e che male c'è? Però nonostante tutte le nostre diversità io credo che ci sia tra me e lui quella curiosità per ciò che è diverso da sé, che può rendere vivo uno scambio di idee e interessante un rapporto. Se due sono d'accordo su tutto non hanno niente da dirsi, mentre invece due che sono in disaccordo su tutto, come me e Apolloni, hanno molto da dirsi. Apolloni è uno scrittore di favole, di strane favole alla rovescia che non sembrano le più adatte da far leggere ai bambini, ma frantumate come sono e spesso legate a significati metaforici troppo ardui per una mente infantile, sono destinate ai grandi. È un autore che ama moltissimo l'artificio letterario e costruisce complicati enigmi narrativi, come avete sentito stasera dalle bellissime spiegazioni che hanno fatto del suo libro i relatori che mi hanno preceduto, D'Ambrosio e Fracchiolla. Lui costruisce enigmi narrativi complicati che per descriverli ci vuole un po' di tempo, e si nasconde sempre dietro inaccessibili e misteriosissimi labirinti mentali. Tutti i siciliani sono un po' così, ma lui in ciò rivela proprio di essere un figlio della sua terra ed è questo pure che lo rende interessante, perché non è che gli scrittori nascono così per caso e come le bolle di sapone. Nascono per delle ragioni ataviche, storiche, antropologiche in un determinato ambiente culturale; i siciliani con i bizantini, e gli arabi hanno una cultura dietro le spalle che è un po' un arabesco, proprio come è un arabesco questo romanzo di Apolloni intitolato "Gilberte". Lui è un romanziere che non ama le storie e non ama i personaggi, non ama le forme concluse del romanzo. L'avete sentito - è stato spiegato talmente bene che è inutile insistere su questo aspetto - lui è un affabulatore inarrestabile. Senza nessuna voglia di denigrarlo dico che è uno che si gioca la chiacchiera, così si dice a Napoli di uno che è abile con le parole. È uno scrittore, come è stato detto, che non ama il centro ma l'eccentricità e dunque la frantumazione, il non-sense, la digressione e così via. Insomma lo avete capito già, lui è uno scrittore sperimentale nel senso più vero della parola perché può dire di sé quel che diceva il nostro Giambattista Vico "conosco facendo" anzi nel caso suo sarebbe meglio dire "mi conosco facendo". Cioè man mano che lui scrive, si definisce, sa chi è, si scopre, lui insomma si conosce scrivendo i suoi libri autoreferenziali ed avvolgenti, omninglobanti come questo metaromanzo intitolato Gilberte che se dovessi riassumere e dire in due parole di che si tratta mi troverei in forte imbarazzo perché è difficile sintetizzarlo. Diciamo che si tratta di un viaggio, di un viaggio in cui ricorre in varie accezioni e con vari cognomi - il nome di Gilberte; così come con varie accezioni cioè con vari cognomi ricorrono e vengono menzionati molte celebrità, attori cinematografici, scrittori ecc... Diciamo ancora che questa Gilberte viene continuamente inseguita in varie città del mondo e in vari continenti da un io narrante di professione fotografo oppure che ha per alter ego un fotografo di professione; un fotografo che usa macchine le più insolite, come l'io narrante usa stili e tecniche sempre diversi per narrare episodi, anch'essi apparentemente sempre diversi e staccati l'uno dall'altro, uniti soltanto dall'intenzione dell'autore che dichiara - divagando da un argomento all'altro - che l'organicità di un'opera nasce appunto dalle intuizioni dell'autore, il risultato soltanto, dal caso. Questa è una definizione che dà lo stesso Apolloni ed è, secondo me, perfetta per indicare il suo modo di scrivere.
Con i paradossi Ignazio Apolloni è di casa, lui sostiene sempre cose paradossali, anche quando scrive una lettera. Sostiene, ad esempio, che si può criticare un libro senza averlo letto e forse non sa che qui fu preceduto da Emilio Cecchi che alla domanda di uno scrittore: "Maestro, cosa pensa del mio ultimo libro?" rispose: "Non l'ho letto; ma non mi piace". Sostiene Apolloni che tutto ciò che è regola, tutto ciò che è ordine anche del pensiero e della fantasia va rovesciato: e figuriamoci come ci resto io che sono invece un sostenitore del senso comune e lo ritengo in questo periodo in cui assistiamo al prevalere di tanti assiomatici concettualismi un prezioso strumento di interpretazione del mondo. Così come ho scritto nel mio libro La mosca nella bottiglia che è appunto un elogio del senso comune. Quindi lui è proprio tutto il contrario del senso comune eppure noi due ci parliamo e discutiamo dei nostri libri. Mi sembra così di avere sottolineato a sufficienza le differenze, direi anche le incompatibilità tra me e Apolloni nel campo letterario. Però questa differenza, come dicevo, mi offre una buona occasione di guardare con occhio estraniato, perciò credo abbastanza oggettivo al suo lavoro di scrittore e al suo continuo work in progress. Così quando ho ricevuto in lettura quest'ultima sua opera Gilberte, questo romanzo sui generis così lontano dal senso comune, ho visto nella sua costruzione, nella sua concezione, nel suo stesso picarismo intellettuale, nella sua erranza concettuale, il riflesso di tutta la personalità, l'esuberanza, e come ho detto prima la pazzia e l'estro del suo autore, e anche della Sicilia da cui proviene. Non sono qui per darne un giudizio, l'ho detto prima, non vorrei dare un giudizio critico ma solo portare una testimonianza e per ciò dirò che Gilberte mi pare uno di quei libri monstre che finiscono per possedere il loro autore avvolgendolo nelle loro spire e fagocitandolo, vampirizzandolo. È la creatura che possiede il suo creatore: questo succede in letteratura, e molti capolavori sono stati concepiti così. Joyce ne sa qualcosa, Finnegans Wake è un romanzo che possiede alla fine il suo autore; e Musil non fu posseduto da "L'uomo senza qualità"? Io non voglio dire con questo che Gilberte può essere paragonato a questi capolavori, io parlo di una tipologia, di un certo tipo di romanzo che si trasforma per il suo autore in una specie di incubo dal quale bisogna uscire in qualche modo tentando tutte le possibili strategie. Credo anche che un altro siciliano, l'autore di Horcynus Orca, il messinese Stefano D'Arrigo si sia trovato in una situazione simile, cioè con un libro che lo possedeva e con cui doveva fare i conti, come si fanno i conti, appunto, con Horcynus Orca. Dunque romanzo monstre, vischioso, che cresce per accumulo, ma anche romanzo che nega il romanzo tradizionale, e qui abbiamo il nouveau roman come ha spiegato il prof. Fracchiolla e come si desume anche da quanto è stato detto dal prof. D'Ambrosio.
Però io qui vorrei proporre dei riferimenti un po' diversi dopo aver detto che questi che finora sono stati rapportati al nouveau roman descrivono bene il carattere del libro. C'è un dato del nouveau roman che è proprio quello del romanzo dello sguardo cioè delle cose che cadono sotto lo sguardo, delle cose nude, esattamente come lo sguardo le coglie, chiuse in sé stesse e non interpretate ma solo viste, la pura visibilità; e questo successe quando cominciarono a tentennare le interpretazioni del mondo, le ideologie ecc: e quindi la filosofia fenomenologica, cioè quella che il mondo non lo interpreta ma lo descrive e che ebbe un forte influsso in quegli anni. Io penso che nouveau roman, l'idea di scrivere soltanto di ciò che si può constatare non di ciò che si può interpretare, fosse anche un modo di entrare in quel mondo di idee che circolavano allora. Ecco, tutto ciò che fa pensare ancora, e infatti i romanzi di Robbe Grillet lo sono, a romanzi un po' secchi, un po' magri, non a dei romanzi fluviali come quello di Apolloni.
Quello di Apolloni è una affabulazione fluviale con gorghi, con cateratte, vortici, insomma è come un'acqua che scorre, un'acqua trascinante di parole che corre in tutte le direzioni verso una foce che non si sa bene quale sia: però forse è la narratività stessa quella corsa dell'acqua di questo romanzo fluviale che è Gilberte. Nel mio libro Letteratura e salti mortali io affermo che i più grandi romanzi del '900 rispetto a quelli dell'800 sono dei romanzi non riusciti. In che senso? non per difetto dei loro autori, ma per costituzione, per necessità epocale, per fedeltà allo spirito e alle contraddizioni del tempo. E sono stati classificati così perché sono tutti in qualche modo dei romanzi di cui il dato principale è che non sono completi come un romanzo di Stendhal oppure di Tolstoi o come un racconto di Cechov. Tra le caratteristiche di questi libri non riusciti c'è da un lato l'incompletezza, cioè sono dei romanzi non compiuti, romanzi virtuali che il lettore deve completare con la sua collaborazione. Questa incompiutezza a volte è tale per scarsità, cioè si tratta di romanzi magri che non danno nessun appiglio, come per esempio i libri di Bataille; invece certe altre volte sono incompiuti per prolissità. Come per esempio Sade. Sade è un romanziere prolisso, ha scritto dei romanzi non riusciti che però sono importanti. Io non li amo, però sono importanti per definire lo spirito della nostra epoca.
Il libro non riuscito tipico del '900 è quello che lascia sempre le cose e il significato in sospeso perché nel nostro universo mentale, in questo universo del 900, non ci sono delle conclusioni che si possano trarre, siamo tutti "tra color che son sospesi". Ecco, allora che anche quando è sovrabbondante, un romanzo non riuscito - e "Gilberte" appartiene a questa categoria - non dice mai tutto quello che potrebbe dire. La scrittura appare solo come la parte visibile di un iceberg concettuale che sta sotto, invisibile, e che lo sostiene. E infatti tutto ciò che abbiamo sentito prima, quando è stato descritto il libro, è la parte sommersa dell'iceberg, che è stata spiegata molto bene e che ci fa capire meglio le ragioni di questo libro. La parte invisibile dell'iceberg, questa parte concettuale, è caratteristica di tutti i libri del '900 e di tutti i libri non riusciti di cui parlavo prima.
Lo scompenso tra la realizzazione e la concettualizzazione nascosta è appunto la caratteristica più notevole dei romanzi non riusciti del '900. A volte questi romanzi di cui parlavo, questi romanzi non riusciti per essere capiti hanno bisogno di un commento che appunto ne riveli la parte nascosta. Bisogna, insomma, certe volte capirli prima di leggerli. Per esempio i libri di Bataille prima li devi capire e poi li devi leggere. E un po' anche i libri di Apolloni sono così, li devi capire prima; devi capire come si muove questo scrittore, solo così diventa leggibile, se no ti sembra di entrare in un universo in cui le cose stanno tutte sottosopra, come in Alice nel paese delle meraviglie.
Infine nei libri che dico io, il dominio della forma, della struttura, è assolutamente prevalente. Perché? ma perché la forma e la struttura del libro dicono ancora più di quanto non possono dire le parole stesse esplicitamente.
Faulkner, sosteneva che per lui l'unico metro per valutare un libro e per giudicarlo "era il rischio e l'importanza del fallimento". Cioè quanto più un libro rischia di fallire tanto il libro era più bello e più importante. Quindi questa, secondo me, è una regola che si può applicare a tutto il '900 e si può applicare anche ai rischi che corre questo libro Gilberte perché più rischia di fallire più importante diventa l'impresa di scriverlo. Questi elementi di cui ho discorso si trovano per me anche in Gilberte.
Ora concludo. Ho fatto una ipotesi di classificazione di questo libro per inserirlo in un certo ambito e ho detto che può essere inserito nell'ambito dei libri non riusciti del '900, dei libri valutabili attraverso il rischio che corrono di fallire, attraverso il rischio del fallimento. Però vorrei fare anche un altro possibile riferimento e mi rifaccio a un libro molto importante nella letteratura e che ha avuto un'interferenza notevole fra gli scrittori di oggi, parlo del libro di Sterne, Tristram Shandy. È un libro scritto alla fine del '700 da Sterne che era un genio della digressione, ed è un libro fatto tutto di digressioni: dopo di lui gli scrittori hanno capito che si poteva anche scrivere un libro senza raccontare una storia filata ma una storia di episodi scollegati purché racchiusi in una cornice. E penso anche agli scrittori che sono venuti dopo, per esempio a Dos Passos e al suo 42° Parallelo o a New York, e a tanti altri scrittori polifonici, che hanno usato più voci per raccontare una storia, e non un'unica voce, la voce dell'io narrante. Ma ancora più ho pensato - sempre riferendomi a questo libro - a due libri che hanno avuto molta influenza su di me come lettore quando ero ragazzo, uno è Le onde di Virginia Woolf, che sono proprio le onde della narrazione, sono tante pagine di narrazione intorno a personaggi un po' vaghi che non raccontano proprio delle storie, sono come degli episodi che sempre uguali si rincorrono come le onde e vanno tutte a morire, come le onde, sulla spiaggia ripetendo sempre lo stesso movimento e la stessa musica. Oppure un altro libro sempre di Virginia Woolf che ebbe pure molta influenza su di me quando ero ragazzo Orlando. Orlando è un altro tipo, è una figura come Gilberte, corre però attraverso i secoli: c'è stato anche un film dove si vedeva questo Orlando che è un personaggio che si trasformava attraverso i secoli; era sempre lui però. Nel '300 era in un modo, nel '400 si manifestava in un altro, nel '600 in un altro ancora. Ora non mi ricordo più il film come si chiamava ma insomma così come Orlando attraversa i secoli anche Gilberte attraversa mutando e trasformandosi continuamente, paesi, continenti, epoche della storia. Se tutti questi riferimenti che io ho fatto a questi libri dovessero essere definiti e sintetizzati con una sola parola, io direi che tutti questi sono libri di metamorfosi proprio nel senso del libro di Ovidio, nel senso di Ovidio. Ovidio è il nume tutelare dei libri di metamorfosi e Gilberte è un libro di metamorfosi.
Questa è la mia definizione e chiuso.
|
|
|
 Sabato, 24 Aprile 2010 00:36 IP: 151.76.142.106

"Ho toccato l'Italia col piede destro" è un libro meraviglioso da bere!!! E' invidiabile come questo giornalista sia riuscito con la sua caparbietà, costanza e preparazione ad arrivare dove tanti sognano. Chi vuole passare 2 o 3 giorni lieti e conoscere cose nuove non ha che da leggerlo. Maurizio
|
| 36) |
santo  |
| santo.dipasquale@yahoo.it |
Località:
livorno |
  |
|
La primavera di Palma, di Salvatrice Vilardi (Edizioni Smasher).
In questo romanzo, la scrittrice Salvina Vilardi ci presenta uno spaccato della Sicilia a cavallo tra gli anni ’30 e ’40, raccontato attraverso le parole della zia Palma, che sgrana, capitolo dopo capitolo, come in un rosario, i trascorsi fondamentali avvenuti all’interno della sua famiglia: le nascite, le gioie, i matrimoni, i dolori e i lutti, non mancando di presentare uno spaccato reale della Sicilia di allora, piena di povertà e miseria.
Un romanzo avvincente, che cattura sino alla fine, con una tecnica descrittiva trascinate, che rapisce il lettore e lo immerge in un mondo, quello della zia Palma, dove le emozioni, gli odori, gli umori, i paesaggi e i personaggi diventano talmente reali, da essere quasi tangibili al lettore.
|
| 35) |
Benito Marziano |
|
Località:
- |
  |
|
 Lunedì, 14 Dicembre 2009 01:29 Host: 93-46-19-89.ip105.fastwebnet.it

Benito Marziano per Memoria aggiunta di Giovanni Stella
Ricevere in dono un libro e' cosa sempre gradita, se poi il dono viene da Giovanni Stella, si tratta di una sua opera e inoltre e' accompagnato da una dedica che esprime i sensi di una sincera amicizia, il gradimentomoltiplicato.<br>
Il libro in questione e' Memoria aggiunta, ultima opera di Giovanni Stella, pubblicato in sedicesimo, con una copertina raffinata nella sua semplicita', nella ''Collana Omnia'' della ''Libreria Editrice Urso'' di Avola.
Non appena l'ho avuto in mano, ero nella libreria di Ciccio Urso, dove l'amico Giovanni me l'aveva fatto recapitare, ho aperto la busta, ho cominciato a sfogliarlo, ho letto l'indice e poi la nota di presentazione del prof. Giorgio Bárberi Squarotti, una nota intensa nella sua brevita', che da' la misura dell'alto valore di questa ultima fatica di Stella.
Il volume presenta scritti di vario argomento raggruppati per tema. Cosi', abbiamo all'inizio dei brevi ritratti di noti professionisti suoi amici; seguono poi alcune note di un suo recente viaggio a New York; delle recensioni di opere
letterarie; alcune note su sue vicende personali attinenti alla salute; altri
brevi ritratti di grandi figure; alcune considerazioni attinenti a problemi
della sua professione; e a chiusura due liriche, di cui una rappresenta una
sorta di doloroso diario dedicato alla madre.
La penna felice di Stella raggiunge, come sempre, livelli cosi' alti di espressivita' e di buona lingua da fare un piccolo capolavoro di ogni scritto, e particolarmente di quella sezione consistente in ritratti di amici, alcuni magari gia' perduti, che nel suo ricordo appaiono circonfusi da un alone di grandezza e dignita', anche, forse, grazie alla sua impareggiabile affettuosita'.
La prosa, qui, si contamina spesso di poesia. Voglio per tutti ricordare, Per Paolo Montoneri , dove, ripercorrendo nellememoria i loro incontri e i loro dialoghi, scrive: ...<i>resteranno in me, nel mio cuore, nei miei ricordi - finche' memoria concedera' - come i momenti piu' alti, piu' belli, piu'lirici ed appaganti del veloce transito...
A questa sezione segue quella degli Appunti di un viaggio a New York (2009), vero, pur se breve, diario odeporico ricco di osservazioni e riflessioni sulla citta', sulla societa', sulla vita e sulla strana democrazia statunitense. Ma, in proposito, preferisco far parlare lo stesso Stella con la sua ineguagliabile efficacia e la
sua prosa affabulatrice: ''Il 'Village' e' un tuffo nell'umana civilta' dove l'uomo ancora misura se stesso resistendo e sopravvivendo a cio' che poco piu' in la' e' diventato: un minuscolo elemento di un ingranaggio gigantesco che lo fagocita e ne annienta la dimensione. (1. Quelle urla al Villane).
Andando in giro per il Villages'imbatte in un edificio, del quale preferisco che parli direttamente Stella, perche' sarebbe impossibile sostituirne la tensione che riesce a comunicarci: <i>Una scritta su due lati, pitturata in bianco e nero su legno
incastonato a muro, dice ''Norther, fondato nel 1827''. Si legge nella guida turistica che il palazzo, a tre piani
fuori terra, fu destinato a offrire assistenza gratuita ai poveri. </i>
<i>''Assistenza gratuita, negli Usa?'', mi sono chiesto. Ma qui, se un essere umano cade a terra colpito da infarto, frattura o qualche altra cosa, e' portato in ospedale solo se e' munito di carta di credito o assicurazione medica, viceversa, resta si trova nella indifferenza piu' totale dei passanti.
Ma da quell'edificio, il Nostro aveva sentito provenire delle urla che, ora, rendendoci partecipi di una situazione quasi onirica, scopriamo provenire si' da
quell'edificio, ma soltanto nella fantasia di Stella, perche' quelle urla... e lascio ancora alla sua fervida penna di appagare la vostra curiosita': Ma quelle urla erano sempre piu' rabbiose e forti e turbavano l'assoluto silenzio d'intorno.
Penetravano i miei timpani, sconvolgevano il mio animo.
Erano urla senza tempo... Fra gli ospiti del nosocomio era stato ricoverato Edgar Allan Poe.
E nel tentativo di volere entrare nell'edificio sbarrato con lucchetti, si trova davanti: Appoggiato al tronco di un albero spoglio, proprio di fronte all'ingresso, alle mie spalle, silente sostava un giovane sui trent'anni, forse trentacinque, non essere piu' preciso sull'eta'. quanto accade dopo assume dei toni che, dice l'autore stesso, gli sembra di vivere un'atmosfera
surreale, e qui mi fermo perche' non desidero privare il lettore del piacere
di leggere questa pagina particolarmente avvincente.
Seguendo il nostro amico nella sua passeggiata, ci veniamo a trovare Harlem. (2 Il bambino di Harem). Dopo un breve ricordo del lungo travagliato cammino dei neri Stati Uniti per raggiungere la loro emancipazione e dell'immenso contributo portato a tal fine da Martin King, ci racconta
di una passeggiata nelle strade di Harlem, durante la quale non perde
l'occasione di qualche chiacchierata con alcuni abitanti del luogo, spinto
dall'interesse a conoscere direttamente opinioni, usanze e abitudini della
gente. Si imbatte, infine, in qualcosa che non poteva non turbare profondamente la fine sensibilita', la grande umanita' che si evince da ogni scritto di Giovanni Stella. Gli accade di vedere che un bambino investito da un'automobile, in pochi minuti arrivano un'auto della polizia e un'autoambulanza, ma poi tutto si blocca per almeno venti minuti, perche' polizia e personale sanitario si mettono a esaminare e riempire moduli e stampati, prima che l'autoambulanza muova verso l'ospedale, con molte probabilita' che tale ritardo comprometta la salute del piccolo. E mentre l'autoambulanza, finalmente, si muove verso l'ospedale, Stella si lascia andare all'amara considerazione: Quanto tempo sprecato!, penso rabbioso. e' possibile che negli Usa le carte siano piu' importanti delle emergenze?
All'occhio attento e alla nobilta' d'animo di Stella non poteva sfuggire questa discrasia della democrazia statunitense, ne' potevano sfuggirgli quelle altre, anche piu' gravi,
di cui ci parla in (6. Manhattan), dove, dopo aver esaltato la grandiosita' Usa, la faccia piu' appariscente e scintillante della medaglia, guarda attentamente l'altra faccia, quella di cui meno si parla, di una societa' dominata dall'individualismo esasperato,dall'egoismo gretto, dall'indifferenza disumana, da una poverta' impensabile.
A Manhattan abitano i miliardari, che si
combattono a suon di dollari, e il barbone che all'angolo della via chiede un
dollaro, per acquistare un ...che gli domi i crampi allo stomaco, e pur di avere quel dollaro e' disposto a farsi fotografare in vostra compagnia.
Il lusso piu' sfarzoso vive e convive con la miseria piu' deprimente, che aumenta via via che ci si allontana dal centro verso quartieri che di poverta' sono pieni.
Ci sono i gioiellieri e le firme piu' famose che propongono oggetti il cui costo fa venire le vertigini, e anche botteghe piccolissime gestite in economia da cinesi e da gente di colore, che stentano a sbarcare il lunario.
Manhattan e' il lusso, la grandeur,
l'assoluto in termini di bellezza architettonica e urbanistica, cui corrisponde l'adeguato prezzo. Ma e'
anche la contraddizione piu' eclatante, dove l'uomo, inquilino del pianeta, e'
costretto a vivere: l'uno nell'oro e nella ricchezza a lui ignota nella entita', l'altro che non ha ricovero la notte e di giorno lesina l'elemosina per un sandwich o una frutta, che gli consentano di sopravvivere.
Ho voluto riportare per intero questa poco piu' di mezza pagina perche' a me sembra che non vi sia da togliere neanche una parola in analisi impietosa della societa' statunitense, cosi' interessante e fondamentale per comprendere questa societa' cosiddetta opulenta, nella quale, ci fa vedere Stella, l'opulenza e' in realta' privilegio di pochi, non di tutti ne' di molti, come con grande superficialita' si e' portati a credere a proposito degli Usa.
Queste amare e illuminanti considerazioni di Stella, personalmente, mi fanno ricordare una analoga considerazione che De Maistre faceva in Viaggio intorno alla mia stanza: <i>Un mucchio di disgraziati, distesi seminudi sotto i portici di quei sontuosi appartamenti, sembra stiano morendo di freddo e di miseria. - Che spettacolo! Vorrei che questa pagina fosse
nota al mondo intero;vorrei che si sapesse che, in questa citta', dove tutto
respira l'opulenza, durante le notti fredde dell'inverno, una folla d'infelici,
dorme all'addiaccio, con la testa appoggiata su un paracarro o sulla soglia
d'un palazzo.
Cosi' scriveva De Maistre: si era a Torino nei primi dell'Ottocento.
E immagino cosa penserebbe se dovesse tornare in vita oggi e dovesse leggere le pagine di Stella, che fotografano la non felice realta' del paese che viene decantato come la piu'grande democrazia del mondo, e scoprire che cio' che tanto lo aveva allora sdegnato, continua a essere di piena attualita', e in tutto il mondo, ben due secoli dopo. Non si farebbe, immagino, un concetto molto lusinghiero del nostro tempo e della nostra civilta'.
Tornando all'opera di Stella, a questi Appunti di viaggio a New York, seguono ancora altri scritti di vario argomento: il racconto Leo e la corsa, e in Quel giorno a Capotaormina, di vicende personali, quali quelle relative a un suo recente periodo angustiato da seri problemi di salute, che e' assieme un omaggio riconoscente e affettuoso all'illustre chirurgo che lo ha avuto in cura; un interessante
arguto ritratto, in Giulio Andreotti</i>,<i> del noto personaggio, del quale ricorda
le indiscusse capacita', non soltanto politiche, ma anche le altrettanto certe
ma meno commendevoli perfidie politiche, che gli hanno meritato, la definizione
di ''<i>Richelieu della politica italiana''.
Un uomo, aggiunge ancora, provvisto di un ottimo senso dell'umorismo,... 'enfant prodige' della politica italiana, e che definisce frequentatore del Vaticano dove la sua cultura e il suo stile curialesco affondano le radici.
In Sciarada, dopo avere brevemente
commentato alcune riflessioni di Gesualdo Bufalino e riflettuto, a sua volta, sulla vita e sulla morte, conclude con un'espressione che riafferma il suo convinto razionalismo: In quello stesso stato di assenza e buio ritengo si ritorni con la morte, evento che conclude e chiude la parabola della vita.
Interessanti le note su ''Sovente all'anima'' di Sebastiano Burgaretta, opera della quale i presentatori e la critica hanno concordemente stimato l'alto valore della poesia, e della quale Stella qui scrive, fra l'altro: <i>Con quest'ultima opera Burgaretta segna un salto di qualita', un'evoluzione positiva e propositiva nella
sua poetica, sia in relazione ai testi precedenti, sia con riferimento alla
lingua.</i>
Il volume dopo qualche altro ritratto di grandi personaggi e alcun</span> scritti attinenti a questioni della sua professione di dottore commercialista,
si chiude con due liriche, una delle quali, A mia madre, e' un affranto diario di amore e dolore per la cara madre
inferma. Il poeta condivide nei versi le sofferenze di lei, che le legge sul volto, negli occhi: ...piccini,
rossi, / lucidi, smarriti come la tua memoria, / in quel corpo che immobile giace / da troppo tempo sul letto del dolore. Ricorda, poi, le cure che a
lui aveva sempre dedicato quand'era bambino, e poi ragazzo, e quando, lei avanti negli anni, ancora lo accoglieva, in qualche momento di sua difficolta' esistenziale, fra le sue braccia. E mi indicasti di
nuovo/, scrive, /la via smarrita / per poi ritirarti / nel silenzio.
E avverte tutta l'amarezza della sua impotenza, resa ancora piu' tormentosa dal non poterle ricambiare l'aiuto che sempre ne aveva avuto: Ora giaci, e nulla, ahime', / io posso fare per
te. C'e', in questoracchiuso in due versi che sono una disperazione soffocata, il senso dell'avvertita nullita' di un uomo, che ritrova, pare, il coraggio di accettare
il vivere grazie alla forza che gli discende ancora una volta, proprio da colei a cui lui non puo' dare alcun aiuto. Infatti, come se
la madre avesse compreso quel suo doloroso rincrescimento, con un gesto lo
rincuora: <i>Ma le tue labbra / spinte a baciarmi / prima di andarmene/ sono state, o madre, / il dono piu' bello.
Vive il poeta lo stesso calvario della madre e, forse, il suo e' persino piu' doloroso di quello di lei, si potrebbe pensare che ci dicano questi versi ricchi d'amore e di pathos: Ti guardo con occhi d'amore, / mi fissi con <i>occhi minuti. / Ma tra i due sguardi / c'e' l'assenza. e' quell'assenza
della madre, che, dicevo, rende probabilmente minore la sua sofferenza rispetto a quella del figlio, quell'assenza che in altro momento, il poeta riprende con un verso straordinario: la tua memoria
sempre piu' rara.
C'e' in quel rara una delicatezza, un pudore, direi,
quasi il poeta non volesse aggettivare la memoria dell'amata madre con un
termine troppo rude, irrispettoso, perche' e', quella memoria, qualcosa di
prezioso per lui e, come tale, col venire diminuendo non puo' che diventare piu' rara.
Ma non voglio togliere al lettore il piacere di scoprire da se' le intense emozioni che puo' dare la lettura di questo dialogo silenzioso, nel quale
agli sconsolati pensieri del poeta arrivano in risposta soltanto qualche
sguardo che lo accarezza, e un accenno di bacio che, tuttavia, lo rincuora,
perche' e' il dono piu' bello, che possa
ricevere da lei.
Quest'opera, ultima arrivata di Giovanni Stella, pur nella non unitarieta' dei temi e delle forme letterarie si presenta, direi, come un'opera unitaria nei contenuti che ne emergono, poggianti su una carica di forti ideali umani ed etici, nella capacita' di procurare al lettore intense emozioni che, in un crescendo quasi da grande sinfonia, raggiungono l'acme in, A
mia madre, che e' uno dei piu' belli e commoventi dialoghi senza parole tra
una madre e un figlio, che mi sia capitato di leggere.
Benito
Marziano
|
| 34) |
Salvatore Salemi  |
|
Località:
Avola |
  |
|
 Sabato, 21 Novembre 2009 01:37 IP: 94.162.130.123

Giovanni Stella
Memoria aggiunta
Libreria editrice Urso, Avola 2009, pp. 143, Euro 10,00
***
Memoria aggiunta Ë líultimo libro di Giovanni Stella, pubblicato, anchíesso come i precedenti, per i tipi della Libreria Editrice Urso di Avola, nel novembre 2009. Líopera, che raccoglie scritti gi‡ apparsi in diverse riviste tra il 2004 e il 2009, si aggiunge, come il titolo vuole suggerire, al volume Una vita, un corposo libro, questíultimo, di oltre milleduecento pagine pubblicato nel 2003, in cui Stella, avendo deciso di porre termine alla sua attivit‡ letteraria, volle riunire i suoi scritti composti tra il 1989 e quello stesso anno della pubblicazione. Da qui il titolo Una vita, a significare che quel ponderoso volume raccoglieva, e sigillava definitivamente, gli scritti di tutta una vita. Ma Stella fortunatamente, come prova questo nuovo libro, si Ë smentito, perchÈ quello di scrivere Ë un ìvizioî che difficilmente si abbandona. ìSi scrive per scrivere ñ sosteneva Stella in una delle sue opere, Il rigattiere e lí avventore, inserita nel macrotesto Una vita ñ, cosÏ come si vive per vivere. Scrivere come vivere, dunqueÖî. E allora diciamo che Stella, finchÈ avr‡ vita, continuer‡ di sicuro a scrivere, smentendosi ancora. CosÏ il nuovo volume, Memoria aggiunta, che ha tutte le caratteristiche di uníappendice al macrotesto Una vita (infatti, ha in comune con questo, nonostante la notevole diversit‡ dello spessore, lo stesso tipo di carta, uníanaloga copertina, le medesime dimensioni dei fogli e i caratteri tipografici identici ), potrebbe essere líappendice n? 1 a Una vita, cui seguiranno le appendici n? 2, n? 3 Ö, ovvero Memoria aggiunta n? 2, Memoria aggiunta n? 3Ö
Memoria aggiunta Ë un libro molto vario sotto il profilo degli argomenti trattati: annovera, infatti, ìricordi di personaggi degni e valorosiî (G. B·rberi Squarotti ) e recensioni di libri letti da Stella con particolare passione; ìappuntiî (racconti, descrizioni, impressioni e curiosit‡) di un viaggio a New York e riflessioni su problematiche di carattere esistenziale (vita e morte, amore); scritti polemici su questioni riguardanti la professione di dottore commercialista e poesie, tra le quali si distinguono quelle dedicate alla madre ammalata.
Numerosi sono gli scritti dedicati ai ìpersonaggi degni e valorosiî: pregevoli ìquadrettiî delineati con raffinata perizia artistica, ossia profili di uomini, morti o tuttíora in vita, stimati e noti per le loro virt? in tutto il mondo o in Italia o in terra di Sicilia. Ecco, allora, il ricordo commosso di Fabrizio De AndrË, colui che <<conosceva bene il valore delle cose e poetÚ provocatoriamente ìÖdai diamanti non nasce niente / dal letame nascono i fiorî il ricordo di Gandhi, ìrivoluzionarioî, ma che fu tuttavia líideatore della non violenza,î infatti ìera persuaso che la paura porta alla violenzaÖ e dunque si puÚ sconfiggere la violenza attraverso líeliminazione della paura,îe fu lui, ancora, a predire ìche líAsia avrebbe potuto conquistare líOccidente, che a sua volta ne sarebbe rimasto grato. E lo disse allora, quando dirlo, o solo pensarlo, era non solo utopia ma folliaî. Ecco, poi, lo scritto su Giulio Andreotti, colui che ìnon sempre dice ciÚ che pensa, seppur pensa bene ciÚ che deve dire, lasciando agli altri di interpretare quel che veramente intende direî; e ancora quello su Barack Obama, la cui elezione a Presidente degli USA Ë ìlíevento pi? importante del terzo Millennio, líatto di civilt‡ pi? eclatante e significativo realizzato dopo lunga macerazione, con democratica espressione del popolo americanoî. Ancor pi? commossi si presentano gli scritti di memoria dedicati ad alcuni siciliani ìdegni e valorosiî ormai scomparsi, e ciÚ a motivo di un sincero rapporto di amicizia che Stella ha saputo instaurare con loro: Antonio Caldarella, uno di quei ìpochi uomini che possono fregiarsi di essere vissuti nellíarte e per líarteî, il quale ìera anche e soprattutto un amico vero, di quelli che dellíamicizia fanno una sorta di religione e non tradisconoî; líaltro concittadino Paolo Montoneri, il magistrato che sapeva sempre essere ìpartecipe del processo, [Ö] pronto allíoccorrenza a ridare equilibrio alla discussione, supplendo allíeventuale grave carenza della parte debolmente difesa, perchÈ nel processo avesse ragione non chi meglio era assistito professionalmente, ma chi meritava [Ö] di ottenere giustiziaî; Piero Fillioley, per la cui dipartita ìlíavvocatura perde una delle sue toghe pi? illustri, [Ö] la Sicilia uno dei figli pi? ingegnosi, la letteratura una delle penne pi? apprezzate, la societ‡ civile una voce levata a difesa degli indifesiî, perchÈ egli ìportava impresse tre doti innate: líavvocatura, la letteratura, la lotta contro líingiustizia socialeî; Nino Zangara, maestro, per Stella, di professione e di vita, il quale ìin questa terra della quale ci innamorammo col primo vagito e che non finiremo mai díamare, si Ë prodigato con tutte le energie per dare il suo contributo in termini professionali, umani, culturali. Soprattutto per il rispetto della legalit‡ cui fu informata la sua vita, perchÈ la Sicilia non fosse considerata líultima regione díEuropa, ma viceversa la prima, come vuole anche líAtlante se osserviamo il vecchio continente dal basso verso líaltoî.
Una sottile vena malinconica Ë come sottesa a questi quattro scritti; essa nasce, a mio parere, dalla coscienza di quanto grande sia stata, per la propria terra, la perdita per la scomparsa di uomini di elevate virt?: una perdita, aggiungo, che appare ancor pi? grave in uníet‡ di crisi dei valori e di uomini capaci di incarnarli.
Tra gli scritti sugli ìuomini degni e valorosiî vanno annoverati i due dedicati al prof. Ermanno Leo, ìil numero uno in Italia nel settore della chirurgia del colonî: in essi la gratitudine nei riguardi del grande chirurgo, che ha sottoposto Stella ad un delicato intervento, ridandogli la vita, si intreccia con il desiderio di esaltarne la grande maestria ñ egli infatti ìmaneggia il bisturi come Von Karajan maneggiava la bacchetta di direttore díorchestraî ñ e al contempo le qualit‡ di uomo ìsemplice, umile, sensibile, di cordiale umanit‡ come tutti i grandi uominiî.
Sparsi qua e l‡ nel libro senza un ordine ben preciso ñ ma avrebbero potuto avere una collocazione tale da costituire uníunica compatta sezione a sÈ stante ñ si presentano poi gli scritti che vogliono essere il resoconto di personali ìlettureî, in altre parole agili recensioni di libri vari: il libro di racconti La gatta di San Basilio di Nanni Di Giacomo, Spingendo la notte pi? in l‡ di Mario Calabresi, Il codice del potere di Franco Stefanoni, il romanzo di Benito Marziano Juliette cara, nonchÈ i libri di poesie Detto fra noi del compianto Antonio Caldarella, Sovente allíanima di Sebastiano Burgaretta, » sera di Annina Rizza, e Trionfo del tempo e del disinganno del gi‡ citato Nanni Di Giacomo.
» in relazione agli ultimi cinque testi citati, opere specificamente di letteratura, che Stella rivela il suo estro critico, e una spiccata finezza estetica nonchÈ una facilit‡ nellíintendere ed interpretare il testo letterario, in particolare quello poetico.
Il discorso, lungi dal risultare pesante e accademico, procede chiaro e accessibile, riportando delle diverse opere i passi pi? significativi che, sapientemente e con sperimentata perizia scelti da Stella, riescono a fornire al lettore líessenza del messaggio contenuto in quelle opere. Líaccenno a problematiche interessanti, come quelle riguardanti il ruolo del poeta o il senso della poesia, e riferimenti inediti alla vita di alcuni autori personalmente conosciuti da Stella, rendono ancor pi? mosso, vivace e articolato il discorso, cosÏ che il lettore si sente invogliato a leggere integralmente il volume di volta in volta presentato.
Tuttavia le pagine pi? belle del libro, le pi? personali e le pi? originali, sono quelle che si riferiscono ad un recente viaggio dellíautore a New York, gli ìAppunti di viaggio a New Yorkî, e quelle che accolgono otto commosse liriche dedicate alla madre.
Riguardo alla cosiddetta ìsezione americanaî il critico B·rberi Squarotti ha espresso un giudizio lusinghiero: ìÖ Ë davvero mirabile, alterna comíË di racconti e di descrizione, di curiosit‡ e di avventura, di stupore e di visioneî. Si tratta invero di sei scritti composti da Stella di getto, uno ogni sera, per documentare un suo breve soggiorno a New York, narrando intorno alle sue visite quotidiane ad alcuni tra i luoghi pi? significativi dellíimmensa metropoli statunitense, registrando personali impressioni, sensazioni, riflessioni. E riportando persino interessanti curiosit‡, come quella relativa alla gabbia di legno esposta al Museum of Modern Art, una cella, in cui Sam Hsieh si fece rinchiudere e trascorse, tra il 1978 e il 1979, un intero anno, facendosi scattare una foto al giorno ìper suggellare la metamorfosi lenta ma progressiva del voltoî: metafora della condizione dellíuomo moderno che ìa furia di velocizzare Ö il ritmo della propria vita, altro non ha fatto che realizzare una gabbia allíinterno della quale si Ë collocato, buttando via la chiaveî.
E che dire poi, a proposito di un altro scritto della sezione americana, della grande umanit‡ che Stella scopre tra le bancarelle e le pizzerie di Harlem? In mezzo a tanta gente di colore, egli solo uomo bianco, non ha motivo di sentirsi un intruso, poichÈ nessuno lo mette a disagio. CosÏ la visita di Harlem diventa uníoccasione per calarsi nellíanima di un popolo attraverso ìun bagno umano di dialogoî e per sfatare un luogo comune foriero di chiss‡ quali rischi: ìMai soli ad Harlemî.
Non voglio riportare altri dettagli, per non togliere al lettore il piacere di scoprirli da sÈ, ma qui mi preme sottolineare il valore della sezione americana del libro, che costituisce un piccolo capolavoro. I sei componimenti sono strettamente collegati tra di loro per il fatto di riferirsi ad una stessa esperienza, eppure ciascuno di essi ha una sua individualit‡ e autonomia, costituisce un grazioso ìquadrettoî tracciato con arte Ë in sÈ concluso: piccolo spaccato del mondo newyorkese filtrato attraverso gli occhi e líanimo di un visitatore attento, curioso e colto.
Per quanto riguarda, infine, le poesie dedicate alla madre, sono convinto che non ci sar‡ persona che non possa commuoversi nel leggerle, cosÏ autenticamente sentite si presentano; Ë significativo, in tal senso, il giudizio espresso dal critico Giorgio B·rberi Squarotti: ìÖ sono profondamente commosse e, al tempo stesso, pudicamente dolci e luminose, pur nel dolore che dura. » un bel dono díamore e di fedelt‡ del cuoreî. Ed anche, aggiungerei, di autentica piet‡ filiale verso una madre che, ormai vecchia e sempre pi? di raramente in grado di attingere un barlume di coscienza, va lentamente spegnendosi, relegata in un letto ìdi dolore, di sofferenza, di ricordiî.
» questa visione pietosa che sta fondamentalmente alla base dellíispirazione delle otto liriche, insieme ad un intimo turbamento che deriva dal contrasto tra il presente doloroso, vigilia della fine dellíesistenza della cara madre, e il passato luminoso di lei: quando, ancora ragazza, era ìfra le pi? belle / e ammirate in Avolaî, e poi, da madre, fu ìuna montagna / nella forza e nel rigore moraleî che seppe trasmettere ai figli. » significativo che queste liriche, cosÏ grondanti di dolore e di commozione, siano precedute da un lungo componimento, quasi una sorta di lauda, ìIl venerdÏ di Ges? Nazarenoî, in cui Stella con autentica sentita partecipazione ripercorre le fasi salienti della passione di Cristo-Uomo: forse a voler significare come la sofferenza renda la madre, e cosÏ ogni uomo che soffre, simile a Ges? di Nazaret.
» questo il punto pi? elevato cui pervenga líesperienza umana di Stella quale Ë espressa nelle pagine di Memoria aggiunta, che Ë opera di profonda e sentita umanit‡ nella sua interezza. Al centro del libro, infatti, sta líuomo, e Stella si pone come ìesploratoreî dellíanimo umano, nella misura in cui sa rivelarci, nelle pagine di poesia, il proprio personale mondo di affetti; riesce a fare emergere, negli scritti di recensione, pensieri, idee e sentimenti contenuti nei libri che sono stati oggetto di sue attente letture; sa mettere in risalto, nelle pagine dedicate a personaggi ìdegni e valorosiî e ad alcuni grandi uomini della storia, le loro nobili virt? e il loro impegno per un mondo pi? giusto; sa cogliere in un viaggio da turista allíestero, a New York, ogni opportunit‡ per ampliare la sua esperienza di conoscenza dellíanimo umano e delle diverse societ‡ umane.
In una sua opera precedente, Il rigattiere e líavventore, Stella si chiedeva, nello scritto díapertura, per quale motivo si scrive, e ricordando le risposte che nei secoli hanno dato alcuni scrittori, citava anche quella di Thomas Mann: si scrive ìper lavarsi il cuoreî. E veramente Stella ìsi Ë lavato il cuoreî anche con questo nuovo libro, rivelando attraverso tanti personaggi gli aspetti pi? nobili dellíanimo umano. Per tale motivo Memoria aggiunta costituir‡ ñ ne sono convinto ñ uníoccasione ìper lavarsi il cuoreî anche per il lettore, che non potr‡ non sentirsi migliorato dalla lettura di scritti che, in fin dei conti, invogliano ad avere fiducia nellíuomo e a coltivare quei valori e quegli ideali che fanno progredire líumanit‡: scritti, quindi, che fanno tanto bene al cuore e allíanima.
Salvatore Salemi
|
| 33) |
Benito Marziano  |
|
Località:
Noto |
  |
|
 Mercoledì, 4 Novembre 2009 23:47 Host: 93-46-2-63.ip105.fastwebnet.it

Paola Liotta
Del vento, e di dolci parole leggere...
2009, cm 16 x
Collana OPERA PRIMA n. 16
EAN 978-88-96071-13-7
Del vento, e di dolci parole leggere, di Paola Liotta
(intervento di Benito Marziano alla presentazione del libro di Paola Liotta Libr'Avola (24 ottobre 2009)
Credo che tutti conosciamo quella sorta di gioco nel quale viene chiesto ai vari interlocutori di elencare i dieci libri che, in caso di catastrofe, si vorrebbero salvare, o avere con sÈ nel caso si dovesse finire su un'isola deserta; scelta veramente ardua a mio parere, che, personalmente, difficilmente riuscirei a operare, ritenendo degni di essere salvati molti, ma molti pi? di dieci libri. Mi Ë tornato alla mente, questo gioco, quando ho terminato la lettura delle poesie di questa silloge, opera prima di Paola Liotta, pensando che, se mi si fosse chiesto di operare una scelta simile e salvare le dieci migliori di queste poesie, mi sarei ritrovato in analoga difficolt‡, e avrei finito col tentare di salvarle tutte, perchÈ tutte le ritengo meritevoli di non andare perdute.
Le ho lette pi? volte, e ogni volta mi Ë capitato di scoprire ora un verso, ora un'espressione, ora una sonorit‡, ora un concetto, un qualcosa, insomma, che, precedentemente, magari, mi erano sfuggiti o non avevo sufficientemente apprezzato o non ne avevo avvertito, a volte, il senso pi? recondito; e ne traevo, ogni volta, nuove sensazioni, immagini, emozioni che ingeneravano ulteriori pensieri, nuove riflessioni.
E, a un tempo, veniva rinsaldata una mia antica convinzione, quella che i poeti, da quegli egocentrici che sono, parlano sempre e soltanto di se stessi e della loro vita. Ma (ed Ë questo che fa arte, che fa poesia), parlando di se stessi e della loro vita, parlano della vita di tutti.
E, forse, Ë per questo che piace la poesia, perchÈ credendo di leggere della vita dei poeti, di venire a conoscenza della loro vita, conosciamo un po' della nostra vita, e, in definitiva, di noi stessi.
La poesia nasce, ritengo, sempre come manifestazione intimistica, e ce lo ricorda anche Paola Liotta, quando scrive nel risvolto di copertina di questa sua opera, che considera ''la poesia come un angolo ëtutto personale' cioË strettamente privato, e privilegiato, da cui meditare sul proprio vissuto''.
E ciÚ Ë certamente vero, ma quando i sentimenti, i tormenti, le gioie e le angustie, le ansie e le delusioni, gli affetti e gli amori, in una parola: il ''vissuto'', come lo definisce Paola, viene esternato ed espresso in forme tali da elevarsi ai livelli dell'arte, smette di essere il vissuto del poeta e diviene il vissuto di ogni essere umano, il vissuto di tutti.
Questa universalizzazione del vissuto Ë ciÚ che opera il poeta, e avviene in poesia, forse, pi? che in qualsiasi altra arte. E accade, per il tramite di versi pregevoli, nel caso della poesia di Paola Liotta.
Volendo, ora, entrare nello specifico della silloge, pur senza voler affrontare una particolareggiata analisi delle singole liriche, ritengo necessario anticipare che non mi Ë stato facile scriverne, di queste poesie, e la prima difficolt‡ mi derivava dal dover racchiudere in quello che ritenevo dover essere un breve intervento (e sar‡ breve), il tanto che si potrebbe e ci sarebbe da dire. PerchÈ in esse viene indagato dalla poetessa ora uno, ora un altro aspetto, o sfaccettatura, se si vuole, dell'animo umano, con una profonda analisi introspettiva, puntando l'obiettivo sulla propria interiorit‡, scandagliandola sin nei pi? profondi recessi, mettendo in luce sia i lati, gli aspetti dell'animo umano pi? ostensibili, diciamo, giusto per intenderci, sia quelli che solitamente tendiamo a celare, a volte, persino a noi stessi.
Senza, quindi, per niente dilungarmi, cercherÚ di fare un po' una veloce carrellata, senza soffermarmi in un esame approfondito e accurato di tutti i temi e i contenuti delle liriche, ma, sempre per brevi tratti, cercherÚ di dare un'idea di quello che a me pare di trovare nella poesia della Nostra, secondo una mia personale lettura, che non so se interpreter‡ poco o molto quanto lei ha inteso comunicarci con i suoi versi. CiÚ, anche, tenendo conto di una difficolt‡ di lettura, intrinseca ai versi, almeno relativamente a quelli nei quali appare una, forse, ricercata intenzione di ëcriptarne' il senso, come persistesse in lei un indugio a voler svelare del tutto il suo personale ''vissuto''. Versi che, fra l'altro, ritengo si possano ascrivere alla migliore poesia dell'Ermetismo.
Credo, anche, che chi conosce questa nostra amica non puÚ non giudicarla persona di squisita gentilezza, di notevole cortesia, di carattere affabile pur se riservato, attributi che smentiscono quel comune modo di dire che vorrebbe che il carattere fosse lo specchio dell'anima. PerchÈ queste sue personali caratteristiche non ne rispecchiano per niente l'animo, che alberga, sÏ, a volte, sentimenti sereni e magari gioiosi, ma pi? spesso Ë abitato da malessere esistenziale, da tormenti, da incertezze, da dubbi, da amare considerazioni sulla natura umana, da profonde delusioni originate dall'aver accordato fiducia e stima a chi non le avrebbe meritate.
A voler seguire, invece, le suggestioni che ispira il titolo dell'intera silloge, che Ë poi il verso di una lirica in essa compresa, come ci viene ricordato nel risvolto di copertina, si rimane un po' sviati, chÈ di qualcosa di incorporeo come il vento e di levit‡ di dolci parole, in realt‡, c'Ë ben poco, in queste poesie, gi‡ sin da quella dalla quale il verso Ë tratto, e dove leggiamo: La mia pace tutt'ora s'intriga / di niente, del vento, e di dolci parole / leggere comprendi?-, ed Ë la pace / di chi si esalta al refrigerio beato / di quattro conoscenze sentite, poche / e tirate come litanie d'autunno- / le dispieghi per le lunghe, se desideri / patire...
(Dolcemente).
Questi versi ci danno gi‡ un saggio della complessa concezione della vita che emerge dalla poesia della Nostra, di quanto sia pensoso e agitato quel suo ''vissuto'', del quale, pur con indugi e incertezze, cosÏ ci lascia intuire, ha voluto, tuttavia, metterci a parte. Superando una riservatezza che, personalmente, spero superi ancora e presto per darci la possibilit‡ di leggere quella produzione che certamente continua ancora a nasconderci, almeno cosÏ pare a leggere il risvolto di copertina, ove ancora scrive di ''una pausa poetica di quindici anni''. Deve tenere, quindi, in serbo una produzione precedente questi quindici anni.
Questa Dolcemente, che suona come un ossimoro voluto, tra titolo e contenuto, ci riporta subito sui giusti binari, se, cadendo in quella suggestione del ''vento e delle dolci parole leggere'', ci fossimo attese poesie che ci dicessero di vita amena, felice, idillica; di contenuti, insomma, che avessero l'immaterialit‡ del vento e la leggerezza di parole dolci, magari affettate e leziose; poesia di manieristica superficialit‡, per intenderci; ciÚ che non Ë affatto vero, neanche quando i versi sono ispirati dai sentimenti pi? teneri e dolci e dagli affetti pi? cari, come nel caso delle liriche dedicate al padre e alla madre; lo Ë ancor meno, quando indaga i problemi, i tormenti che agitano il suo animo, che poi sono i problemi e i tormenti che agitano tutti, uomini e donne, tranne, forse, alcuni animi ingenui, chiamiamoli cosÏ.
Ma, gi‡ sostenevo, il lettore non legge nelle poesie di Paola le vicende della sua personale vita (vale ciÚ per qualsiasi poeta leggiamo), perchÈ quelle sue vicende sono il paradigma della vita di ciascuno di noi, chÈ nella vita di tutti ci sono giorni, eventi fausti e ce ne sono tanti di infausti; la vita Ë fatta di gioie ma anche di dispiaceri; di serenit‡ e di ansie; di speranze, pi? o meno grandi, e di altrettanto pi? o meno grandi spiacevoli realt‡; di illusioni (e utopie, anche) e di delusioni.
E nella poesia di Paola ci sono tutti questi ingredienti, lasciatemi passare la parola. La silloge, anche se le liriche sono tutte scritte ''in alcuni mesi dello scorso anno'', ci precisa lei stessa, racchiude un po' l'intero percorso, ancora tutt'altro che lungo, della sua vita, con un procedimento cronologico, scandito da alcuni titoli che vanno segnando le tappe della crescita fisica, ma soprattutto della parallela evoluzione psicologica e della maturazione intellettuale.
Questi i titoli e le liriche che hanno riferimenti temporali: Prima, che apre la raccolta: qui la poetessa si abbandona alla dolcezza dei ricordi d'infanzia e del padre, resiste / ancora in me un'eco / di ricordi singolari / d'infanzia legati ad arte / nello scrigno del tempo /... depredati di Te..., scrive; ricordi che in Ora e prima, tornano ancora a un tempo lontano, ma l'et‡ Ë quella che segue l'infanzia, quando ci accompagnano i sogni: Fitte diaspore / di insetti, /sulla costa, su, / per l'erta di Avola / Antica: guizzanti / nell'anima in fiore,/ e un po' oltre: ... le schiere / dei miei sogni / miti e di quelli / estivi pi? agguerriti, /e accanto ai sogni la gioia di vivere: dei sospiri / emessi, di quanto /risi. In Presente, la troviamo in piena et‡ giovanile, quando l'amore si affaccia nella sua vita, come in quella di tutti, con le apparenze di una meravigliosa favola che ci entusiasma, ci esalta, ci disarma, ci appaga, ci avvince, ci possiede quasi interamente: l'amore di chi amo / la gioia di abbracciarti / e di amare in quel che sono, scrive. E l'essenza della vita Ë, appunto, il ëpresente', e poco importa il futuro, e poco il passato, aggiunge con versi che comunicano, intanto, una straordinaria ebbrezza di vivere, e che desidero ricordare: Il meglio Ë unicamente /questo, l'ora in cui viviamo, / non la conquista di un domani / che sar‡, e allora? / nÈ un passato che oramai / non ci appartiene, / ...mais ouiÖ /, e chiude il verso e la lirica con i puntini di sospensione, quasi a volerci ricordare che la vita continua, comunque, come le va di continuare. Quale eco di epicureo vivere o del ''chi vuol esser lieto, sia'' di lorenziana memoria sembra giungerci da questo ''mais oui''! Ma sÏ! sembra suggerire anche a noi la poetessa, prendiamo dalla vita ciÚ che nell'attimo Ë possibile strapparle e non pensiamo ad altro.
Ma non sempre Ë bello, purtroppo, il presente, l'attimo, e quand'anche lo fosse, il passato, che lo si voglia o non lo si voglia, Ë anch'esso la nostra vita, e ci appartiene, e ci appartengono coloro che sono stati nel nostro passato; e ci appartiene pure il futuro, anche quando non ci saremo pi?, perchÈ ci saranno, in ogni caso, molti di coloro che ora ci sono accanto o accanto ci saranno stati, e del futuro di costoro non sappiamo e non possiamo disinteressarci. Non siamo monadi!
E la nostra amica lo sa, e ne d‡ atto, in alcune liriche, di quanto il passato e il futuro facciano parte del suo presente: il ritorno sovente, ad esempio, al ricordo del padre, o ai ricordi dell'infanzia. Sono il suo passato! E allora? Non vivere del passato! Come si fa?
E in Futuro prossimo, quando scrive: E il mio giorno di festa, / lo attendo,Ö non Ë l'attendere, sempre, un'attesa di futuro? Per bene o male che ci tratti la vita, non ci attendiamo un po' tutti il nostro ''giorno di festa''? O i nostri giorni di festa?
Certamente, fra i due momenti: del vivere giorno per giorno, senza attendere nient'altro dalla vita e questo puntare sul domani, qualcosa Ë dovuto intervenire a mutare il suo stato d'animo: si Ë accesa o riaccesa qualche speranza, l'attesa di qualche evento, ora, la allieta.
E sappiamo tutti che nei momenti in cui la vita ci gratifica di un po' di generosit‡, si ha la sensazione che di nient'altro ci importi, e si desidererebbe vivere quei momenti in eterno.
In questa scansione temporale, ricordata dai titoli, segue Finale. L'amore, dopo un incontro inebriante ci dice: impietrita come l'ultima volta che ti vidi,/ ebbra di vita, tra le pieghe del sole estivo; /si ridurr‡ alla debole
speranza di un altro assai incerto incontro, e, poi, smaltita l'ebbrezza, nel rendiconto del dare e avere, chi pi? aveva dato, ora, pi? soffre: dopo aver tanto dato, da oscurare / il paesaggio e i volti di chi mi Ë accanto: / tale lascito raro ebbi da te in dono, / nÈ ricambio di sentimenti schietti.
Segue Infine, che chiude la silloge. Siamo all'oggi, ormai, e alla maturit‡, perchÈ le liriche sono state composte nel 2008. Della vita e dalla vita ha appreso molto: ormai saviamente / disillusa, leggiamo, e l'enjambement, procedimento metrico che non Ë il solo, ma Ë molto usato da Paola, e che a me sembra, generalmente, di particolare efficacia, qui viene a sottolineare, pare, come una pausa di riflessione, quasi avesse voluto concedersela, affinchÈ la sua disillusione non derivasse da affrettate conclusioni, ma fosse veramente, come lei dice, ''saviamente'' ponderata. E chiude la lirica e quindi l'intera silloge, con versi che sono un inno stupendo a quella vita, che l'ha delusa e che, tuttavia, non ha inaridito i suoi sentimenti: e, come vedi, non ho /mai avuto bisogno / che d'amare''.
Tra Prima Infine Ë racchiuso l'intero arco della vita di Paola Liotta,
dall'infanzia al 2008, quel ''meditare sul proprio vissuto'', per dirla con parole sue, affrontando i temi perenni della vita: l'amore tout court, e ne abbiamo parlato, ma anche l'amore per il padre, con il quale si sentiva un tutt'uno: Fusione immaginaria / di cieli e terra, /... eravamo scrive A mio padre, al quale con versi toccanti rivolge sentimenti profondi di forte affetto e di immensa gratitudine per averle dato un amore che la accompagner‡ per sempre e costituir‡ un po' l'analgesico al dolore della sua assenza. Questi i versi che mi piace ricordare: Non Ë l'ora, questa, / di dolersi nÈ nutro / illusioni sempiterne / o un bel niente:/ ci sono, e il mio / ëper sempre' sar‡ / il tuo amore per me. Non cerca metafisici rifugi. Qui viviamo e scontiamo tutto quanto Ë possibile vivere e scontare, e qui vanno vissuti i sentimenti e gli affetti.
Ma l'affetto per il padre Ë tema anche di Prima, lirica gi‡ ricordata, dove nei ricordi d'infanzia, la figura del padre appare gi‡ un po' incerta, quasi, ...a predire d''altre' / lontananze, due versi, due emistichi, pi? propriamente, ancora un enjambement, che a me sembrano una meravigliosa e delicata metafora della morte.
Eguale intensit‡ d'affetto nutre per la madre, al cui amore ha affidato se stessa; madre e figlia vivono, nei suoi versi, in amorevole simbiosi, l'una per l'altra: che sia io, in te, / Tu, in me. Lei alla madre ha affidato la sua vita, aggiunge in versi dolci e tristi: <i>eppure il dolore / corrode la tua mite / pazienza d'una volta /e il mio tempo / scivola ora / fra le tue mani / vigili d'amore / lievemente,/. E sono un'unica persona nell'affrontare il ... greve passo / per l''ignoto' / che Ë la Vita...? scrive in Madre.
Non desidero aggiungere altro, per non abusare ancora della vostra pazienza, pur ritenendo che parlare delle poesie di Paola Liotta non credo possa spazientire l'ascoltatore, tranne che ad annoiare non fosse chi ne parla, e non vorrei essere io questo caso. Soltanto poche parole ancora, riguardo a un altro aspetto della visione della vita che emerge dalla poesia di Paola: Ë una vita che in gran parte si sostanzia di affetti, di elevati sentimenti, di apertura dell'animo all'altro, di fiducia nell'uomo e si scontra, invece, con la vanit‡, la futilit‡, la finzione, la delusione.
E stupisce, gi‡ dicevo, un'interiorit‡ tanto dibattuta e tormentata pi? consona, a mio giudizio, a un'et‡ pi? avanzata e a una pi? vissuta vita.
Ma la maturit‡ non sempre procede di pari passo con l'et‡ cronologica.
Un'ultima cosa desidero dire, leggo ancora dal risvolto di copertina, di penna della Nostra: ''tali versi sono sgorgati con semplicit‡, nella temporanea auscultazione di quanto, delle sue (di sÈ, intende), energie spirituali e affettive, si era sedimentato,...''. Ebbene, leggendo queste parole mi tornava il ricordo di quanto Sartre, nella ''Nausea'', mette in bocca ad Antoine Roquentin, protagonista di quel romanzo: ''Bisogna scrivere tutto come viene alla penna, senza cercare le parole''. Io credo che questo valga molto per la vera poesia, e apprezzo moltissimo la poesia di Paola, anche perchÈ i suoi versi a me danno l'impressione che scaturiscano da una grande spontaneit‡, come se le ëparole' fluissero dal pensiero alla penna; e, tuttavia, appaiono, come gemme in un castone, tutte perfettamente al loro posto, quindi come fossero ëcercate', e i versi lungamente meditati. Specificit‡, ritengo, anche queste della buona autentica poesia.
Benito Marziano
alla presentazione del libro di Paola Liotta (24 ottobre 2009)
|
| 32) |
Sauro |
| sauro.aurus@tiscali.it |
Località:
Milano |
  |
|
Rocco BRUNO, The matrix", una parabola moderna
Si tratta di un libro che parla della condizione umana prendendo come spunto dalla popolare trilogia dei fratelli Wachowsky di "the matrix".
Il libro propone ed affronta la condizione umana partendo da un punto di vista esoterico, dove le cause di tutte le cose dipendono da questioni intime e profonde nell'individuo e non dalle circostanze fuori di lui. La nostra ricchezza o la nostra miseria sono cose intime e non materiali.
I tre film sono leggibili a vari livelli, socio-politico, quale denuncia di un "sistema" che tende sempre pi? ad appiattire e normalizzare l'individuo, soffocando deliberatamente gli impulsi creativi e spirituale-esoterico come rivelazione di un destino umano vincolato alla dimensione pi? densa della terra.
Il rimedio in entrambi i casi che propone l'autore Ë il risveglio della dimensione cristica in ciascuna persona.
Rocco Bruno cita tutta una serie di esercizi psicofisici volti a rompere il circolo degli automatismi, esercizi che nel libro ''Essere Reale'', essere reali, prendono ulteriore forma e sviluppo.
Importante Ë soprattutto lo sguardo chiaro su se stessi e sulla vita che solo puÚ condurre "nel mondo reale" come promette Morpheus a Neo.
Che altro?! L'editore, lo stampatore ed il rilegatore Ë l'autore stesso, fa tutto da sÈ, in casa e questo ha motivato ulteriormente diverse individui a cercare e leggere i questi testi.
Ah! Dimenticavo, i libri non sono distribuiti in libreria, fatto salvo che a Milano presso la "libreria esoterica", le altre non distribuiscono libri fuori dal consueto circuito.
Si possono ordinare e le info sono su http://www.thematrixrw.webs.com/
esiste un Blog - http://matrixunaparabolamoderna.blogspot.com/
|
| 31) |
Giovanni Stella  |
|
Località:
- |
  |
|
 Martedì, 9 Giugno 2009 17:20 Host: 93-46-44-14.ip106.fastwebnet.it

Sovente all'anima
ìSimile a un colombo viaggiatore /il poeta porta sotto líala/ un messaggio che ignoraî. CosÏ Gesualdo Bufalino in uno dei suoi splendidi aforismi.
Me ne sono ricordato ieri sera, quando Sebastiano Burgaretta, prendendo la parola per un breve ringraziamento, emozionato, ha detto di scoprirsi vieppi? ignoto a se stesso, dopo aver ascoltato Giuseppe Traina, docente di italianistica presso líUniversit‡ di Catania, dipartimento di Ragusa, mons. Giuseppe Greco, vicario generale dellíArcidiocesi di Siracusa e Paolo Giansiracusa, storico dellíarte, docente presso líAccademia di Belle Arti di Catania.
Era il 15 aprile 2009 e nel ìGlobeî, ad Avola, si Ë tenuto un Convegno, meglio chiamarlo Simposio, perchÈ in effetti tal Ë stato, sul libro di poesie Sovente allíanima, di Sebastiano Burgaretta, edito dal Girasole, Valleverde (Ct) 2008, pp. 77, Euro 15, in bella veste grafica con carta uso mano antica.
Le relazioni sono state intervallate e allietate da pezzi musicali, suonati al flauto, e dalla lettura di poesie scelte dal volume, a cura di Mirella Parisini, Erminia Gallo e Donata MunafÚ.
Líedizione si avvale di una ricca prefazione (che merita uno scritto a sÈ), del poeta e filologo spagnolo Juan Miguel Domίnguez Prieto, con testo a fronte tradotto dallíispanista Rosa Rossi. » inoltre arricchita da bei disegni di Corrado Frateantonio, presente anchíegli al tavolo dei relatori, in una sala gremita di pubblico interessato e attento a un argomento oggi non certo di moda, ma sostanzialmente rimasto per addetti ai lavori, che, con vigore e passione, portano avanti il vessillo di questíarte nobile o, se vogliamo, di questo ìprodotto assolutamente inutile quasi mai nocivoî (cosÏ Montale a Stoccolma il 14 dicembre 1975, allíatto di ricevere il premio Nobel per la letteratura dalle mani del re Gustavo di Svezia). E in una Societ‡ in cui tutto Ë nocivo Ö
Anche líarte della poesia fa parte del mistero. I versi appartengono al poeta finchÈ questi li ha dentro di sÈ, come il magma in un vulcano, ma, una volta spifferati fuori, sono lapilli (o lava incandescente) che restano a macerare in cassetto fra i tanti, finchÈ le fiamme della purgazione non li divorano. Se perÚ líautore cede alla tentazione di pubblicarli, non sono pi? suoi ma di tout le monde, dei lettori che li leggeranno, apprezzandoli o stroncandoli secondo un proprio convincimento, una personale valutazione, talora, anzi molto spesso, lontana dai motivi di ispirazione del poeta; di quel poeta che Pessoa definÏ ìÖun finitore, /(e) finge cosÏ completamente/ che arriva a fingere che Ë dolore/ il dolore che davvero senteî.
La poesia Ë travaglio interiore non dissimile dal parto della donna, dunque prima dolore, dipoi gioia per la nuova creatura, che magari líautore stesso stenta a credere essere frutto del proprio ingegno.
Pertanto, anche se in forte crisi di lettori, líarte della poesia ñ come ben avvertÏ Quasimodo, cantandone la perenne attualit‡ ñ non potr‡ che esistere, finchÈ esister‡ líuomo, se Ë pur vero quanto Addamo scrisse: ìSar‡ solo un poeta /a dichiarare estinta líera dei poetiî.
Tre sezioni, come una triade divina, compongono líopera poetica ultima nata di Sebastiano Burgaretta: Colori, Parole e Sovente allíanima, questíultima anche titolo del volume.
Líautore non Ë nuovo alla poesia, tuttíaltro. Ha gi‡ pubblicato in versi: Diario del Golfo (1992), Líala del tempo (1995), Epigr‡ffi (1998) con lo pseudonimo di Vanesio Mercuriale, Mpizzu ri fuddÏa (1999), An‡stasis (2000), Trame del Mediterraneo (2003), Le ol‡m (2004), RrËpitu per due dicembre (2008). Lavori tutti ricchi e densi di interesse, dove si nota un impegno civile e di memoria di un passato talora ancora vivo e presente.
Con questíultima opera Burgaretta segna un salto di qualit‡, una evoluzione positiva e propositiva nella sua poetica, sia in relazione ai testi precedenti, sia con riferimento alla lingua. Accantonato líimpegno civile, cíË ora la ricerca, riuscita, di un linguaggio nuovo, di una creativit‡ della parola, che Ë anche ricerca, questa pure riuscita, di un nuovo stile. E, per arrivare a ciÚ, si Ë avvalso di molti riferimenti alle lingue Greca, Spagnola e Araba, che sono poi le lingue parlate dalle popolazioni che hanno dominato la Sicilia. Lavoro, questo, che non puÚ non far auspicare ora anche il ritorno del Mediterraneo quale crocevia essenziale con un ruolo di centralit‡ in termini culturali e socio-economici fra líEuropa, líAfrica e il Medio Oriente.
Se il tema dominante e, come dire, musicale, della poesia di Bugaretta Ë sempre riconoscibile, in questo lavoro la musicalit‡ trova una nuova armonia e una nuova tonalit‡, entrambe ancor pi? pregnanti, che conducono a quel salto in avanti di cui dicevo prima.
La ricerca di un nuovo linguaggio inventivo, creativo, Ë circostanza che in passato abbiano gi‡ avuto modo di sperimentare con Montale, Gadda, Consolo Ö, ai quali ora si aggiunge Burgaretta.
La sua parola Ë cura dellíassoluto, tende a un dialogo col lettore, con una vocazione metafisica che volge, sottotono, a un ritorno a Dio, il quale qui parla attraverso i silenzi, la natura, la storia.
Líinfluenza dei poeti arabi antichi e moderni Ë presente, come lo Ë quella di spagnoli e persino caraibici.
Ma il richiamo pi? forte, forse, Ë quello greco con líeco della letteratura che in questa terra fa ancora parlare di una grecit‡ sicula, che interamente ci appartiene.
Líazzardo pi? bello si avverte nella composizione grafica dei versi ñ la poesia che d‡ il titolo al libro, ad esempio ñ dove la voce di poeta autentico volge al metafisico, allíintangibile, alla presenza divina ñ forse il vero tema dominante ñ che il poeta avverte costantemente e sussurra al lettore.
Addirittura, da laico, penso di poter dire che Burgaretta, uomo di grande fede religiosa, in questíopera, con líuso di un linguaggio nuovo, attraverso i colori abbia voluto operare una sorta di ricognizione degli elementi essenziali della natura, e attraverso la parola abbia intenso colloquiare coi propri simili, per giungere alfine allíanima, mezzo ultimo e diretto per un suo dialogo con Dio.
In un testo cosÏ non poteva mancare il richiamo a Dante, presente ben cinque volte, perchÈ Ë il padre della nostra lingua, ed Ë a lui che bisogna attingere, se si vuole elevare la qualit‡ del discorso.
Qui il discorso di Burgaretta, per iniziati certamente, ma anche per lettori che intendono apprezzare una qualit‡ nuova di parola poetica sforzandosi di seguirla, Ë sicuramente un punto fermo che sar‡ oggetto di numerose visite di critica e di pubblico, desiderosi di dissetarsi a quel ìSovente allíanima /distilla / il tempo / gocce / dal sapore ineffabile díamore. / Torna verde lo stupore antico. / Lontano gli occhi della mente / a incontri celebrati dentro il cuore. / Il filo díarianna mai reciso, /del labirinto persa la memoria, / allunga al cielo líombra del suo arcoî.
Giovanni Stella
Burgaretta Sebastiano, Sovente all'anima, 2008, 8?, pp. 80, Euro 15,00
http://www.libreriaeditriceurso.com/Burgaretta_Sebastiano.html†
|
| 30) |
Salvo Pignato  |
|
Località:
Avola |
  |
|
 Sabato, 23 Agosto 2008 23:28 Host: 89-97-35-72.ip15.fastwebnet.it

Un bel capolavoro si è rivelato il libro ''LA CATTEDRALE DEL MARE'' DI FALCONES, Longanesi ediz.
Basta leggere la retro copertina del libro per comprendere la sua caratura.
Il compito di questo libro secondo il mio parere Ë quello di comunicarci che delle forze Divine governano il destino degli uomini; basta lasciarsi andare, il risultato Ë che nellíarco di tre generazione il destino di un padre e di un figlio ebbero dei risvolti possibili anche se non di facile realizzazione. †Líabnegazione di un giovinetto rimasto solo a lottare per la sopravvivenza, ma che con le armi della perseveranza †dellíonesto †duro lavoro e della lealt‡ †verso líuomo riesce a realizzare un impero economico, al quale non ha mai anteposto sani principi etici e †nobile morale, accettando le angherie di chi gestiva il potere, ìParliamo come collocazione temporale del 1300 circa in Spagna, dove ancora le caste regnanti davano e toglievano il diritto supremo della vita.î
Libro che mi ha parlato dellíamore in tutte le sue †forme e credetemi sono tante e si puÚ affermare che ci sono state riportate intatte per oltre i mille anni che ci separano dai fatti avvenuti..Libro che mi ha parlato della faziositaí della chiesa che allora professava líinquisizione.
In questo libro ci si scivola piano e ci si lascia emozionare a volte con impeto, oltre con dolcezza, ma mi rendo conto che Ë difficile segnalare
tutti i †messaggi, gli usi, i costumi di un popolo che pur latino come il nostro, di cui ne abbiamo avuto la dominazione e che, nonostante tutto,
molte cose ci sono ignote.
Se vi capita di avere ancora voglia di leggere un bel libro reduci da una bella vacanza, penso che questo di cui vi ho parlato non vi deluderaí.
Salvo Pignato
|