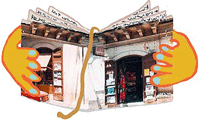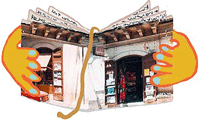| Nome |
Riflessioni con eventuali Commenti |
| 9) |
Simona Ruta  |
|
Località:
Modica (RG) |
  |
|
 Martedì, 7 Marzo 2006 04:00 Host: host57-156.pool80104.interbusiness.it

Patrick S¸skind, Il Profumo, 1992, pagine 266, Euro 7,80
ìIl Profumoî, di Suskind
Non conoscevo Suskind prima di leggere il suo bellissimo romanzo dal titolo ìIl profumoî e devo ammettere di esserne rimasta colpita sia dal punto di vista della tecnica narrativa e descrittiva adottata, sia per líoriginalit‡ della storia.
ComíË facilmente intuibile Suskind parla di fragranze.
Non di semplici odori, bensÏ di profumo come vera essenza, come ìanimaî delle cose.
Tale concetto puÚ certamente risultare ambiguo poichÈ parla di qualcosa di estremamente lontano dalla realt‡ di qualsiasi essere umano, di qualcosa di non concreto, che non si puÚ toccare con mano, di qualcosa di estremamente soggettivo.
Il romanzo parla di un uomo dotato della capacit‡, del dono, oserei dire, di captare gli odori pi? impercettibili.
Di un fiore, ad esempio, non sente ìil profumo del fioreî in sÈ, ma distingue nettamente líodore dello stelo, delle foglie e dei petali.
CosÏ succede per ogni oggetto o persona e impara in tal modo, da solo, a conoscere la realt‡ che lo circonda, perchÈ al nostro protagonista, Grenouille, nessuno spiegÚ mai nulla.
Da piccolo passava da una balia allíaltra.
Nessuno lo voleva: non lo volle la madre, non lo vollero i sacerdoti, non lo volle neppure la morte nel corso dei suoi anni, nonostante le gravi malattie che gli segnarono il corpo e le precarie condizioni in cui esso si trovava a vivere.
Non aveva ambizioni.
Viveva per arricchire la sua conoscenza del mondo degli odori e per imparare a distinguerne quanti pi? possibile.
Voleva creare un profumo straordinario, inebriante, che nessuno potesse non amare.
Voleva creare il ìsuoî profumo.
Grenouille, infatti, non emanava alcun odore. Credendo di essere, per questo, privo di una sua identit‡, decide di imparare le tecniche pi? innovative, adottate dai maestri profumieri francesi dellíepoca, per scindere le essenze dagli oggetti, comunemente fiori e piante e raggiungere cosÏ il suo scopo.
Ma egli non si limitÚ ai vegetali.
Non riconoscendo una differenza morale tra un oggetto e un essere vivente comincia a ìrubareî líodore di gattini, cagnolini e di esseri umani.
Diventa un assassino uccidendo le ragazze che riteneva ìolfattivamente interessantiî per raggiungere il suo scopo e, alla fine, vince. Crea il suo profumo che lo rende speciale, bellissimo agli occhi della gente, la stessa che avrebbe voluto vederlo morto per punire quei delitti.
Tutti lo adorano come un Dio e lui si lascia ìamareî finchÈ non lo sventrano, lo squartano per poter possedere un pezzo di quel corpo.
Il corpo di Jean Baptiste Grenouille.
Il genio di Suskind, a mio avviso, sta proprio nella capacit‡ di basare la rappresentazione di luoghi e personaggi sul fattore olfattivo.
Raramente si fa riferimento a colori, forme o a qualsiasi altro elemento ottico.
E man mano che si va avanti con la lettura non si puÚ fare a meno di ìsperimentareî, annusando, le ìessenzeî di ciÚ che ci sta intorno per concretizzare il concetto di profumo come anima delle cose trasformandosi in piccoli Grenouille.
Ruta Simona
Modica 29 dicembre 2005
|
| 8) |
Salvatore Di Pietro  |
| turidipietro@virgilio.it |
Località:
Noto (SR) |
  
|
|
Don Agostino SalvÏa e altri racconti
di
Benito Marziano
Riflessioni di un lettore casuale
Ha scritto bene il Prof. Sebastiano Burgaretta che il tema dominante del libro Ë, da un lato, líincomunicabilit‡ contrapposta alla possibilit‡ e alla voglia di comunicare e, dallíaltro, il dramma dellíesistenza o meglio il dramma di arrivare alla fine della propria esistenza.
Lo sforzo comunicativo dellíautore, che sembra volere dar voce a Don Agostino, si esaurisce nella scelta di non riportare tra virgolette i dialoghi, quasi a volere spegnere il favellare e relegare tutto nel limite angusto del pensiero. Díaltra parte Don Agostino rifiuta spesso di proferire parola e si limita a pensare quello che avrebbe voluto rispondere al figlio o al nipote Romeo.
Il tema dellíesistenza (certe volte ci sentiamo pi? amici con una persona che si incontra per pochi minuti che con una con la quale passiamo tanto tempo insieme) viene sviluppato attraverso tutta una serie di trovate concettuali immarcescibili che hanno in comune il lento ma inesorabile trascorrere del tempo che dilata le distanze e spegne i ricordi ed il fluire dei giorni che rende inappetibili le costumanze e i desideri della giovinezza ormai lontana:
ìDon Agostino non aveva pi? interesse per la pulizia.î
ìIl mare mi piaceva molto, ormai mi piace di meno, ci vado raramente e non faccio pi? i bagniî (il turista netino in vacanza a Sciacca).
ìAnche noi avevamo dei nipotini prima che andassero lontanoî (Basilio).î
ìIo prima ci andavo a pescareî (Basilio).
ìIl maestro di ballo pensÚ alla sua et‡ come a un ostacolo.
Dal rifiuto delle opportunit‡ offerte dal passato si passa alla ricerca dellíanonimato e dunque dellíimpersonalit‡, e il tutto attraverso la poca affidabilit‡ dei nomi che non designano, anzi, spesso, confondono:
- il figlio di Don Agostino non ha un nome;
- il maestro di ballo, pur chiamandosi Miro Ralli, viene sempre citato come ìil maestro di balloî;
- ìBasilio Basilio. Basilio nome e Basilio cognome. Ridicolo vero? Non si capisce qual Ë il nome e quale il cognome. Uno mi chiama Basilio e io, neanche poter sapere se mi chiama per nome o per cognome.î
- ìÖ responsabile di tutte le sventure del povero Ventura che, anche in questo suo cognome diceva di vedere quasi uno scherno del destino che si divertiva a far fioccare proprio su lui, con quel cognome cosÏ beneaugurate, sventure su sventure.î
E naturalmente líanonimato porta inevitabilmente allíoblio:
ìNessuno seppe pi? niente di Accursia e di Calogero.î
Tuttavia, cíË da dire che il pessimismo che aleggia sui racconti viene mitigato dalla speranza, ovvero dalla fiducia che la propria vita, ormai trascorsa, sia servita a qualcosa o a qualcuno e che possa ancora fungere da sostegno alle generazioni future:
ìA certi alberi ai piedi del tronco spunta un germoglio che comincia a crescere velocemente, mentre quella grande comincia a perdere vigore, sembra che voglia avviarsi a morire, ma non Ë triste per questo, si nutre di meno, perchÈ una parte di nutrimento, la pi? consistente, la d‡ alla giovane piantina, líaiuta a crescere, líha fatta nascere lei.
La pianta vecchia, se gli uomini non fossimo cosÏ insensati da andarle a strappare quella giovane accanto, líaiuterebbe ancora per un poí, forse le darebbe anche dei consigli per farla vivere pi? serena, pi? felice, e poi morrebbe lei e sarebbe felice di farlo per lasciar vivere líaltra.î
I racconti sono caratterizzati dallíuso accentuato dei contrasti o dei gesti contraddittori:
ìLa moglie aveva un volto triste, pur se sorridente.î
ìQuel bambino che dopo la morte della moglie líaveva riconciliato con la vita.î
ìUna convulsione di riso e pianto gli scuoteva il petto.î
(Il commissario)î spense la sigaretta appena accesa e ne accese uníaltra.î
La lingua usata dai personaggi poco colti o quantomeno poco istruiti non Ë líidioma siciliano, sono rare difatti le espressioni dialettali, ma quella che i linguisti chiamano italiano regionale. Si tratta di uní espressione linguistica a met‡ strada tra il dialetto e líitaliano. Essa si basa sulla struttura dellíitaliano standard, ma con elementi lessicali e strutturali tratti dalle corrispondenti forme dialettali. Essa non va confusa con líitaliano popolare parlato dai ceti pi? bassi, cioË da coloro che, avendo per madrelingua il dialetto e poca familiarit‡ con la lingua italiana, cercano di esprimersi italianizzando, e dunque storpiando, la loro parlata in vernacolo:
ìSe lei non si secca ce la racconto.î
ìNon cíË pericolo che si offende nessuno.î
ìTutti gli amici ci (gli) dicevano che aveva ragione.î
ìCi disse ai due uomini.î
Prof. Salvatore Di Pietro
|
| 7) |
Benito Marziano  |
| benito.marziano@virgilio.it |
Località:
Noto |
  
|
|
Considerazioni su Patrie smarrite
di Corrado Stajano, Ed. Garzanti
Comincio a leggere con grande curiosit‡ Patrie smarrite di Corrado Stajano. So che il libro parla di Noto, so che líautore Ë figlio di un notinese. Quanto basta per accendere una buona curiosit‡ in un notinese. Sono ancora alle primissime pagine laddove, attingendo al diario di Domenico Russo, bibliotecario del tempo a Noto, relativamente agli avvenimenti bellici del gennaio del í43 in citt‡, ricorda che dopo il bombardamento del 20 della citt‡ e della stazione e gli allarmi divenuti ormai quotidiani, la paura fra la popolazione aumenta e "i pi? impauriti sono gli abitanti delle case vicine alla Villa." CosÏ leggo e la curiosit‡ diventa altro, si fa ëinteresseí nel senso pi? strettamente etimologico, nel senso, cioË, di ëessere in mezzoí, in mezzo agli avvenimenti, perchÈ io sono l‡, bambino, in una di quelle case "vicine alla Villa", tanto vicina da esserci quasi dentro, e ricordo ancora quella paura e quel terrore, perchÈ la guerra, scrive pi? oltre Stajano, "non si dimentica, anche se vissuta da bambini, soprattutto se vissuta da bambini."
E io non sono ancora riuscito a dimenticarla quella guerra e ancora ricordo quella paura e quel terrore. Paura e terrore che sempre torno a rivivere per ësimpatiaí, direi, ogni volta che sento di bombe che cadono su popolazioni civili e su bambini innocenti.
Pi? leggo e pi? rimango impaniato nella lettura, senza pi? riuscire a chiudere il libro prima di arrivare alla conclusione della prima parte, quella appunto dedicata agli eventi bellici a Noto e in Sicilia e poi agli anni del dopoguerra, quando líautore veniva a trascorrere le sue vacanze a Noto che lui considera come la sua patria "smarrita", una delle sue due patrie, líaltra Ë Cremona, nella quale Ë nato, "smarrita" anche questa, e alla quale Ë dedicata nel libro la seconda parte, che leggo egualmente díun fiato nel pomeriggio dello stesso giorno.
"Smarrite" perchÈ la Noto e la Cremona di oggi, nelle quali ancora torna (e proprio da questi recenti ritorni nascono i ricordi e il conseguente racconto), e non vuole pi? tornare, sembrerebbe di capire, gli appaiono cambiate, e non in meglio.
Il viale Confalonieri di Noto gli "sembra una strada di Cinisello Balsamo, un quartiere di MalagaÖ" A Noto "i giovani non si distinguono dai loro coetanei di altre citt‡ piccole e grandi." A Cremona gli sembra di riconoscere i padri di alcuni suoi amici, sono invece proprio quegli amici. Non ritrova tanti luoghi della sua giovinezza e della sua infanzia, ai quali sono legati tanti piacevoli ricordi, nÈ a Noto nÈ a Cremona. O, almeno, non le ritrova come sono nel suo ricordo.
Non le sente pi? sue, queste patrie, eppure ad entrambe dedica queste pagine che sono un sofferto canto díamore, sofferto perchÈ líamore non gli impedisce di scorgere i loro difetti che poi sono un poí i difetti di questo nostro tempo, delle nostre citt‡ saccheggiate dalla speculazione, omologate da un malinteso senso di modernismo. In gran parte vero. Anche se io non credo, in fondo, che il nostro tempo, le nostre "patrie" siano tanto peggiori dei tempi passati e di quelle "patrie". Credo, piuttosto, che forse siamo un poí annebbiati nel giudicare quei tempi migliori di quelli attuali, chÈ ci fa velo il rimpianto di quellíet‡ che avevamo allora e che non puÚ pi? tornare. Anche a Stajano accade, a me pare, di confondere i tempi con la sua giovinezza e la sua infanzia.
Non mi trovo díaccordo con certo risentimento che il libro ha suscitato in alcuni notinesi che, a sentire delle voci, trovano offensivo quanto vi si dice a proposito di alcune peculiarit‡ del nostro carattere di siciliani: del nostro disinteresse per la cosa pubblica, per esempio, controbilanciato da un soverchio interesse per la privata; e simili affermazioni che non sto qui a riportare, ma che credo per buona parte condivisibili.
Libere tutte le opinioni! Ma veramente riteniamo di essere immuni da tante di quelle pecche che oggi Stajano ci rimprovera, ieri tanti altri, e anche siciliani, ci hanno rimproverato? Io credo che, a non essere affetti da una sorta di scotoma mentale, ci dovremmo rendere conto che se troviamo tanto da lamentarci per come vanno le cose in questa nostra terra, ci deve essere una qualche responsabilit‡ di qualcuno, ma ci deve pur essere, almeno, una nostra corresponsabilit‡. O fanno tutto gli altri e la fatalit‡? Non Ë possibile che se prestassimo un poí díattenzione a come gli altri ci vedono, potremmo conoscerci meglio? Non Ë conoscendosi meglio che ci si puÚ migliorare?
Mi Ë capitato anche di leggere su un giornale locale, in questi giorni, una breve nota sul libro in questione, che sostanzialmente si riduce allíaccusa di anticlericalismo a Stajano per avere scritto: "La Chiesa e le famiglie nobiliari sono dalla met‡ del Settecento le padrone della citt‡."
Ma si dimentica che líoperato della Chiesa in quel tempo, e non soltanto a Noto, Ë gi‡ consegnato alla Storia e Stajano non ci mette niente di suo, ce lo ricorda semplicemente.
Díaltra parte se la Chiesa non sentisse un qualche disagio per il suo operato nel passato, non ci accadrebbe di sentire il Papa chiedere continuamente scusa a destra e a manca.
Pi? realista del papa?
E come si potrebbe non condividere pienamente quanto scrive ancora Stajano: "Si tenta di riabilitare, falsificandolo, un lugubre passato, si mettono sullo stesso piano di giudizio i carnefici e le vittime, i morti per la libert‡ e la giustizia e coloro che hanno agito per soffocarle."
» opera meritoria di quanti, come lui, sostengono ancora il dovere di ricordare, specialmente oggi che tante sirene si fanno avanti (chiss‡ poi quanto disinteressatamente!), per tentare di convincerci a dimenticare, a ëconfondere ogni erbaí, per cui puÚ accadere di sentire (appena pochi giorni or sono perfino dalla pi? alta carica dello Stato), frequenti sollecitazioni a tener conto, nel giudizio storico anche della ëbuona fede dei ragazzi di SalÚí?
Uníinesattezza desidero segnalare (allíautore, se mai dovesse capitargli di leggere queste brevi considerazioni), senza peraltro niente voler togliere a questa sua pregevole fatica, in merito alle vicende relative al tentato sacco di Vendicari. Si ascrive, a questo proposito, a merito dei Verdi aver salvato Vendicari. Non mi pare che siano andati esattamente cosÏ, i fatti. Intanto, se la memoria non mi inganna, i Verdi sono apparsi sulla scena politica pi? tardi di quando si verificarono gli avvenimenti. Almeno i primi, quelli relativi alla vicenda ISAB. Inoltre perchÈ chi si battÈ per salvare la prima volta, appunto, Vendicari, dal tentativo di insediarvi la raffineria ISAB, fu la sezione locale del PCI, rimasta sola e isolata in quella battaglia. Chi scrive ricorda le accuse che ci venivano rivolte (ero militante comunista), le pi? benevoli di essere ëipocriti che dicevamo di lottare per il lavoro e quando il lavoro veniva offerto, spingevamo la gente a rifiutarloí.
Personalmente fui quasi aggredito, trovandomi per acquisti in un negozio, da altri acquirenti, perchÈ difendevo le ragioni dei comunisti contro líinsediamento dellíISAB, a salvaguardia dellíambiente. Rimanemmo isolati nellíastiosa e minacciosa avversione generale; salvo il rinsavimento di molti e il riconoscimento di tanti qualche tempo dopo, quando i cittadini di Marina di Melilli dovettero abbandonare le loro case per líinquinamento della zona dovuto a quella stessa raffineria che da quelle parti aveva trovato di gettare le ancore.
La seconda volta líassalto a Vendicari venne tentato da un gruppo di imprenditori che volevano impiantarvi un grande albergo e, mi pare, anche un villaggio vacanze. E anche questa volta, questi altri pi? che spregiudicati speculatori trovarono orecchie pronte a Noto. E ancora, anche questi si trovarono di fronte a contrastare le loro mire la sezione del PCI, non pi? da sola ora, pronta a difendere quel territorio che ora costituisce la riserva di Vendicari.
Questo per precisione e amor del vero. E senza niente togliere al valore di un libro che, a mio giudizio va letto come un grande atto díamore di Stajano per le sue "patrie", e che mi auguro abbia la diffusione che merita.
Benito Marziano
|
| 6) |
Paolo Randazzo  |
|
Località:
- |
  |
|
 Giovedì, 9 Febbraio 2006 03:58 Host: host139-154.pool80104.interbusiness.it

Simonetta Agnello Hornby, La mennulara, Milano 2002, pp. 209, euro 14.00
CíË un bel romanzo da qualche settimana negli scaffali delle librerie italiane: si tratta de La mennulara di Simonetta Agnello Hornby, palermitana trapiantata a Londra, dove esercita la professione di avvocato in quel di Brixton. Eí una bella storia quella che narra questo romanzo, una storia ambientata in un paese della nostra isola nella prima met‡ del secolo scorso. Diciamo subito perÚ che affermare che si tratta di un bel romanzo non significa sostenere anche che sia un capolavoro: Ë uníopera prima ed Ë, complessivamente, un lavoro di buona fattura anche se non del tutto privo di ingenuit‡. La storia narra retrospettivamente, con intelligente coralit‡ e plurivocit‡ e con una buona capacit‡ di dar vita a personaggi credibili, la vicenda di una donna, Maria Rosaria Inzerillo detta La mennulara (voce dialettale che sta per raccoglitrice di mandorle), che da serva (da criata, in dialetto) rivela, prima e dopo la sua morte, prodigiose doti di amministratrice del patrimonio di terre e ricchezze della famiglia Alfallipe (piccola nobilt‡ di paese, gente inetta e comunque culturalmente inadeguata a reagire alle spinte della societ‡ industriale che sta irresistibilmente affermandosi sulla civilt‡ contadina), nonchÈ una ferma, rigorosa e quasi feroce, capacit‡ di far rispettare la propria dignit‡ di donna. Il tutto intrecciato ad una storia di violenza e di mafia (una mafia allíantica perÚ, ammesso sia mai esistita, fatta díuomini díonore per davveroÖ) e ad una segreta storia díamore vista da una prospettiva femminile, motivi che rendono davvero avvincente la lettura del romanzo. Particolarmente gradevole Ë poi il tono complessivo di leggera ed affettuosa ironia che líautrice non abbandona quasi mai, e giustamente, nel corso dellíintera narrazione. Un tono di diffusa leggerezza che si nota persino nellíimpianto linguistico e sintattico della scrittura che presenta solo un leggero velo regionalistico (nella costruzione dei periodi ad esempio, oppure usando magari al posto di anche), ma non cade mai nel macchiettistico.
Cosa non convince allora? Non convince la continua sequela di allusioni, situazioni e suggestioni provenienti, evidentemente, dalla letteratura siciliana (anche -ne siamo convinti- malgrado la volont‡ stessa dellíautrice) che invadono letteralmente la narrazione (pagina per pagina, se non riga per riga) e rendono il romanzo prima ancora che líopera prima della Agnello Hornby, una delle tante opere della letteratura siciliana: insomma, nihil sub sole novum , purtroppo. E niente nascer‡ di nuovo e artisticamente necessario fino a quando si continuer‡ a pensare alla Sicilia, quella antica e quella díoggi, fondamentalmente come ad uno splendido topos letterario. Ci sembrano magistrali le pagine che narrano dellíamore, segreto, severo, violento e dignitoso, della Mennulara per il suo padroncino; tutto il resto perÚ lo hanno raccontato gi‡ Verga, De Roberto, Sciascia, e poi Brancati, Ercole Patti, Bufalino, oggi Vincenzo Consolo ed ancora tanti altri.
Non Ë vietato scrivere della Sicilia, ci mancherebbe, ed anzi Ë sempre auspicabile che la letteratura si sforzi di usare la storia o le tante storie (nobili o miserrime, maschili o femminili) di questa terra per capire come va il mondo e cosíË líuomo; ma o si trova una chiave che ne renda necessaria la scrittura o si incorre immancabilmente, e persino fatta salva líassoluta onest‡ dellíautore, nel pericolo del gi‡ scritto, gi‡ letto, gi‡ detto. Diversamente, non cíË davvero ironia che tenga.
Paolo Randazzo
|
| 5) |
Paolo Randazzo  |
|
Località:
- |
  |
|
 Giovedì, 9 Febbraio 2006 03:54 Host: host139-154.pool80104.interbusiness.it

Quando le parole diventano odoriÖ
Silvana La Spina
La creata Antonia
Mondadori editore Milano, pp. 250
Eí un racconto di donne, di odori e di cose líultimo romanzo di Silvana La Spina, "La creata Antonia". Eí, ancora una volta, un romanzo di corpi che si fanno odori (odori forti, rancidi, penetranti) e che parlano oltre la parole; di parole che si fanno cose e che, rompendo gli argini di qualsiasi codice linguistico strutturato, rotolano nella vicenda narrata con moto torrenziale (trascinando anche qualche accenno di un gioco linguistico che talvolta sembra compiacersi di sÈ stesso e disturba). Eí anche una storia díamore e di sangue che, a sua volta, di storie ne raccoglie mille altre e tutte, o in gran parte, storie di donne narrate (con voce semplice, quasi da cantastorie) da una donna. Ed Ë, infine, un romanzo storico, non solo nel senso che la storia della Sicilia di fine ë700, e di Catania in particolare, Ë sempre presente come sfondo ricchissimo e vociante di tutta la vicenda, ma anche per quei personaggi che, pur nella miriade di presenze, sono invece assenti. In Sicilia, tra la fine del ë700 e i primi dellíë800, manca assolutamente una borghesia che sia in grado di dirigere sul serio un qualsiasi moto, se non rivoluzionario almeno di rinnovamento. In questo romanzo della scrittrice catanese manca la benchÈ minima presenza di questa classe o di un personaggio che ad essa significativamente possa fare realmente riferimento (e non tanto, ovviamente, dal punto di vista politico, che anzi di giacobini ce ne sono tanti, quanto da quello sociale). Ed Ë giusto che sia cosÏ e non Ë poco. Di conseguenza la vicenda narrata assume subito la fisionomia di una tragedia nera e segreta: la tragedia di uníaristocrazia che Ë ormai alla sua dissoluzione e di un popolo che non trova alcuna via di riscatto. Ecco, la Catania che ci dipinge Silvana La Spina, pur cronologicamente datata a fine ë700, Ë una Catania sostanzialmente barocca e grottesca: e di un barocco tragico e oramai in disfacimento che, non avendo, e non potendo aver assimilato quasi nulla della nuova cultura borghese e illuminista la combatte nei due modi che da sempre sono tipici della reazione nella nostra terra: con la violenza della repressione (anche sorda, segreta, infame) o con il disinteresse nei confronti della voce di quegli uomini di quelle donne che nellíisola hanno, in ogni tempo, voluto davvero rischiare il nuovo (nel romanzo, per esempio, il canonico giacobino De Cosmi e Domenico Tempio, il potente poeta della antica civita catanese) immergendosi in esso oltre la superficialit‡ di una moda che ora viene dalla Francia e che domani magari potrebbe venire dagli States.
E tutto questo viene raccontato da una prospettiva essenzialmente femminile: Ë una donna che racconta la storia della "creata" Antonia e del suo essere violentemente schiacciata tra la sua condizione crudamente servile e le sue idee giacobine "Öla meraviglia della mente umana, che riesce con chiarezza a concepire líingiustizia dei tempi". Idee che uníaltra donna, Madre Crocifissione di Dio, suora appartenente alla nobilissima casata dei principi Roccaromana le ha instillato insegnandole a leggere, come dono materno e come folle e feroce vendetta contro coloro che líavevano costretta, suo malgrado, a monacarsi. Una prospettiva femminile che Ë fondamentale in questo romanzo perchÈ d‡ ad esso piena necessit‡ artistica e la possibilit‡ di trovare una propria originale collocazione nel panorama letterario attuale: la possibilit‡ stessa insomma di essere romanzo in un contesto in cui troppo spesso ci si chiede (e la risposta Ë altrettanto spesso, purtroppo, negativa) se oggi si possano ancora scrivere romanzi.
Paolo Randazzo
|
| 4) |
Benito Marziano |
|
Località:
- |
  |
|
 Giovedì, 9 Febbraio 2006 03:51 Host: host139-154.pool80104.interbusiness.it

Trame del Mediterraneo
Edito dalla Libreria Editrice Urso Ë in libreria un prezioso poemetto (il diminutivo si riferisce soltanto al piccolo formato), Trame del Mediterraneo, ultima fatica poetica di Sebastiano Burgaretta.
Líopera consta di due parti: la prima, che Ë quella che d‡ il titolo al volumetto, che crediamo inedita; la seconda An‡stasis, gi‡ pubblicata, qualche tempo fa, in uníedizione che era una graziosa miniatura fuori commercio.
Il poeta torna, ancora una volta, a darci prova di una poesia colta che parla alle menti senza, tuttavia, nulla togliere alla musicalit‡ e allíeleganza del verso.
Non intendiamo dilungarci a dire di tutti i componimenti che costituiscono la silloge, sia perchÈ non disponiamo dello† spazio sufficiente a poter scrivere quanto si potrebbe sia perchÈ ci piace non ìcontaminareî eccessivamente, con le nostre, le riflessioni del lettore.
Vogliamo qui soltanto anticipare che, con quella pregnante umanit‡ che lo contraddistingue, Burgaretta ci ripropone quel mito di un Mediterraneo che Ë unit‡ geofisica, che Ë unit‡ culturale, che ci comprende; mare che non divide ma unisce, mare che, come scrive Fernand Braudel, ìinizia e finisce dove si estendono líulivo, il fico e il melogranoî.
Ci Ë sembrato di leggere nei versi del Nostro il suo dolore, di fronte alle tante, troppe volte, purtroppo, in cui, in questi ultimi tempi, questo mare Ë diventato bara díacqua e di alghe per troppi ìfigli amari di HamdÓsî, forse perchÈ quel ìvento generoso della vita / che soffia nei cuori dei poetiî (versi che, pensiamo, ogni poeta avrebbe voluto scrivere), non soffia nei cuori di tutti gli uomini (crediamo si debba ammetterlo), e che nei cuori dei molti pare soffi di pi? il vento gelido dellíodio e della morte.
Líultima cosa che vogliamo aggiungere a queste nostre brevi considerazioni Ë che ci troviamo di fronte a versi di grande poesia, che sollecitano profonde riflessioni e arricchiscono lo spirito.††
Benito Marziano
|
| 3) |
Paolo Di Stefano |
|
Località:
- |
  |
|
 Giovedì, 9 Febbraio 2006 03:49 Host: host139-154.pool80104.interbusiness.it

Corrado Stajano, Patrie smarrite
Noto, Cremona e le insensatezze della storia nell'ultimo racconto di Corrado Stajano
da IL CORRIERE DELLA SERA 21 settembre 2001
<Pietroburgo! Ho ancora gli indirizzi, RintraccerÚ cosÏ le voci dei cadaveri>. Sono versi di Osip Mandelístam, il poeta russo morto in un lager staliniano. Appartengono a una poesia, Leningrado, scritta nel dicembre 1930, di cui si ricorda Corrado Stajano, nel suo nuovo libro Patrie smarrite (Garzanti, pagg. 189). E questi due versi potrebbero esserne la migliore epigrafe. Gli "indirizzi" di Stajano sono quelli di Noto e Cremona, suoi luoghi díorigine, i paesaggi dellíanima, le "patrie smarrite" che occupano le due sezioni del libro. Sezioni ben saldate da un filo comune: la dolorosa memoria personale che diventa memoria pubblica, storia del Novecento italiano. Nel ricercare i propri fantasmi (quello paterno in Sicilia, quello materno nella Bassa padana), Stajano ritrova brandelli di storia collettiva. E si accorge che al dolore della ricerca familiare si aggiunge una sorpresa ancora pi? straziante: la consapevolezza di non appartenere nÈ al Sud nÈ al Nord. Di sentirsi un estraneo ovunque. Illudendosi sempre che la vita sia altrove.
Ma andiamo con calma. Nella prima parte líio narrante torna a Noto nel tentativo di vendere le terre del padre, "stoppie, ulivi, mandorli e grotte dellíet‡ del bronzo". Forse le vender‡, forse no. Ma non Ë questo che importa. CiÚ che conta Ë che quel ritorno, tra líagosto e il settembre 1998, scatena nella coscienza dellíautore il desiderio di una ricerca puntuale e quasi ossessiva di tutti i segni e gli indizi lasciati dal passato nei suoi tanti nodi ancora irrisolti. E il fulcro del racconto, attraverso ricordi personali, referti, memoriali, testimonianze dirette, documenti inediti, diventa cosÏ la ricostruzione rigorosa dello sbarco anglo-americano sulle coste orientali dellíisola, nel luglio 1943. Momento cruciale in cui una intera collettivit‡ rivela il proprio carattere, attraverso le parole, i gesti, i silenzi, le collusioni, gli eroismi, le piccole e grandi vilt‡. La narrazione, scandita in forma di diario, ha un montaggio calibratissimo che alterna il racconto presente, con i materiali díarchivio rinvenuti nel corso della quÍte (i diari personali di un canonico e di un bibliotecario, i bollettini di guerra, i notiziari di Radio Londra, le cronache dei giornali, eccetera) e testimonianze ancora pi? antiche consegnate in varie forme alla storia (le fonti archeologiche, i brani di Tucidide dedicati alla battaglia dellíAsinaro tra siracusani, spartani e ateniesi; il testamento di un conte locale del Settecento; altro ancora). Si ha la sensazione, nel procedere del diario, di un presente compresso e vertiginoso, un presente invaso da un passato prossimo e un passato remoto che in fondo gli somigliano. Un procedere pendolare per digressioni e incastri, in cui quando meno te líaspetti possono comparire Vittorini, Goethe, Mann, Borgese, De Roberto, Antonello da Messina per offrire segnali, possibili bagliori tra le ombre del tempo. Ma possono fare da guida anche personaggi meno illustri, come il comandante Mimmo o Michele Luminati, professore di storia del diritto allíUniversit‡ di Zurigo, che attratto dal fascino di Noto combatte da "straniero" la sua battaglia civile contro il degrado del paesaggio e delle coscienze, contro líindifferenza e líambiguit‡ dei cittadini. E poi cíË il paesaggio, le meraviglie e le offese: le spiagge rossastre, i colori, gli odori di gelsomino e di ricotta, il tufo, i profili cadenti delle architetture barocche. Tutto ciÚ che seduce e respinge. Come il carattere eterno dei siciliani ("la nostra razza non Ë degenerata, Ë sempre la stessa", dice il principe Consalvo nei VicerË), pronti a salutare il nemico come un salvatore, cosÏ certi della loro superiorit‡ per diritto di nascita, insofferenti, passivi, sconfitti.
Le brume della Bassa, visitate tra il gennaio e il febbraio 1999, sembrano nascondere, allí"ambiguo figlio di un quasi emigrante che sente nel profondo il conflitto tra il Nord e il Sud e la difficolt‡ di comporre le due anime", un paesaggio interiore speculare. L‡ il capriccio voluttuoso del ghirigoro barocco, qui la linearit‡ geometrica del romanico. L‡ il caos violento, qui il placido Po e la pianura cantata da Virgilio. L‡ una fantasia esasperata e irrazionale, qui ordine e concretezza illuminista. Ma non saranno due facce inconciliabili della stessa, italica, medaglia? Patrie perdute dal narratore o piuttosto patrie che si sono smarrite da sÈ? La parabola di Farinacci, il ras di Cremona sotto il fascismo, Ë esemplare. Nel vivisezionare (anche qui attraverso un immenso materiale documentario edito e inedito, fotografico, epistolare) la sua protervia, la sua resistibile ascesa e la sua caduta, Stajano cerca in realt‡ di interpretare come sia stato possibile che una popolazione di antica cultura e di tradizioni democratiche abbia consentito e anzi favorito, con divisioni, furbizie, losche complicit‡, líimporsi dellíuomo nero, accettando di farsi cavia della violenza. A dare risposte e a formulare infinite altre domande, concorrono, come nella prima parte, il saggista, lo storico accanito e soprattutto lo scrittore civile alle prese con un bricolage di informazioni, note, carte, ritagli, ricordi intimi, ma capace di servirsene per dipingere tutte le sfumature di una tragedia non privata bensÏ collettiva, non siciliana o cremonese bensÏ italiana. E lo fa con uno stile pacato spesso acceso da flash improvvisi del pensiero, da visioni, da accostamenti imprevisti, da accelerazioni del ritmo, da fughe in avanti e ritorni, che lasciano in sospeso e poi riprendono personaggi maggiori e minori (memorabile il ritratto della coppia Ausenda-Amigoni, antifascisti pronti al tradimento).
Ritorno: quanto dolore nei ricordi che affiorano, contro ogni volont‡, nel ritorno alla casa dellíinfanzia e dellíadolescenza, la casa materna, con i suoi oggetti da svendere, con i mobili da imballare, le pareti da liberare, le vecchie carte salvate dallo sfaldarsi lento della famiglia. Quanto dolore nel ritrovare per caso, dentro una cassaforte, la pistola díordinanza del padre. Epifanie, tracce di una felicit‡ perduta, "voci di cadaveri", piccole coincidenze privatissime, che trovano un loro senso solo nelle insensatezze della nostra Storia. Che hanno ora trovato, con Patrie smarrite, il loro grande romanzo.
Paolo Di Stefano
|
| 2) |
Sonia Alia |
|
Località:
Avola (SR) |
  |
|
 Mercoledì, 8 Febbraio 2006 20:04 Host: host174-156.pool80104.interbusiness.it

Lilia Urso, Lacrime eroiche ñ lacrime umane , 2004, 16?, pp. 70, Euro 5,00
Il testo, che appartiene alla collana "La laurea in tasca", rivisita la concezione di alcuni grandissimi pensatori dell'antico mondo greco riguardo alla sofferenza umana.
Partendo da Omero, e quindi dallíorigine della storia del pensiero occidentale, vengono evidenziati i passaggi che fanno esprimere le concezioni, riguardo alla tematica, dalla originaria forma di un linguaggio poetico sempre sublime ma sicuramente pi? immediato, a quella pi? elaborata e razionale della dissertazione filosofica.
Líexcursus dellíautrice, tra i percorsi scelti per illustrare le idee che gli antichi Greci elaborarono sul dolore umano, abbraccia, infatti, i secoli compresi tra líVIII e il I secolo A .C. e le prime venti pagine del libro analizzano con originalit‡ il rapporto che i grandi eroi dellíIliade e dellíOdissea hanno con le loro lacrime.
Sempre esse sono versate inscindibilmente dal rapporto con il divino.
Sempre esse sono versate legandole ad un agire che, pur se influenzato da debolezze tipicamente umane, non puÚ prescindere da precisi riferimenti riguardo al volere degli dei, al libero arbitrio, alla colpa, al male contrapposto al bene che, per quegli eroi, in ultima analisi, era ciÚ che generava il dolore umano.
Nel II capitolo del suo lavoro, líautrice evidenzia come la stessa concezione viene espressa anche dal poeta tragico Eschilo che presenta nelle sue opere personaggi profondamente tragici poichÈ nonostante i loro sforzi e i rimedi escogitati dal proprio intelletto vengono sopraffatti dal male e dal dolore che non si possono eliminare perchÈ entrambi naturali e non nettamente separabili.
Il male trae la sua origine dal divino e quindi líuomo Ë al contempo colpevole nel male (perchÈ spesso líaccecamento lo induce in errore ), ma anche vittima di uno sventurato e doloroso destino (perchÈ egli Ë sotto líinfluenza di forze superiori che lo inducono, suo malgrado, in errore).
Il III capitolo del libro analizza il pensiero filosofico greco dal IV al I secolo A .C, (Pitagora, Eraclito, Empedocle, Socrate, Platone, Aristotele, gli Stoici, Epicuro, Plotino) riguardo alle domande e alle risposte che esso formula circa il dolore, approdando, anche se in modi e prospettive diversi, alla conclusione che la sofferenza Ë per líuomo inevitabile ma che con risoluzioni differenti, (a seconda della corrente di pensiero del filosofo in oggetto), essa puÚ essere dominata dallíuomo con líesercizio della virt?, o della imperturbabilit‡, o dellíascesi o della razionalit‡, ecc...
La lettura del libro ìLacrime eroiche, lacrime umaneî permette, al di fuori delle aule di un liceo o di uníuniversit‡, di rincontrare i pensatori che hanno originato il pensiero occidentale per riflettere, con la maturit‡ che líet‡ adulta ci dona e líangoscia che i tragici eventi contemporanei ci procurano, circa il comune destino di noi esseri umani che, soggetti tutti al dolore e allíincertezza, dovremmo vicendevolmente essere uniti dallíantico sentimento di ìpietasî che gli antichi riuscivano a provare.
SONIA ALIA
|
| 1) |
Simona Ruta |
|
Località:
Modica (Rg) |
  |
|
 Martedì, 7 Febbraio 2006 04:00 Host: host191-154.pool80104.interbusiness.it

Gabriel Garcia Marquez, Cent'anni di solitudine
Sin dalle prime pagine avevo capito che ïCentïanni di solitudineï non sarebbe stata una lettura semplice.
Se avessi peccato di concentrazione, infatti, avrei rischiato in molti punti di perdere il filo della trama.
Causa di ciÚ i numerosi flashback che rimandano i personaggi a tempi remoti, in cui si incontrano figure secondarie ma non meno importanti dei protagonisti principali.
Cercare di individuare un solo personaggio ïprincipaleï risulta impossibile, a mio avviso. Tutti coloro di cui Garcia Marquez narra nel suo romanzo giocano un ruolo fondamentale nellïevolversi della storia.
La vita di tutti ruota attorno a un villaggio, Macondo, attorno allïinerzia del tempo che passa inesorabilmente, attorno alla morte nella pi? completa solitudine.
PerchÈ in effetti, e sembra un paradosso, tutti muoiono in solitudine, nonostante casa Buendia fosse sempre piena di gente, parenti e non.
Tutti arrivano alla fine dei loro giorni con rassegnazione, insoddisfazione e solitudine ïmoraleï.
Per un gioco di omonimia ïereditariaï, tutti i personaggi maschili portano il nome di JosË Arcadio e Aureliano cosicchÈ spesso si corre il rischio di non capire di chi si sta leggendo. Tuttavia ognuno ha delle caratteristiche distintive tali che lo smarrimento svanisce in un attimo.
Personalmente ho ammirato la figura di Ursula, matrona della grande casa dei Buendia. Forte, energica, cieca da anni ma talmente ostinata da aver imparato ad orientarsi e a ïvedereï, utilizzando gli altri quattro sensi riuscendo a nascondere a tutti il suo handicap. Indimenticabile la frase con cui, insieme alle altre donne del villaggio, nel bel mezzo della guerra, sfida i militari asserendo che nonostante i vari titoli bellici e le medaglie, in qualit‡ di madri avrebbero avuto sempre il diritto di sculacciarli!
Mi ha commosso anche la figura di Arcadio Secondo. Lontano da qualsiasi esempio di saggezza e rettitudine, era comunque di animo buono e generoso. Era dedito al puro divertimento, sempre al centro di feste e gare gastronomiche, fu per un periodo uno degli uomini pi? benestanti del villaggio grazie al suo allevamento di bestiame miracolosamente ïprosperoï.
Adultero, divideva la sua vita tra la castissima e religiosissima moglie Fernanda e lïamante Petra, che amava. Purtroppo ***** tutto durante lïalluvione che mise in ginocchio il villaggio, ma non smise mai di provvedere alle due donne.
Quando si rese conto che la sua fine era vicina, a differenza dei suoi avi che si chiudevano in se stessi aspettando la morte, diede tutto se stesso, sopportando il dolore fisico, per mettere da parte il denaro necessario a mantenere la figlia avuta da Fernanda, Amaranta Ursula, in una prestigiosa scuola di Bruxelles come le aveva promesso.
Ci riuscÏ.
Mi Ë entrata† talmente dentro la bont‡ del suo cuore che mi sono ritrovata a leggere dellïaddio alla figlia in partenza alla stazione con le lacrime agli occhi.
Simona Ruta
Modica 12-12-2005
|